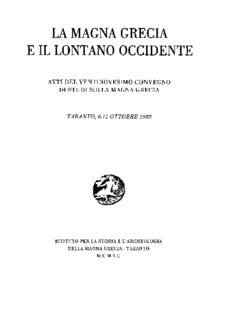Table Of ContentLA MAGNA GRECIA
E IL LONTANO OCCIDENTE
ATTI DEL VENTINOVESIMO CONVEGNO
DI STUDI SULLA MAGNA GRECIA
TARANTO, 6-11 OTTOBRE 1989
ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA
DELLA MAGNA GRECIA-TARANTO
MCMXC
Questo volume che raccoglie gli Atti del XXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia
svoltosi a Taranto dal 6 all'Il ottobre 1989, è pubblicato dall'Istituto per la Storia e l'Ar
cheologia della Magna Grecia, con i contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Ente Provinciale del Turismo di Taranto_
La redazione è stata curata da Attilio Stazio con la collaborazione di Stefania Ceccoli e
Rosa Vitale_
PRESENTAZIONE
Per la loro situazione geografica, per la portuosità e le risorse
naturali delle loro zone costiere, l'Italia e la Sicilia hanno assunto,
dai primi momenti dell'esplorazione navale del Mediterraneo occi
dentale, una indispensabile funzione, oltre che di statio e tràmite,
di vera e propria base d'operazione, vicaria di quella d'origine dei
navigatori: in altri termini, una sistematica ricognizione delle ter
rae incognitae ad ovest della Sardegna esigeva ben più che la fon
dazione di emporii e la frequentazione di porti iapigi o enotrii, si
cani o siculi. Specialmente dacché sulle rotte verso l'Occidente si
erano riversati navigatori anatolici e siriani e sul canale di Sicilia
incombeva Cartagine con le sue aspirazioni all'egemonia mercan
tile nei mari occidentali, le poleis trafficanti si erano convinte della
necessità di essere presenti nell'Italia meridionale e in Sicilia con
colonie saldamente fissate, destinate a divenire poleis ma legate
alle rispettive metropoleis dali 'infrangibile vincolo delle comuni
tradizioni, e promotrici di ulteriori esplorazioni. Spettò quindi alle
poleis italiote e siceliote intessere costanti relazioni commerciali
con grandi emporii della penisola Iberica e affrontare in prima li
nea, e non solo sul piano commerciale, la concorrenza di Cartagine
e delle città dei Tirreni. È sintomatico di questa funzione storica
delle colonie greche del versante tirrenico d'Italia il fatto che in
quell'area cercarono rifugio dalla servitù ad un tiranno o al re per
siano i cittadini politicamente più maturi delle due poleis d 'Asia
che si erano distinte per intraprendenza nella navigazione ocea
nica: da Samo, donde verso la metà del secolo VII a. C. era partita,
al comando di Kolaios, la prima spedizione greca nell'Oceano, rive-
latrice dell'emporio iberico di Tartesso, e da Focea, i cui celeri na
vigli avevano tratto il maggior frutto da quella scoperta samia: i
Focei trovando una nuova sede a Velia, poco dopo il 540 a. C., i Sa
mii a Dicearchia qualche anno dopo. Corrispondente di Samo per i
traffici con l'Occidente era allora Crotone, ove il maggior lume di
quel tempo, Pitagora, cercò la libertà tolta alla sua patria da Poli
crate; e l'altra grande polis commerciante d'Asia, Mileto, aveva
come suo tnimite con l'Occidente la rivale di Crotone, Sibari.
Era dunque necessario che il nostro orizzonte di studio inclu
desse il 'Far W est' mediterraneo, verso cui prima i Rodii fondatori
di Partenope nel più sicuro golfo tirrenico aperto verso occidente,
poi i Focei di Massalia hanno cominciato a dilatare l'area di espan
sione commerciale e civile della grecità; e venisse approfondita la
conoscenza di quel settore ove il mitico termine Eracleo era il se
gno di una potente attrazione (oltre che di avventurosi percorsi del
l'e tà micenea}, e sollecitato un contatto con gli studiosi spagnoli e
portoghesi non meno intenso di quello che è in atto con gli studiosi
francesi grazie al Centre ]ean Bérard. L 'opera degli archeologi ibe
rici, partita dalla città che ebbe il significativo nome di Emp6rion
(Ampurias), ha già notevolmente arricchito il quadro delineato
circa cinquant'anni or sono da Antonio Garda y Bellido nella sua
classica opera Hispania Graeca; e ci invita inoltre a non trascurare
l'incontro dei Greci con quegli Iberi a cui volgevano lo sguardo
Antioco e Tucidide nella ricerca delle origini sicane. Il nostro è
d'altronde un desiderio che coincide con quello dei nostri colleghi
iberici, sensibili sempre al gran richiamo dell'unitaria tradizione
classica, quale risuona suggestivo nella poesia di un lspano d'Ame
rica, Rubén Dario:
Aqu{, junto al mar latino,
digo la verdad:
siento en roca, aceite y vino
yo mi antigiiedad.
GIOVANNI PucuEsE CARRATELLI
RELAZIONE INTRODUTTIVA
A. GRILLI
IL MITO DELL'ESTREMO OCCIDENTE
NELLA LETTERATURA GRECA
Qual è stato l" animus' con cui i Greci antichi hanno guardato
verso l'estremo Occidente? Non occorre dire che non possiamo
aspettarci una risposta esplicita, che non rientrerebbe, del resto,
nella mentalità né greca né romana. Se ci è possibile riconoscerlo,
lo è attraverso, prima di tutto, una serie di considerazioni generali
e solo dopo un esame paziente dei documenti letterari.
La terra greca è stata terra di mercanti, a cominciare dai Mi
cenei, che seppero arrivare sul Medio Danubio e nell'alto Adriatico
per i loro scambi, in cerca tra l'altro di ambra.
Ma allo stesso tempo i Greci erano gente in cui era profonda
mente radicato un senso di 'curiositas ', dote o difetto a seconda di
come si vede la cosa: per esempio, la 'curiositas' riuscì irritante
per i Romani e fece sì che essi parlassero spesso e volentieri, con
un certo disprezzo, di Graeculi. Per la nostra questione è diverso,
perché anche questa 'curiositas' spinse Micenei ed Elleni, popoli
di navigatori, a muoversi su disparate rotte, naturalmente secondo
la logica delle rotte più agevoli, sopra tutto alla ricerca di quelle
più redditizie.
Ora, soffermiamoci a osservare su una carta del Mediterraneo
la collocazione geografica della Grecia tra Adriatico-Ionio da una
parte ed Egeo dall'altra: la penisola si protende in mare nella metà
orientale del bacino mediterraneo; ma, contrariamente a quanto
viene quasi spontaneo di pensare all'osservazione, il continente
greco non è più vicino all'Oriente che all'Occidente. Più agevole
da raggiungere senz' altro il primo, con tutti i ponti di isole che
collegano la Grecia con l'Anatolia, più lontano no, sopra tutto se si
tien presente quanto ricco d'insediamenti micenei sia stato il Pelo
ponneso. Per fare un esempio concreto, da Pilo la più antica Espe
ria, 'la terra d'Occidente', cioè l'Italia, era meno distante che non
Mileto, Rodi o Cipro. È quindi nell'ordine storico delle cose che il
progredire delle ricerche archeologiche e delle loro interpretazioni
abbia indicato siti frequentati dai Micenei dalle isole attorno alla
Sicilia su su fino alla foce dell'Arno.
Nonostante qualche scetticismo attuale, rimane bella e per
molti aspetti soddisfacente la vecchia immagine che dobbiamo a
Edward Schwartz: i marinai ionici che da tempo immemorabile si
trovavano nelle lunghe serate invernali nella Àc€rx.YJ della loro città
a scambiarsi le esperienze, volontarie o involontarie, delle loro na
vigazioni, mescolandovi tutto quello di fantastico e sgomento che si
è sempre unito al vero e al vissuto per chi si sia avventurato in
mondi sconosciuti e tra genti di altri costumi. In fin dei conti, l'i
dea del 9<XUf.l<XCJ'tOV è profonda caratteristica dei Greci tanto da es
sere quasi naturale che esso abbia impregnato i loro occhi di una
capacità di visione quale per nessun altro popolo antico abbiamo
prove o ci è stato tramandato: bisognerà arrivare alle storie meravi
gliose dei monaci irlandesi per trovare qualche cosa di simile, ma
in scritti come la Navigatio sancti Brendani c'è sempre l'incontro
col sovrumano; mentre ciò che è davvero mirabile in tutta la tradi
zione greca, letteraria e non, almeno fino a quando cede davanti al
misticismo orientale, è, anche nei confronti dell'estremo Occidente,
il pieno sforzo di razionalizzazione. Si potrebbe dire che, mentre
ogni visione fantastica nel mondo celtico vede qualche cosa che è
al di là della realtà umana, ogni visione nel mondo greco, per
quanto fantastica, ha sempre un vincolo ravvisabile con la realtà,
anche se nebulosa o alterata.
È ovvio che un simile modo di reagire a esperienze nuove
prende subito i colori del f.lU9oç, proprio per la caratteristica del
mito greco di rappresentare la storia prima della storia: questo non
soltanto nella poesia. Se posso confortare quanto dico con l' esem-
lO
pio di una vicenda che si svolge tra Nord e Occidente, il mito degli
Argonauti in viaggio dall'Adriatico a un Erìdano davvero fiume del
(l.G9oç e di qui al Rodano è cantato da Apollonio Rodio con una
particolare lucidità; ma noi sappiamo che questa geografia non è
inventata, ha una sua validità, perché nasce da remote notizie che
attraverso Timeo sono giunte fino ai Problemi pseudoaristotelici: si
tratta delle vie dell'ambra che, per i Greci, al di là dell'lstro si per
dono nel mistero di terre ignote.
Per quanto riguarda il mondo dell'estremo occidente non ab
biamo un racconto che, sotto il manto di notizie lasciate nell'inde
terminabile, riveli in modo altrettanto trasparente una realtà geo
grafica e fattuale.
Ma non possiamo dimenticare l'Odissea. È Odisseo, un eroe
mediterraneo dal nome anellenico, signore di ltaca, una delle più
piccole tra le Isole lonie, di fronte all'Italia, che nella tradizione
della più alta poesia epica viene presentato come l'involontario sco
pritore delle terre occidentali, ovunque ognuna di tali esperienze
possa trovare una collocazione incontrovertibile nello spazio della
geografia moderna. Voglio dire che l' Odissea va spogliata da
quante meschinità razionali vi hanno incrostato i commentatori an
tichi e, spesso, le invenzioni dei moderni. Pensiamo al fiabesco ri
torno di Odisseo da Scheria, l'isola dei Feaci, e al sonno magico
per cui l'eroe rientra in patria senza aver coscienza di luoghi e di
stanze: tutto questo è stupenda fantasia del poeta che con un tratto
di meraviglioso (ancora il 9ocu(l.OCO"tov) ottiene di poterei introdurre
nell'ultimo atto della sua tetralogia. Si vorrà dare molto credito a
quanto i grammatici antichi sostenevano? Secondo loro la terra dei
Feaci è Corcira/Corfù, che dista da Itaca non più di 110 miglia ma
rine ed è in un'area che già le rotte micenee battevano regolar
mente: a parziale scusante di quei grammatici si potrà dire che al
lora non si sapeva quello che noi sappiamo.
Non si può pretendere che l'Odissea abbia il candore dei rac
conti primitivi non manipolati da poeti e sopra tutto che non pre
senti sottostrati e sovrastrati: è doveroso vedere in Omero non una
11
cronaca di viaggio, ma la 'summa' di tutta una serie di esperienze,
di esplorazioni, di contatti commerciali del passato, che in Odisseo
viene eroizzata. Ma al tempo stesso è d'evidenza palmare come il
poema sia il poema dell'Ovest. Il momento in cui scatta l'avventura
è il momento in cui Ulisse perde il controllo della situazione per
l'intervenire di «venti funesti» (Od. 9,82), che - come tutti gli av
venimenti atmosferici - non sono sotto il dominio dei mortali. Il
vento impetuoso che non gli lascia doppiare il Capo Malea, conti
nuando a soffiare lo spinge verso Sud-Ovest per nove giorni (lvvrj
!J.CXp) e nove notti. Nove giorni e nove notti, dunque in una dispe
rata navigazione alla deriva che, se vogliamo ammettere un minimo
di coerenza nel poeta, butta Odisseo sulle coste della Libya: una
traversata che getta l'eroe fuori del reale, al di là di uno dei grandi
«vuoti» del Mediterraneo. Ancora Plinio il Vecchio nel IV libro
della sua Naturalis Historia (4,20,60), seguendo Agrippa, misura il
percorso da capo Malea alla Cirenaica con un tragitto attraverso
Cerigo, Cerigotto e Creta, non per mare aperto, che sarebbe più di
360 Km.
Anche se l'identificazione delle tappe del viaggio odissiaco
non ci riguarda, è chiaro da tutto il contesto che le successive navi
gazioni sono in direzione più o meno Ovest, altrimenti Odisseo ver
rebbe inevitabilmente a ricadere nei mari del Mediterraneo orien
tale, che i Greci conoscevano da lungo tempo e in cui si sarebbe
dovuto scontrare con i Fenici, che nell'Odissea sono ancora nelle
loro sedi originarie e né Omero né il suo eroe conoscono un'espan
sione fenicia nei mari d'Occidente.
È opinione comune che gli avvenimenti dell'Odissea si svol
gano nell'ambito del Tirreno, un altro dei grandi «vuoti» del Me
diterraneo, tra Corsica, Sardegna, Sicilia e la costa italica, anche se
questo fa difficoltà con quanto si dice della dimora di Circe che è
«dove ci sono la casa e le danze d'Aurora che nasce di buon mat
tino e la levata del Sole» (12,3-4), così come quando oltre le Sirene
uno dei due cammini annunciati da Circe è quello per le IH<Xyx-rcxt,
le Simplegadi, da dove passò solo la nave Argo, 'Apyw 7tCXO'L(J.i-
12
Description:Peninsular de Historia Antiqua, II, Univ. Santiago de Composte1a I988, pp. III ss. 25 R. PANVINI, in Quaderni /st. Arch. Univ. Messina 3 (I986-87), p. I07. 26 B. B. SHEFTON, Rhodischen bronzekannen, Mainz am Rhein 1979, p. 5 ss.; Greeks and Greek lmports in the South of the lberian Peninsula,