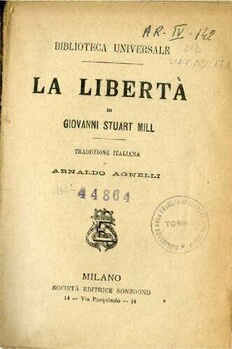Table Of ContentBIBLIOTECAU NIVEHS.\LI~
)
LA LIBERTA"
DI
GIOVANSNTIU ARMTI LL
--
TRADUZIONE1 TALI.ANA
.A.:QN ALDO .AGNELL2
MILANO
SOC'lr.TÀ En!TRICE S0N7nn~o
14 - Vin Pnqquirolo - H •
l'llOl'Hll,;'J \ 1,1·:rrt:ll \III,\ UJ~EH\".\T\
l[ilun:,, 1911.
•
GIOVANSNTIU ARMTI LL
Giovanni Stuart Mili nacque a Londra nel 18o6.
Il padre di lui, Giacomo Mili, storico ed economista
di qualche valore, scolaro di Bentham ed intimo
amico di Ricardo, sottopose il suo promettente in
geg110 nel un sistema di educazione che ne sviluppò
assai per tempo le forze: giovinetto ancora, lo
Stuart Mili conosceva perfettamente il latino, il weco,
la storia, specialmente antica: dopo alcuni mes, pas
sati nel 1810 in Francia, ritornò in patria, studiò li
losofia e giurisprudenza, e ottenne, sotto la dipen
denza del padre, un posto negli u!]1ci amministrativi
della Compagnia delle Indie, che èonservò dal 1813
al 1~58. Fu, per qualche anno, membro della Camera
dei Comuni, mandatovi dagli elettori di Westmin
ster. Ritiratosi negli ultimi anni ad Avignone in
Francia, vi moriva nel 1873.
L'ingegno dello Stuart Mili si esplicò nelle forme
più svariate: scrisse di filosofia seguendo e modifi
1
cando dapprima l'utilitarismo cti Geremia Bentham,
poi subendo l'influenza del positivismo di Augusto
Comte, col quale egli ru in corrispondenza ed ami
cizia; pubblicò un Sistema di logica; patrocinò arden
temente quelle riforme agrarie d'Irlanda, di cui già
si faceva sentire la necessità.
Ma il maggior titolo di gloria a cui il nome di lui
si lega sono, senza dubbio, i suoi scritti in materia
di economia politica e di diritto pubblico. Seguace,
in economia, della scuola classica, quale in Inghil
terra l'avevano costituita Adamo Smitb, l\1.altbu.s
Ricardo, egli si occupò nondJmeno con amore d11
questioni operaje, accettando e svolgendo a questo
proposito delle idee prettamente moderne; coi suoi
lavori poi sul Governo rappresent,,tivo, sulla Sogg,·
,ione delle donne e con questo saggio di cui presen
tiamo una traduzione al lettore italiano, egli prese
posto fra i primi pubblicisti d'Europa.
Propugnò la rappresentanza delle minoranze; fu
un apostolo intelligente ed appassionato di quel com-
4 .,,. GIOVANNI STUART MILL.
plesso d1 riforme che si comprendono sotto il nome
di • Emancipazione della donna ,, : sopratutto, col
presente lavoro sulla Ubertà, si pose in una decisa
posizione di combattimento contro quelle tendenze
ad allargare le funzioni del potere sociale, che, por
tato inevitabile di nuovi tempi e di nuove condizioni,
debbono essere per altro energicamente frenate in
ciò che hanno d1 eccessivo e di tirannico.
Questo libro è uscito per la prima volta a Londra
nel 1859. Eppure, esso non è invecchiato, non ha per
duto d'interesse nè di sapore d'attualità; anzi, il giu
dizio del tempo ha dato alle idee che vi sono svolte
una cosi incontestata ragione, che la loro importanza
e la loro autorevolezza ne è cresciuta d'assai.
Non ho creduto bene di premettere al libro un
cosi detto proemio critico. Davanti ad una mente
come quella dello Stuart Mili, davanti ad un lavoro
come questo, un ~iudizio sarebbe facilmente avven
tato: è bene che il lettore se lo formi da sè, secondo
i suoi convincimenti e le sue tendenze.
Certo è che, se il libro ottenesse in Italia quel suc
cesso e quella di!fusione che pur troppo non gli me
riterà la povera veste ch'io gli bo saputo dare, esso
potrebbe fare qualche po' di bene. La dimostrazione
limpida, pacata, serena che la libertà non è soltanto un
astratto diritto teorico, ma anche una condizione im·
prescindibile- di saldo progresso civile, potrebbe con
tribuire a di!fondere nel nostro paese quel senso della
libertà di cui, in tante occasioni, si constata malinconi•
ca mente l'assenza. Oso raccomandare in modo specia
le, a chi segue ciecamente l'impulso di certi pregiudizt
e di ceni timori, quel piccolo capolavoro che è il ca
pitolo secondo, sulla libertà di pensiero e di parola.
Se, ad ogni modo, l'intento di sgombrar dalle menti
qualche falsa opinione, d'inse~nare a qualcuno un po'
di tolleranza in fatto di relig10ne e d1 politica, fosse,
anche in minima parte, raggiunto, io sarei esuberan•
temente compensato del mio modesto lavoro.
Geunajo, 189J.
ARNALDO AGNELLI.
11 gran principio, !I principio dominante,
a cui mettono capo tutti gli argomenti
esposti in queste pagin~, è l'impòrtanza es•
scntiale cd assoluta dello sviluppo umano
in tutta la ricchezza della sua varietà.
GUGLIELMO 01 Hu>iaOLDT. - Dtlla
sfera d'a::.iouc I dii dovtJri dii gov1ruo.
lo dedico questo volume alla cara e lagrimata
memoria di colei che fu l'inspiratrice, e in parte l'au
trice, di quanto v'ha di meglio ne' miei lavori: alla
memoria dell'amica e della sposa, il cui fervido senso
del vero e del giusto fu il mio più vivo incoraggia
mento - la cui approvazione fu la mia ricompensa
più al.ta.
Come tutto quello ch'io ho scritto da molti anni,
questo volume è tanto opera sua '-{Uanto mia, ma
il libro, quale ora si presenta, non ha goduto se non
ìn grado molto insu!fìciente il vantaggio inestimabile
d'esser riveduto da lei: qualcuna delle parti pii.i im
portanti era riservata ad un secondo e più accurato
esame, che ormai non è destinata a ricevere mai pii.i.
S'io sapessi interpretare la metà soltanto dei grandi
pensieri, dei nobili sentimenti che sono con essa se
polti, il mondo ne coglierebbe un frutto ben mag
giore che da tutto quello ch'io posso scrivere, senza
l'inspirazione e l'assistenza della sua impareggiabile
s 1ggezza.
G. STIJART 1\1,c.L.
,
Il
•
'
l
I/
LA LIBERTÀ
CAPITOLO PRIMO
INTl{ODUZIONE,
li soggelto di questo lavoro non è il così dello libero
arbitrio tanto infelicemente opposto a quella che mal si
chiama dottrina di necessità filosofica, ma bensì la libertà
sociale o civile, cioè la natura e i limiti del potere che la
Società può le~ittimamente esercitare sull'individuo: que
stione posta d1 rado e forse non discussa mai in termini gc-,
nerali, ma che colla sua presenza inavvertita ha una profonda
influenza sulle controversie pratiche del secolo e probabil
mente sarà benlosto riconosciuta come la questione vitale
dell'avvenire. Questa questione è si lungi dall'esser nuo,,a,
che, in un certo senso, es:m ha diviso l'umanità, fin quasi
dai tempi più remoti. Ma essa si presenta sotto nuove forme
nell'epoca di progresso in cui ora sono entrati i gruppi più
civili della SJ;lecieu mana, ed è necessario tra!tnrln in modo
diverso e piu fondamentale.
La lotta tra libertà ed autorità è la nota caratteristica di
quelle epoche storiche che ci divengono a prima giunta fami
liari nelle storie greca, romana ed mglese. Ma, in altri tempi,
la lotta era tra i sudditi, o qualche classe di sudditi, e il go
verno: per libertà, s'intendeva la protezione contro la tiran
nia dei governanti politici. Questi (tranne che in qualche città
democratica di Grecia) sembravano in una posizione necessa
riamente nemica nl popolo da essi governato, In altri tempi il
governo era in generale tenuto da un uomo o da una tribù o
8 LA LIBERTÀ
Ja una casta che derìvàva la propria autorità dal diritto
di conquista o dl successione, - in nessun caso dal
consenso dei governati - e di cui gli uomini non osa
vano fors'anche non desideravano di porre in dubbio la
supr~mazia, pure prendendo qualche precauzione contro
l'esercizio oppressivo di essa. Si considerava allora il po
tere dei governanti come necessario, ma anche come alta
mente pericoloso; come un'arma ch'essi avrebbero tentato
di usare tanto contro i loro sudditi Quanto contro i nemici
esterni. Per 'impedire che i membri pfù deboli della collet
tività fossero divorati da innumerevoU avoltoi, era indi
:;pcnsnbile che un uccello da rapina più forte degli altri
rosse incaricato di frenare questi animali voraci; ma poichè
il re degli avolloi non sarebbe stato meno disposto a di
vorare il greggio di nessuna delle arpie minori, così biso
gnava tenersi sempre sulla difensiva contro il suo becco e
contro i suoi artigli.
Per questo, scopo dei 1;1atriotie ra di assegnare dei limili
al potere che i governanti dovessero esercitare sulla collet
tiv1Là; questo essi intendevano per libertà. Vi si tendeva
in due modi; anzitutto, coli ottenere il riconoscimento di
certe immunità, dette libertiì o diritti politici, che, secondo
l'opinione generale, il ç-overno non poteva impunemente
violare sen:za 1nancar dJ parola e senza correret ben n. ra
gione, il rischio di una resistenza particolare o di una ri
bellione generale. Un altro espediente, piti recente in ge
nerale, era lo stabilire dei freni costituzionali, per mezzo
dei quali il consenso della comunità o di un corpo qua
lunque, supposto rappresentante degl'interessi di questa,
era condizione necessaria di qualcuno fra gli atti impor
tanti di governo. Nella maggior parte dei paesi d'Europa,
11g overno è stato costretto, più o meno , a sottomettersi
alla prima di queste restrizioni. Non avvenne lo stesso per
la seconda ; e 11 potervi giungere o, quando fino a un certo
punto già la si possedeva, il giungervi più completamente,
divenne dappertutto principal fine degli amici di libertà. E
fincbè l'umanità si contentò di combattere un nemico col
l'altro, e d'esser governata da un padrone , a condizione
d'esser piti o meno efficacemente garantita contro la sua
tirannia, i desideri dei liberali non si elevarono pii1 alto.
Pure, nel cammino delle cose umane, venne un momento
in cui gli uomini cessarono di considerare come natural
mente necessario cbe i loro governanti costituissero un
potere indipendente, d'un interesse opposto al loro. Parve
ad essi assai meglio che i vari magistrati dello Stato fos
sero loro rappresentanti o delegati, revocabili a loro pia
cimento. Sembrò che solamente a questo modo l'umanità
potesse avere la completa assicurazione che non.si sarebbe
mai, a suo danno, abusato dei poteri del governo. A poco
CAPITOLO PRIMO, 9
a poco, questo nuovo bisogno di governanti eletti v1 e tem
poranei divenne l'obbietto principale delle agitazioni del
partito popolare, dovunque ce n'era uno, e allora si abban
donarono quasi dappertutto gll sforzi precedenti per limi
tare il potere del governant.i. Poichè in questa lotta si
trattava di far emanare il potere di governo dalla scelta
periodica dei governati, alcu11i cominciarono a credere che
si era attribuita troppa importanza all'idea di li miL are il
potere stesso. Questo (a ciò che pareva) era un vantaggio
contro quei governanti i cui interessi erano abitualmente
opp~sti a quelli ~el popolo; ma ciò che allora occorreva, era
che 1 governanti fossero una cosa sola col popolo, che il
loro interesse e la loro volontà fossero l'interesse e la vo
lontà della nazione. La nazione non avea bisogno d'esser
protetta contro la sua propria volontà: non c'era da temere
ch'essa si tiranneggiasse da sè. E poichè i governanti di
una nazione erano efficacemente responsabili verso di essa,
prontamente revocabili qµando a questa piacesse, sì poteva
bene affidar loro un potere di cui la nazione stessa aveva
il mezzo di prescrivere l'uso. Il loro potere non era che lo
stesso potere della nazione, concentrato e messo in una
forma comoda per essere esercitato. Questo modo di pen
sare o forse piuttosto di sentire era comune, nell'ultima
generazione dei liberali europei, fra i quali prevale ancora
sul continente. Quelli che pongono qualche limite a ciò che
un governo può fare, tranne il caso di governi tali che,
5econdo essi, non dovrebbero esistere, sono, fra i pensatori
del continente, segnali a dito come brillanti eccezioni. Un
tal modo di sentire potrebbe, nell'ora che volge, prevalere
anche nel nostro paese, se le contingenze che per un dato
tempo l'incoraggiarono non l'avessero mutato dappoi.
Ma nelle teorie politiche e lìlosolìche, come nelle persone,
il successo lascia scorgere dei difetti e dei lati deboli che
l'insuccesso avrebbe potuto nascondere. L'idea che i popoli
non hanno bisogno di limitare il loro 1:otere su loro stessi
poteva sembrare assiomatica quando 11g overno popolare
era una cosa di cui ci si limitava a sognar l'esistenza o a
lcg_gerla nella stol'ia, in qualche epoca molto remota.
\,luesto concetto non fu necessariamente turbato da tran
sitorie aberrazioni, come quelle della rivoluzione francese,
ui cui le peggiori furono opera di una minoranza usurpa
trice e che, in ogni caso, non rappresentavano l'azione per
manente delle instituzioni popolari, ma una esplosione su
bitanea e convulsiva contro il dispotismo monarchico ed
aristocratico. Frattanto, a tempo opportuno, una repubblica
democratica venile ad occupare una larga superlìc[e della
terra e divenne una delle parti più potenti della comu
nità delle nazioni. D'allora in poi, il governo elettivo e
responsabile divenne l'obbietto di quelle osservazioni e di
10 LA LIBERTÀ
quelle critiche che si dirigono a qualunque grande fatto
esistente. Ci si accorse ntlora che certe frasi, come« il po
tere su sè stesso > e « il potere dei popoli su loro stessi, »
non esprimevano il vero stato delle cose; il popolo che
esercita il potere non è sempre quello stesso su cui lo si
esercita, e il governo di sè stesso di cui si pnrln non è il
governo di ciascuno tenuto da lui stesso, ma di ciascuno
tenuto da tutli gli altri. Inoltre, volontà del popolo significa,
praticamente, volontà della parte più numerosa cd attiva
del popolo - della maggioranza insomma, o di quella che
riesce a passare per tale. Di conseguenza, il popolo può
desiderar di opprimere una parte di sè stesso, e le J?recau
zioni sono, a questo riguardo, utili allretlanto che contro
qualunque altro abuso di J.>Otere. Per queste ragioni è
sempre importante limitare 11 potere del governo sugl'in
dividui, anche quando i governanti siano regolarmente re
sponsabili verso la comunità, o cioè verso il partito che
nella comunità prevale. Questo modo di lumeggiare l'ar
gomento non ha duralo fatica a farsi accettare: esso si
r"ccomanda ugualmente all'intelligenza dei pensatori e alle
tendenze di quelle classi notevoli dclii\ società europea che
considerano la democrazia come ostile ai loro interessi
Cosi orn si pone, nelle speculazioni politiche, la tirannia
della maggioranza nel novero dei mali contro di cui la so
dclà deve premunirsi.
Come le altre tirannie, quella della maggioranza fu dap
prima ed è volgarmente ancora temuta, sopratutto in quanto
agisce por mezzo degli atti della pubblica autorità. Mn ogni
attento osservatore si accorse che. quando 111so cieta è essa
stessa il ti ranno - la società collettivamente, rispetto ai
singoli individui che la compongono - i suoi mezzi di
tiranneggiare non si restringono ai:..lia lti eh 'essa comanda
ai suoi funzionari politici. La societa può eseguire, cd ese
guisce essa stessa, i suoi propri decreti; e, se ne emana di
~altivi, o se ne emana a proposito di cose in cui non do
vrebbe entrare, essa esercita una tirannia sociale più for
mid11biled i qualunque oppressione legale: in realtà. se una
tal tirannia non dispone di penalità altreltunto grnvi, lasciu
però minor mezzo di sfuggirle; perchè penetra ben più
llddcntru nei particolari della viln cd incatena l'anima
stessa.
Per questo, la protezione contro la tirannia del magi
strato non basta. Dappoichè In società ba la tendcn~a:
l. 0 d'imporre come regole di condotta, con mezzi che non
entrano nelle penalità ci\•ìli, le sue idee e i suoi costumi a
quelli che se ne staccano - 2.0 d'impedire lo sviluppo e,
per quanto è possibile, la formazione di qualunque indivi
dualità spietata - 3.0 di costringere tutti i caratteri n mo
dellarsi sul suo proprio - r individuo ha il diritto di esser