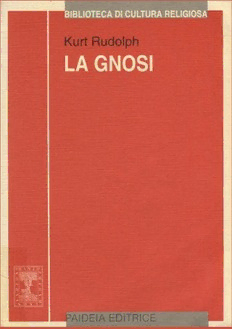Table Of ContentIBLIOTECA DI CULTURA RELIGIOSA
LA GNOSI
La grande importanza della gnosi per la storia delle
religioni della tarda antichità è oggi indiscussa.
Le sue radici sono da ricercare nella dottrina sapienziale
giudaica, nelle concezioni religiose iranico-zoroastriane
e nel pensiero greco illuministico, ma sulle sue origini,
così come sulla sua scomparsa, sono possibili soltanto
ipotesi, perché non vi sono fonti che consentano
di risolvere il problema una volta per tutte.
Apparsa all'incirca all'inizio dell'era volgare,
la gnosi scompare al più tardi nel sesto secolo,
almeno per quanto riguarda la sua forma occidentale.
Si può quasi affermare che la gnq_si abbia seguito
la grande chiesa come un'ombra: ·questa non riuscì mai
a dominare completamente quella, perché ne era
troppo influenzata. Nel corso della lom comune storia
esse rimangono sorelle, due sorelle tra loro ostili.
Merito del saggio di Kurt Rudolph - da tempo ·
considerato l'opera di riferimento sull'argomento -
è di delineare un quadro articolato, preciso e insieme
oltremodo chiaro e ordinato di un fenomeno per molti
versi intricato e sfuggente, che non riguarda soltanto
il cristianesimo, e la cui presenza si fa sentire ben al di là
della sua concreta esistenza storica, fin in età moderna
e contemporanea.
Kurt Rudolph, dopo aver insegnato alle Università
di Lipsia e di Santa Barbara in California,
dal 1986 è ordinario di Storia delle religioni
all'Università di Marburg.
ISBN 88-394-0584-4
f
lf
]li!IJ111lif
Il 9
Lire ~/.UUU
Kurt Rudolph
LAGNOSI
Natura e storia di una religione tardoantica
Edizione italiana a cura di Claudio Gianotto
Paideia Editrice
Titolo originale dell'opera:
Kurt Rudolph
Die Gnosis
Wesen und Geschichte einer spiitantike Religion
Mit zahlreichen Abbildungen und einer Faltkarte
3., durchgesehene und erganzte Auflage
Traduzione italiana di Franco Ronchi
Revisione di Claudio Gianotto
© Vandenhoeck & Ruprecht, Géittingen J1990
© Paideia Editrice, Brescia 2000 ISBN 88.394.0584.4
Premessa
L'interesse crescente, anche di un più vasto pubblico, per quel
fenomeno che va sotto il nome di «gnosi» o di «gnosticismo»,
non è dovuto unicamente ai clamorosi ritrovamenti di mano
scritti manichei e gnostici avvenuti in questo secolo nel Turke
stan (Turfan 1902-1914) e in Egitto (Medinet Madi nel 1930 e
Nag Hammadi nel 1945/46-1948), bensì anche al progressivo
riconoscimento, da parte della ricerca storico-critica, della no
tevole importanza di questa realtà religiosa tardoantica. Non è
semplice fornire una chiara e netta definizione di questa «reli
gione della conoscenza» o «del sapere», come si potrebbe sem
plicemente tradurre il termine greco yvwcrn:;, tuttavia si deve
cercare di farlo, sia pur brevemente, proprio all'inizio. Non si è
molto lontani dal vero se con questa denominazione s'intende
una religione dualistica, formata da più scuole e correnti, che a
suo tempo si pose in una posizione di netto rifiuto nei confronti
del mondo e della società dell'epoca, predicando una liberazio
ne («redenzione») dell'uomo proprio dalle costrizioni dell'esi
stenza terrena mediante la «presa di coscienza» del suo - tal
volta corrotto - legame essenziale, vuoi come «anima», vuoi
come «spirito», con un regno ultraterreno della libertà e della
pace. La sua diffusione nel tempo e nello spazio, a partire dal
l'inizio dell'era volgare, nell'Asia Anteriore occidentale (Siria,
Palestina, Egitto, Asia Minore) e via via fino all'Asia centrale e
orientale e all'Europa medievale (XIV secolo), lascia ben im
maginare quale ruolo le competa, sia pure in forma mutata e
adattata, nell'ambito della storia delle religioni, senza conside
rare che ancora oggi, in Iraq e Iran, vivono una esistenza au
tonoma i Mandei, considerati gli ultimi gnostici. Ma anche al
trimenti sono rintracciabili multiformi influenze dello spirito
7
gnostico nelle tradizioni dell'Europa e del Medio Oriente: nel
la teologia e nella teosofia, nella mistica e nella filosofia.
Per quanto riguarda una puntuale informazione sulla gnosi,
la situazione non è delle migliori, soprattutto per i non specia
listi, giacché da molto tempo manca una presentazione globale
di una certa ampiezza. Oltre alla pratica monografia di Hans
Leisegang, molto diffusa e più volte ristampata (Die Gnosis,
r924, •r 95 5) e la pionieristica e ambiziosa ricerca di Hans ]onas
(Gnosis und Spatantiker Geist, tomo I, r934, 1 r964), il lettore
odierno ha più o meno a disposizione soprattutto raccolte di fon
ti tradotte (ultime, in ordine di tempo, quelle curate da Robert
Haardt [r967] e da Werner Foerster [r969, r97r]) e presenta
zioni d'insieme abbastanza limitate. La frequentazione quasi
venticinquennale di questo ambito di studi mi ha dato il co
raggio di tentare una nuova presentazione d'insieme, che ten
ga conto dei risultati della ricerca recente. Il modello che ho
avuto davanti agli occhi è stato il prezioso libro di Leisegang,
per quel suo alimentarsi direttamente alle fonti, che cita diffu
samente. D'altro canto, mi differenzio da lui non solo per es
sermi posto in una prospettiva diversa, che devo a Hans ]onas,
ma anche per aver fatto parlare soprattutto le abbondanti fon
ti originali oggi disponibili, in particolare quelle copte, e un po'
meno gli eresiologi, cui invece Leisegang lascia ampio spazio.
Ho pensato, inoltre, non inutile premettere una breve storia cri
tica delle fonti quale introduzione all'argomento principale e,
come «epilogo», offrire una rapida presentazione della storia
delle influenze della gnosi. È stato concesso anche più spazio
alle questioni cultuali e sociologiche. Inoltre ho volutamente
preso in considerazione anche il manicheismo e i Mandei, che
Leisegang non tratta affatto. Sono il primo a conoscere i limiti
della mia presentazione, che è lungi dall'essere completa. An
che chi scrive ha avuto qualche difficoltà a far coincidere l'idea
con la sua concreta espressione. L'edizione e lo studio, ancora
in corso, delle nuove fonti copte impongono una certa limita
zione e anche una certa cautela. Non ho mai celato il mio per
sonale punto di vista su questioni fondamentali e su singoli pro-
8
blemi, punto di vista che si è formato in una lunga f amiliarita
con le fonti e che non sempre ho potuto qui supportare appie
no, considerato il carattere dell'opera e il pubblico al quale è
destinata: l'esposizione privilegia l'essenziale e il quadro d'in
sieme mentre le note e la bibliografia forniscono ulteriori e più
specifiche informazioni. Ad ogni modo, l'ampia citazione delle
fonti offre molteplici possibilità di controllo. Spero sinceramen
te che anche i miei stimati Colleghi possano trarre una qualche
utilità dalla mia fatica.
Ci sono ancora alcuni particolari da spiegare. La traduzione
delle fonti è stata condotta tutta sui testi originali, il che non si
gnifica che non siano state consultate con profitto le traduzioni
già esistenti (talvolta il debito è esplicitamente indicato). Nella
riproduzione dei testi le parentesi tonde indicano aggiunte del
traduttore per facilitare la comprensione del testo, le quadre
una lacuna dell'originale con l'integrazione suggerita, le unci
nate una correzione del testo originale in base a varianti te
stuali. Le fonti vengono citate seguendo i sistemi e le edizioni
in uso nel mondo di lingua tedesca, come da bibliografia. I co
dici di Nag Hammadi (NHC) vengono citati con codice (nu
mero romano), trattato (numero arabo), numero di pagina e,
talora, di rigo (la numerazione delle pagine può in certi casi
variare, ma sarà segnalato). I termini tecnici di lingue stranie
re sono in corsivo, mentre per i termini di origine orientale
(soprattutto mandei), si è scelta una trascrizione semplificata,
che ne facilitasse la pronuncia. L'indice dovrebbe permettere la
ricerca per argomenti e favorire in genere l'organicità della pre
sentazione. La bibliografia offre, nella parte dedicata alle fon
ti, una rassegna ragionata delle traduzioni disponibili (preferi
bilmente in tedesco) e almeno una edizione del testo originale.
Naturalmente anche il resto della bibliografia rappresenta sol
tanto una selezione, ma comprende tutte le opere essenziali e
quelle che possono aiutare a proseguire lo studio. La tavola cro
nologica costituisce il tentativo, che io sappia il primo del gene
re, di presentare la storia della gnosi e del manicheismo in un
quadro d'insieme, con tutte le lacune e le incertezze del caso.
9
Le illustrazioni che arricchiscono il libro hanno una storia a
parte. Senza l'aiuto di altre persone la parte iconografica non
sarebbe mai nata. Mi può capire solo chi sa quanto sia difficile
trovare e mettere insieme delle buone, utili ed efficaci illustra
zioni sul nostro argomento. Non possediamo, in senso stretto,
alcuna testimonianza archeologica certa sugli gnostici, a parte
alcune poche epigrafi e molti libri o parti di libri. Anche le
gemme non fanno parte dei reperti archeologici. I tentativi di
acquisire alla causa catacombe e ipogei non si sono mai rivela
ti, a mio parere, particolarmente riusciti. L'ipogeo degli Aure/i
di Viale Manzoni a Roma, spesse volte chiamato in causa, è sta
to nel frattempo spiegato in modo molto diverso, e persino la
sua origine cristiana viene seriamente contestata. Anche in al
tri casi simili non ho rilevato nulla di tipicamente gnostico e ho
così rinunciato a questo genere d'illustrazioni. La basilica sot
terranea di Porta Maggiore a Roma (tav. 9) rappresenta una
soluzione di comodo per dare almeno una vaga idea dei locali
che gli gnostici potrebbero aver usato per il culto. Per contro,
dei Manichei in Asia centrale abbiamo molti più resti archeo
logici, e pertanto i loro monumenti hanno uno spazio maggio
re. Anche sotto il profilo artistico, quelli manichei sono i più pre
ziosi reperti che possediamo di una religione gnostica. Abbon
dante è naturalmente il materiale illustrativo per i Mandei (in
parte anche di proprietà dell'autore). Per il resto sono stati ri
prodotti soprattutto manoscritti e anche ciò è caratteristico del
la gnosi, perché essa rappresenta una religione del libro e della
scrittura, come ha ampiamente e indiscutibilmente dimostrato
ancora una volta il fondo di Nag Hammadi. James M. Robin
son, direttore dell'Institute of Antiquity and Christianity della
Claremont Graduate School, Clermont, California (USA) ha
generosamente e disinteressatamente risposto alla mia richiesta
di fotografie del fondo di Nag Hammadi, che è conservato nel
Museo Copto del Vecchio Cairo, e dei luoghi stessi del ritrova
mento, esplorati da lui e dai suoi collaboratori nel dicembre
1975. Anche le preziose foto di ]ean Doresse provengono dal
l'archivio di Claremont. Al prof Robinson va pertanto un mio
IO
grazie tutto particolare. Devo inoltre ringraziare il prof Josef
Frickel di Roma per avermi procurato il materiale per la ri
produzione della cosiddetta «statua d'Ippolito» (ripulita e rie
sposta) e dell'epigrafe di Semo Sancus; il prof Ludwig Koenen,
già a Colonia e ora nel Michigan, per la concessione della foto
del Codice manicheo di Colonia (nella sua condizione origi
naria); il dr. Werner Sundermann per l'aiuto nella scelta dei te
sti illustrati manichei iranici del Turfan dal fondo dell'Acca
demia delle Scienze della DDR; il dr. Ulrich Luft per un ana
logo aiuto per quel che riguarda i papiri gnostici e manichei in
copto di proprietà dei Musei statali di Berlino, sez. papirologi
ca; la dott.ssa Hannelore Kischkewitz per avermi procurato le
riproduzioni fotografiche delle gemme dal Museo egizio di Ber
lino. Ringrazio qui, collettivamente, tutti i musei e tutte le isti
tuzioni che hanno concesso l'autorizzazione a riprodurre que
sto materiale.
Ringrazio moltissimo anche mia moglie per l'aiuto nella pre
parazione del manoscritto e per la redazione dell'indice anali
tico. Mio suocero, il rev. Martin Killus, si è sottoposto, benché
meritatamente a riposo, alla fatica della correzione delle prime
bozze. Il dr. Peter Nagel di Halle (Saale) è stato anche lui così
gentile da intraprendere una prima lettura, dandomi una serie
di consigli critici per i quali gli sono grato. La Sig.ra Cerda
Kunzendorf, lettrice della casa editrice, si è molto impegnata
per dare la forma definitiva al manoscritto, eliminando scom
pensi e imperfezioni ancora presenti. Impaginazione e redazio
ne finale sono opera di ]oachim Kolbel, mentre Hans-Ulrich
Herold è l'autore dei disegni nel testo e della carta geografica
(pp. 88-89). Grazie anche a loro.
Lipsia, 22 luglio 1976.
Kurt Rudolph
Alla seconda edizione
Prima del previsto si è resa necessaria una nuova edizione del
libro, offrendo così all'autore la gradita occasione di eliminare
refusi e altri errori ancora presenti (soprattutto nei sottotitoli).
Il