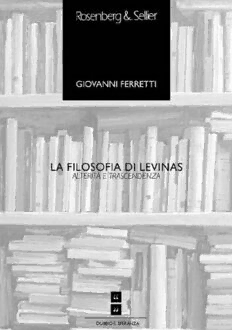Table Of ContentI
LA FILfOSO~IA DI LEVINAS
AL ERITÀ E1TRASCENDENZA
-
!
DUBBIO&. SPERANZA
INDICE
9 Sigle usate per le opere di Levinas
13 Presentazione
17 Avvertenu. per la seconda edizione
19 1. Biografia intellettuale
19 L Gli anni giovanili e la formazione ebraico-lituana (1900-1923)
22 2. Studente di filosofia a Strasburgoe Friburgo (1923-1930)
28 3- Prime pubblicazioni e attività a Parigi ( 1930-1939)
32 4 Gli anni della guerra e della prigionia (1939-1945)
35 5 Il primo dopoguerra: direttore della Scuola normale israelita
orientale a Parigi (1946 ss.)e scoperta delTalmud
38 6 La produzione filosofico-letteraria fino a Totalità e Infinito
( 1947-1961)
-,. Professore universitario ( 1964-1979) e nuova produzione
filosofica fino ad Altrimenti che essere
& L'ultima fase della sua attività ( 1979-1995)
LE OPERE GIOVANILI
51 2. L'interpretazione di Husserl e Heidegger
51 L L'interpretazione di Husserl inl..a teoria dell'intuizione (1930)
59 2. Sviluppo dell'interpretazione di Husserl in L'opera di Ed,nund
Hus$erl (1940)
65 3- L'interpretazione dell'ontologia di Heideggcr
70 4 Il pa<soggi.., dalla fenomenologia ali'e sistenzialismo
77 3. L'opera Da//'esistenu.a//'esistente (1947)
77 L Verso una d.iversa impostazione del problema ontologico
78 2. Un precedente: l'uscita dall'essere in Dell'evzione (1935)
80 3- La nozione di il y a
84 4 Il sorgere del soggetto esistente: l'ipostasi
90 5 Il concetto di mondo
5
97 4 Il tempo e l'altro
97 x. Lasolitudine dcll'io
xoo 2. Sofferenza, passività, morte, futuro
xo3 3. Altri, femminilità, paternità
TOTALITÀ E INFINITO
5. Introduzione alla lettura di Tota/iJà e Infinito
x. Le idee portanti di Totalità e Infinito
2. Le quattro sezioni dcll'opcra
3. Metodo fenomenologico, linguaggio e scrittura
6. La relazione metafisica e l'idea dell'infinito
X2X
X2X x. lo fenomenologia del Desiderio
X22 2. La relazione metafisica, la separatezza atea, la creazione
n4 3. La struttura formale paradossaledcll'idca dcll'lnfinito
x29 7. Il «volto» dell'altro e la relazione etica
X29 x. li «luogo» dclla «produzione» dcll'Infinito
2. La fenomenologia del «volto» e U discorso: «il volto parla»
X3X
x34 3. «Nudità» del volto e natura dclla relazione etica
x38 4. Il primato dclla relazione etico-metafisica sull'ontologia
x4x 8. La separatezza dell'io come interiorità ed economia
x4x x. Interiorità e godimento: l'indipendenza dcll'io
x44 2. Corporeità e sensibilità: indipendenza attraverso la dipendenza
x5x 3. Dimora cd economia: condizione condizionata del rapporto con
Altri
9. Oltre l'interiorità:le categorie etiche dello spirituale
x. La soggettività in se stessa: parola e bontà
2. Ragione, evidenza, linguaggio, giustizia
3. Relazione etica e tempo: U problema dcli a morte, dcli a sofferenza
e dclla storia
x72 4. L'infinito del tempo: portataetica dcllafcconditàe dcllapatemità
x77 5. Per una soggettività "decentrata"
ALTRIMENTI CHE ESSERE
x85 xo. La traccia e l'enigma
x85 x. La radkalizzazinne del tema dclla trascendenza
x88 2. La via dcll'immanenza e la via dclla trascendenza
x9x 3. Liturgia, visitazione, diaconia
x94 4. Tracciae Ulcità
x97 5. L'enigma
205 11. Introduzione alla lettura di Altrimenti che essere
205 L L'argomento
212 2. Il metodo
221 12, Sensibilità e passività
221 L Il tema: la «riduzione» dal Detto al Dire
222 2. L'itinerario dell'ontologia e il senso ontologico del Detto
233 } Il Dire eia soggettività come passività/esposizione
243 13- Prossimità e ossessione
243 L Il •doppio senso" della sensibilità
249 2. Soggenività come prossimità
255 14 Sostituzione e identificazione
255 L L'idcntinca:aone dell'io nell'ontologia della coscienza
259 2. Laricom:nza identificatriccdcll'io eia passività comecreaturolità
261 } Identificazione e ipostatizzazione dell'io in termini etici
265 4 Dal «Sé» alla «sostituzione»: il paradosso dell'identità
271 5 La sostituzione come comunicazione originaria
274 6 •Libertà finita" come gratuità e senso della •finitezza" umana
287 15- Soggettività e infinito
287 L Verità come svelamento e verità come testimonianza
298 2. La gloria dell'Infinito
309 } Possibilità della filosofia e senso dcli'o ntologia
323 1~ Altrimenti detto
323 L Violenza e ontologia
327 2. Criticismo e trascendenza
333 Appendice. Il dialogo-confronto tra Derrida e Levinas:
«un contano nel cuore di un chiasmo»
347 Bibliografia
SIGLE USATE PER LE OPERE DI LEVINAS•
1111 La 1héorie de /'in1uilion dans la phénoménologiede flusserl, Akan, Paris,
1930; trad. it. La leoriade/l'inluivone nella fenomenologia diflusserl, a
cura di S. Petrosino, trad. di V. Perego,Jaca Book, Milano, 2002.
De l'évosion, riedito daJ. Rolland, Fata Morgana, Montpellier, 1982
(or. 1935-36); trad. it. De/l'evasione, a cura di G. Ceccon e G. Francis,
Cronopio, Napoli, 2oo8.
liF. De l'exislence à l'existanl, Vr in, Paris, 19782 (or. 1947); trad. it. Dall'esi
sle,cy: al/'esi's1enle, a cura di F. Sossi, con una premessa di A. Rovatti,
Marictti, Casale Monferrato, 1986.
Le Temps e/ l'Aulre, Puf, Paris, 19831 (or. 1947); trad. it. Il Tm,po e
TA
l'Allro, a cura di F.P. Ciglia, il mclangolo, Genova, 1987.
En dérouvranl l'existence avec Husserl el Heidegger. Vrin, Paris, 19672
EOE
(1•cd. 1949); trad. it. Scopni-e l'e sis/e,cyJ ron Husi';;/ eHeidegger, a cura
di F. Sossi, Cortina, Milano, 1998.
11 ToJalité el ln/ini. Essai sur l'exleriorilé, Nijhoff, La Haye, 1961; trad.
it. ToJalilà e In/imio. Saggio su/J'esleriorilà, a cura di A. Dal!'A sta, con
introd. di S. Petrosino,Jaca Book, Milano, 199o2.
l>I. Difficile Liber1é. Essais sur le judaisme, Albin Miche!, Paris, 19762 (x• cd.
1963); trad. it. Difficile liberlà. Saggi sul giudaim10, a cura di S. Facioni,
Jaca Book, Milano, 2004.
a
I Ndlccitmoni, dopolasigla primonwncm si rifc:rise<:allc pagincddl'cdizioncfranccsc
gui ciiaia,_ m<:n!J'C il secondo, dopo un punto e vu-gola. alle pagine dcli'e ventuale tnid. it.
indiatL l,}uandoncllc ciiazioni introducwnodci corsivi. li indichcn:mocon l'abbn:vmione
cn = corsivo nostro; cam = corsivi nostri. Più ampie indiCIIZÌoni sulle c:diz:ioni ddlc opere:
di Lc:vinas si trovano nella bibliografia finale.
9
Ql:r Quatre Leau,e TalrnuJigues, Minuit, Paris, 1968; trad. it. Quallro le11u,e
talrnuJiche, pref. e trad. di A. Mosato, il mélangolo, Genova, 1982.
111\11 Hu,11anisme de l'autre ho,mne, Fata Morgana, Montpcllicr, 1972; trad.
it. Urnanesi,r10 dell'altro uon10, a cura, con introd. e note di A. Mosato,
il mdangolo, Genova, 1985.
AE Aut,en,enl qu'ètreouau-delà de l'enence, Nijhoff, La Hayc, 1974; trad.
it.A/1,irnenti che essere oaldi làdel/'essen1.11, a cura di S. Petrosino e
M.T. Aiello, con introd. di S. Petrosino, Jaca Book, Milano, 1983.
Mli Su, Maurice Blanchot, Fata Morgana, MontpclJier, 1975; trad. it. Su
Blanchot, con introd. di F. Fistetti e A. Pon:cio, Palomar, Bari, 1994
NI' Nomes prop,es, Fata Morgana, Paris, 1976; trad. it. Nomi propn·, con
introd. e note a cura di FJ>.Ciglia, Marietti, Casale Monferrato, 1984
ss Du Sacré au Saint. Cinq nouvelles leaures tal,nudiques Minuit, Paris,
1977; trad. it. Dal Sacro iJ Santo. Cinque nuove le11u,e 1aJrnudiche, a cura
di O.M. Nobile Ventura, con introd. di S. Cavalletti, Città Nuova, Roma,
1985.
DVI De Dieu qui uient à l'idée, Vrin, Paris, 1982; trad. it. Di Dio che viene
all'idea, a cura di S. Petrosi.no, trad. di G. Zcnnaro, Jaca Book, Milano,
1983.
Ethique et ln/ini. Dialogues avec Philippe Nen10, Fayard et Radio France,
l'J
Paris, 1982; trad. it. Etica e Infinito. Dialoghi ron Phi/ippe Nen,o, a cura
di E. Baccarini e con introd. di G. Mura, Città Nuova, Roma, 1984
ADV L'au-delà du verse/. Leau,es et discours talrnudiques, Minuit, Paris, 1982;
trad. it. L'a/Jilàdel verse/lo. Le11u,ee discorsi talrnudici,a cura di G. Lissa,
Guida, Napoli, 1986.
11U T,anscendence et intelligibilité, Labor et Fidcs, Genèvc, 1984; trad. it.
T,ascendefl1.II e intelligibilità, a cura di F. Camera, Marietti, Genova,
1990.
Hors Sujet, Fata Morgana, Montpcllicr, 1987, trad. it. Fuori dal Soggello,
1IS
a cura di F.P. Ciglia, Marictti, Genova, 1992.
IIN A l'heu,edes nations, Minuit, Paris, 1988; trad. it. Nell'ora del/e navoni,
a cura di S. Facioni, Jaca Book, Milano, 2000.
o De l'oblitération, Entretien aver E Annengaud à propos de l'oeuure de
Sosno, La Différencc, Paris, 1990.
IO
liN Entre nous. Essais surkpe11ser-à-l'011tre, Grasset, Paris, 1921; trad. it. T 112
noi. Saggis ul pensare-all'altro, a cura di E. Baccorini,Joca Book, Milano,
1998.
1».rr Dieu, la Mori e k Te111ps,Grasset, Établissementdu texte, notes et post
foce dc J. Rolland, Paris, 1993; trad. it. Dio, la morie e il le,npo, o cura
di S. Petrosino, trad. di S. Petrosino e M. Odorici,Jaca Book, Milano,
1996.
u; Liberté et comn111nde,nenl, Fata Morgana, Paris, 1924 (or. fr. 195J), trad.
it. par..:ialc Libertà e comando, in E. Lcvinas e A. Pepcr.r.ak, Etica co,ne
fi/,osofia prima, a cura di F. Ciaramelli, Guerini e associati, Milano, 1989,
pp. 15-29-
111 Les in,prévus de l'histoire, Fata Morgana, Paris, 1994.
II
PRESENTA ZIONE
L'opera offre una delineazione globale della filosofia di Emmanuel
Levinas, morto recentemente a quasi novant'anni sul finire del 1995
e ormai da annoverarsi tra le grandi figure non solo della filosofia
ma dell'intera cultura del novecento. Il metodo scelto è stato quello
di seguirne lo sviluppo storico. Si parte dai primi studi, in cui egli si
confronta con Husserl e Heidegger ascoltati a Friburgo negli anni
1928-1929, si passa agli scritti degli anni immediatamente seguenti
la seconda guerra mondiale, che offrono la prima formulazione auto
noma del suo pensiero, si giunge ai capolavori Totalità e Infinito del
1961 e Altrimenti che essere del 1974, in cui abbiamo l'esposizione
organica più matura della sua filosofia. Nell'analisisonotenuti presenti
anche importanti saggi di passaggio dal primo al secondo capolavoro,
come pure gli scritti posteriori che ne prolungano le tematiche; e non
mancano i riferimenti ai lavori di carattere non strettamente filosofico,
come i suoi originali commenti al Talmud. L'opera è così tra le prime
presentazioni complessive della filosofia di Levinas, che ne segue con
impegno analitico-interpretativo tutto losviluppo. Normalmente si sono
avute trattazioni per temi settoriali o tentativi, più o meno riusciti, di
presentarne le strutture di fondo sganciandola dal suo divenire.
La biografia intellettuale chepremettiamo nelcapitoloiniziale, vuole
essere una sintetica presentazione della figura del filosofo e un collega
mento tra il suo pensiero e le fondamentali esperienze di vita in cui si
radica: l'ebraismo lituano in cui fu educato e lo studio del Talmud cui
si appassionò in età matura, l'incontro con Husserl e Heideggere con
la cultura universitaria francese, gli orrori delle due guerre mondiali,
della prigionia, dell'Olocausto del suo popolo ecc. Esperienze pre
filosofiche che non spiegano certo il sorgere del suo pensiero ma sono
indispensabili per comprenderlo. In appendice abbiamo infine dato un
esempio del dibattito critico che egli ha suscitato: il dialogo-confronto
con Derrida. Forse l'episodio più rilevante di tale dibattito ma anche il
modello del tipo di risposta che l'opera di Levinas provoca. Non solo
IJ
la vigilanza critica circa le argomentazioni in giocobma anche la libera
accenazionedi un dono di cui si diviene responsa ili.
Lo stile del nostro lavoro cerca di coniugare la rigorosità scientifica
dell'interpretazione con un'esposizione piana e progressiva, rivolta
anche ai non filosofi di professione e acli studenti universitari. Per
un verso si è quindi cercato di evitare lab analizzazione di Levinas in
poche formule stereotipe: fenomenologo del volto altrui come assoluta
trascendenza, filosofo dell'etica in alternativa ad Heidegger filosofo
dell'ontologia, "pensa-tore ebraico" che ha rimesso in circolazione la
figura biblica del Dio della legge ecc. Formule che estrapolate dal
contesto e dalla trama di concetti che ne determinano il significato,
finiscono più per tradire che per introdurre alla ricchezza e alla forza
provocante del suo pensiero. Un pensiero che, maturatosi in quel
crogiuolo di idee che si è avuto nel passaggio dalla fenomenologia di
Husserl all'esistenzialismo ontologico di Heidegger, si presenta come
una delle proposte più originali e feconde della filosofia del novecen
to, sfuggendo all'alternativa, in essa dominante, tra totalizzazione o
frammentazione del senso, centralità del soggeno o morte dell'uomo,
metafisica tradi:i'Jonale o nichilismo.
Per altro verso, coscienti della complessità del pensiero e della scrit
tura di Levinas, si è cercato di condurre progressivamente a leggere
e gustare direnamente le sue opere fondamentali, ormai veri e propri
"classici" ma di difficile lenura e comprensione per chi non vi fosse
preparato in modo appropriato. Il nostro lavoro, messo alla prova in
alcune sue parti in forma di dispense universitarie, si presenta quindi
anche come un'introduzione alla lenura di tali opere e come un loro
commentario.
La scelta che abbiamo fano di concentrarci sull'itinerario "filoso
fico" di Levinas, lasciando in secondo piano gli scritti sul Talmud o
d'impegno teologico-confessionale nasce dalla convinzione che egli
sia riuscito nell'intento, più volte dlchiarato, di elaborare un pensiero
veramente filosofico, che si fa valere non arpeggiandosi a dogmi di
fede oa testi ritenuti sacri, ma per la forza de suo stesso procedimento
fenomenologico-argomentativo. Nei suoi scritti Levinas fa certamente
risuonarci! grido degli antichi profeti e quello delle vittime della violenza
antisemita, presentandone l'istanza imperativa come la contestazione
decisiva del corso prevalentedella cultura occidentale, ove ha dominato
l'ontologia totalitaria, la storia ha schiacciato gli individui, la guerra è
stata il momento risolutivo delle relazioni umane, l'altro è stato visto
anzitutto come il nemico.
Ma è altrettanto vero che egli ha cercato di "tradurre" nel linguag
gio greco della filosofia la portata universalmente umana di tali voci,
impegnandosi a mostrare che l'istanza della giustizia reclamata dal
povero, dallo straniero, dall"'altro", è alla base di ogni significato e di
ogni intelligibilità umanamente rilevanti. Anzihegli ha anche cercato
di ricuperare e far valere in modo nuovo que a tradizione filosofica
alternativa, presente a sprazzi nd corso stesso del pensiero occidentale,
che ha posto «il Bene al di là dell'Essere», insegnando ad andare oltre
l'immanenza dd logoso l'orizzonte delle varie ontol(?gie. E cosl non ha
semplicemente contrapposto l'esperienza religiosa alla filosofia, ma ha
cercato di scoprire nella prima le valenze umanamente universali e di
riportare la seconda alla sua tradizione più valida. La scelta di concen
trarci sull'itinerario "filosofico" di Levinas non ha quindi il significato
di lasciare da parte un aspetto del suo pensiero, bensl qudlo di andare
alla sua sostanza, studiandolo e analizzandolo per quello che ha voluto
essere: un pensiero valido p_er tutti e comunicabile a tutti.
L'opera appare nella collana Et-et/aut-aut, impegnata a illustrare
il rapporto spesso conflittuale, che nella modernità si è avuto tra
pensiero filosofico e tradizione ebraico-cristiana. Di tale rapporto il
pensiero di Levinas costituisce certamente un modello caratteristico,
a un tempo di aut-auJ e di et-e/. Di auJ-auJ in quanto per Levinas
l'ebraismo, ripensato tramite un'interpretazione del Talmud all'al
tezza dei tempi, costituisce una radicale alternativa al pensiero greco
ontologico-contemplativo, esploso nelle sue virtualità totalizzanti e
immanentistiche soprattutto nella modernità. Di et-et, in quanto egli
è convinto non solo che sia possibile "tradurre" il pensiero religioso
ebraico nel linguaggio "greco" della filosofia, ma anche che esso spinga
a ricuperare ndla tradizione filosofica occidentalequegli elementi som
mersi di rimando alla trascendenza che in essa pur sono presenti.
Il sottotitolo che abbiamo dato al lavoro, «alterità e trascendenza»,
è stato scelto, tra altri possibili, per esprimere qudlo che ci pare essere
il nucleo tematico centrale della filosofia di Levinas. Questa è infatti
indubbiamente una filosofia che vuole salvaguardare l'alterità altrui,
anzitutto l'alterità dell'altro uomo, non riconducendola alle categorie
del soggetto conoscente o all'orizzonte dell'essere quale orizzonte
della coscienza. E al tempo stesso essa vuole ricuperare il senso vero e
proprio della trascendenza, dopo la crisi della metafisica ontoteologica.
Impegnandosi in una ricerca filosofica tesa a «intendere un Dio non
contaminato dall'essere» (AE X; 2) e riscoperto come assoluta santità/
alterità e come kéno.rinella "passione" del suo popolo, Levinas ha offerto
alle stesse teologie confessionali una via per ripensare la trascendenza
divina dopo la morte del Dio «abitante dietro i mondi» (Nietzsche) o
ridotto a semplice «enfasi dd mondo» (Barth).
I termini di alterità e di trascendenza sono quindi stati scelti più