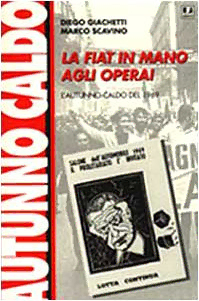Table Of ContentBiblioteca di cultura storica 16
Diego Giachetti
Marco Scavino
LA FIAT IN MANO AGLI OPERAI
L' AUTUNNO CALDO DEL 1969
0
Diego Giachetti ha scritto ii primo capitolo, a eccezione del primo para
grafo steso da Marco Scavino che ha scritto anche ii secondo capitolo.
e
L' introduzione comune.
In copertina:
Manifesto di Lotta Continua in occasione del
Salone internazionale dell' auto del 1969
1999
© BFS edizioni
Biblioteca Franco Serantini soc. coop. a r.I.
Largo Concetto Marchesi -56124 Pisa
per corrispondenze: cas. post. 247 -56100 Pisa
tel. 050 57 09 95 fax 050 31 37 201
e-mail: [email protected]
sito web: http://www.bfspisa.com
ISBN 88-86389-52-3
INDICE
7 IN1RODUZIONE
L' AUTUNNO CALDO
13 0ALLE LOTTE DELLA PRIMAVERA ALLA BATTAGLIA DI CORSO TRAIANO
46 REALTA E DIFFICOLTA DELL'ESTREMISMO TORINESE
57 L'0FFICINA 32 APRE LA VERTENZA CONTRATTUALE
63 Gu SCIOPERI ESTERNI
70 NASCITA E ORGANIZZAZIONE DEi DELEGATI
77 LA FIAT IN MANO AGL! OPERA!
90 LOTTA DURA PER VINCERE LA PAURA
96 LA LOTTA DILAGA NE! QUARTIERI E NELLE SCUOLE
115 LA FIRMA DEL CONTRATTO
UN TENTATIVO DI INTERPRETAZIONE
129 UNA "NUOVA" CLASSE OPERAIA?
153 CULTURE POLmCHE A CONFRONTO
177 LA QUESTIONE DEi DELEGATI
197 IL '69 COME FATTORE DI CRIS!
217 OOICE DEi NOMI
GIOCO DELLA
Contrattazione
Democratic a
La risposta sara data
riempendo gli spazi
segnati col puntino.
da « LA CLASSE», n. 12. 1969
INTRODUZIONE
L'unica musica che il padrone sente
e
il silenzio delle macchine ferme
(scritta apparsa sui muri di cinta della Mirafiori, 1971)
Le lotte operaie del 1969, culminate nei rinnovi contrattuali del cosid
detto "autunno caldo" (espressione usata forse per la prima volta dal quo
tidiano «11 Sole. 24 ore» nel numero del 10 agosto di quell'anno), sono
state uno dei piu consistenti fenomeni di mobilitazione collettiva mai av
venuti. Furono perse complessivamente piu di 300 rnilioni di ore di scio
pero, di cui oltre 230 rnilioni nell'industria1• Secondo lo storico inglese
Robert Lumley, si tratto del "terzo movimento della storia quanto a nume
ro di ore di lavoro perdute (d opo lo sciopero generale del maggio '68 in
Francia e quello generale del 1926 in Gran Bretagna)"2•
Considerare questo fenomeno esclusivamente sotto il profilo sindacale
e
e delle relazioni di lavoro (come pure stato fatto in molti e pregevoli
studi, indispensabili per un' analisi che non voglia essere solo impressioni
stica), appare pero riduttivo. 11 1969, insieme all'anno che lo precedette (il
mitico "Sessantotto" degli studenti, secondo una lettura che non ci si stan
chera mai di giudicare rniope e fuorviante ), segno infatti una svolta che,
partendo da alcuni luoghi del conflitto -le fabbriche e gli uffici, le univer
sita, le scuole secondarie -, investi direttamente l'intera societa, la politica
e la cultura dell' epoca, gli stili di vita, i sisterni di relazione tra i gruppi
sociali e tra gli stessi individui. Fu, in altre parole, una di quelle fasi stori
che che -per la radicalita delle trasformazioni cui danno vita - assumono
un significato di svolta, di rottura violenta e accelerata degli equilibri
preesistenti. Una di quelle fasi alle quali gli storici in genere assegnano un
forte valore periodizzante.
Eppure, l'indagine storica su quel periodo appare oggi ancora larga
mente insufficiente. Non solo dal puntb di vista dell'interpretazione gene
rale che di essa si da nel quadro di sviluppo della societa nel secondo do-
1. Per i dati, cfr. R. FRANWSI, The Puv.le of Strikes. Class and State Strategies in
Postwar Italy, Cambridge, University Press, 1995. lnoltre si veda, anche per un confronto
intemazionale, G. P. CELLA (a cura di),11 movimento degli scioperi nel xx secolo, Bologna,
II Mulino, 1995.
2. R. LUMLEY, Dal '68 agli anni di piombo. Studenti e operai nella crisi italiana, Fi
renze, Giunti, 1998 (Londra, Verso, 1994), p. 157.
8 D. GIACHEm - M. ScAVINO
poguerra, ma anche sul piano delle ricostruzioni fattuali e dei contesti spe
cifici in cui quei fatti si svolsero. Per quanta possa apparire paradossale,
sul biennio 1968-69 e sulle lotte operaie dell'autunno, che ne costituirono
l' apice, possediamo ancora pochi elementi di conoscenza veramente ap
profonditi. Abbiamo ottimi studi sociologici e di storia delle relazioni in
dustriali, ma pochi lavori di impianto storiografico.
Le ragioni sono molte e senz'altro complesse. L'impressione piu im
e
mediata che oggi il tema del ruolo che il conflitto sociale (in primo luo
go quello operaio) ha avuto nello sviluppo della societa non riscuota mol
to interesse. Come ha ricordato di recente Stefano Musso nell'introduzio
ne all' Annale Feltrinelli, intitolato Tra fabbrica e societa. Mondi operai
nell'/talia del Novecento (Milano, Feltrinelli, 1999), la storiografia del
movimento operaio sta attraversando una fase acuta di crisi, priva ormai
delle certezze che un tempo la animavano e che spesso (soprattutto in Ita
lia, verrebbe da dire) la spingevano a confondere la storia della classe
operaia con la storia delle sue lotte, delle sue organizzazioni, delle sue
espressioni ideologiche maggiori. Oggi prevale semmai l'eccesso oppo
sto: le organizzazioni sembrano scomparse dalla memoria storica, il mo
mento del conflitto diventa un mero dato sociologico, degli operai interes
sano i consumi, le culture, gli stili di vita, ma sempre di meno le lotte, il
cui senso storico sembra del tutto smarrito. E come se, venuta meno la
convinzione che il conflitto di classe andasse ineluttabilmente nella dire
zione di una societa piu giusta ed egualitaria, e che la classe operaia fosse
destinata a diventare "classe generale", fosse crollato anche qualunque
senso della storia. Come se, vivendo in un'epoca che vede la classe opera
ia (almeno, quel tipo di classe operaia) ridimensionata e ridotta al silen
zio, si fosse rinunciato a ragionare storicamente, comunque, sulle epoche
in cui invece la fabbrica e gli operai erano il luogo centrale del conflitto.
Di fronte a questa impasse della storiografia operaia, oggi prevale in
vece (e sembra risultare vincente) un'interpretazione assai diversa dello
sviluppo economico e sociale, che ne vede ii motore decisivo nel sistema
delle imprese, nel suo dinamismo, nella sua maggiore o minore capacita
di aderire alle esigenze che lo circondano. Una lettura che non nega il mo
mento del conflitto (anzi: per certi aspetti lo esalta - qualora opportuna
mente regolato - come elemento importante dello sviluppo), ma lo consi
dera come un aspetto tra gli altri della storia del sistema, accanto alle in
novazioni tecnologiche, la formazione del management, la conquista del
e
mercato, i rapporti con lo Stato e la classe politica. E non certamente un
caso che in. Italia questa interpretazione venga proposta con forza soprat
tutto dagli studi che hanno al centro le vicende della piu grande impresa
privata italiana (l'unica, tra l'altro, ad aver valorizzato adeguatamente il
proprio archivio storico), come il volume di Berta su Conflitto industriale
INTRODUZIONE 9
e struttura d'impresa alla FIAT e quello piu recente di Castronovo, FIAT
1899-1999. Un secolo di storia italiana.
D'altra parte, queste pubblicazioni (e altre analoghe, come i due volu
mi curati da Berta e da Cesare Annibaldi per Il Mulino, Grande impresa e
sviluppo italiano) prendono spunto proprio dalla ricorrenza del centenario
della FIAT, celebrato a Torino con grande impiego di mezzi, con mostre fo
tografiche e festeggiamenti vari, sino a uno sfarzoso ricevimento (seguito
con morbosa attenzione dai grandi mezzi di informazione) che ha visto
riuniti, con la direzione dell'azienda, il Presidente della Repubblica Ciam
pi e il Presidente del Consiglio D' Alema, il segretario della CGIL Cofferati
e tutti gli amministratori locali, lasciando anche un commovente spazio
all'intervento di una "rappresentante" dei lavoratori. Forse mai come in
questa occasione e apparsa evidente l'egemonia che (anche sul terreno
culturale) la grande impresa esercita nella societa odiema e che si nutre
anche della capacita di rileggere a modo suo le proprie vicende storiche,
di offrime un'immagine conciliante e positiva, in cui -per usare le parole
di Giovanni Agnelli, intervistato da Marcello Sorgi su «La Stampa» del
10 luglio -gli anni della conflittualita permanente, seguiti all'autunno del
'69, si riducono a "una grande sarabanda". Ed ecco, allora, che tra le ma
nifestazioni del centenario c'e spazio anche per l'ironia amara e disincan
tata del Cipputi di Altan, la figura che -meglio di tanti discorsi -ha sapu
to rappresentare in questi anni la sconfitta del movimento operaio italiano.
E stato impressionante il coro pressoche unanirne dei mezzi di infor
mazione e dell'opinione pubblica nel ricordare i cento anni della FIAT
come una vicenda fatta di cifre, di fatturato, di settori di investimento, di
modelli automobilistici piu o meno azzeccati, di quote di mercato, di di
nastie familiari e di grandi amministratori (il paragone tra Valletta e
Romiti); nel celebrarla come il massimo emblema della modernita italia
na, senza spendere una parola su altri punti di vista di quella stessa vicen
da, magari meno esaltanti o solo piu problematici3. Chi si illudeva che la
3. Ci sembra giusto segnalare, come rara voce dissonante, l'intervista di Salvatore
Tropea al segretario torinese della CISL, Tom Dealessandri, ex operaio assunto alla FIAT nel-
1' aprile de! 1968, pubblicata dal quotidiano «la Repubblica» (peraltro nelle pagine locali)
ii 10 luglio, che offriva un'immagine almeno piu schietta e viva della realta di fabbrica.
Ricordava tra I' altro Dealessandri: "entrai e subito mi dissi: questi sono tutti matti, non e
possibile che ii lavoro sia questa cosa qui. In alto, contro i soffitti che sembravano un cielo
scuro, scorrevano i convogliatori. Per terra i corridoi di legno catramato, anche questi scu
ri. Gli operai lavoravano alla lastroferratura che era ii posto dove si metteva assieme la
scocca delle vetture. Que! giorno mi fecero fare ii giro <lei principali reparti [ ... ]. Mi sem
brava veramente di stare in un altro mondo. E poi i rumori diversi da un settore all'altro,
assordanti, insistenti, ripetitivi. II clic delle pinze, lo scoppiettio pirotecnico della saldatu
ra, ii frastuono delle lamiere, ii sibilo dell'aria compressa e dei getti d'acqua, lo sferraglia-
10 D. G1AcHEm -M. ScAvINo
ricorrenza del centenario potesse es sere I' occasione anche per una rifles
sione storica, o per un lavoro di documentazione, avra dovuto ricredersi;
e
neppure dai partiti di sinistra e dalle organizzazioni sindacali stato fatto
e
uno sforzo degno di nota in questo senso. Se questa la tendenza domi
nante, ci si puo aspettare che vengano prese iniziative per ricordare I' au
tunno caldo?
Questo libro tratta anch'esso principalmente della FIAT, in particolare
di quanto avvenne nello stabilimento di Mirafiori tra la primavera e I' au
tunno di quell'anno. Si inserisce anch'esso in quella interdipendenza
strettissima tra storia della grande impresa torinese e storia nazionale che
e
stata piu volte sottolineata, da ultimo nel monumentale lavoro di Valerio
Castronovo, che si apre considerando appunto come "nel corso del Nove
cento nessuna impresa europea, ancorche di maggiori dimensioni, ha con
tato tanto quanto la FIAT nella storia del proprio paese". Anche in questo
e
caso, dal nostro specifico punto di vista, ci sembrato che le vicende del
la FIAT, di Mirafiori, avessero un valore piu generale, che andava al di la
della dimensione torinese, influenzava l'intero quadro nazionale, aveva ri
percussioni dirette su tutti gli aspetti della vita pubblica, del dibattito eco
nomico e politico dell' epoca. Proprio per questi motivi, perche convinti
che le lotte FIAT di quel periodo non possano essere considerate un sempli
ce fatto locale, abbiamo ritenuto di poter unire a una parte piu analitica,
ricostruttiva dei fatti e del contesto specifico in cui si svolsero, un tentati
vo di interpretazione del loro significato storico di taglio piu generale, che
ci auguriamo non appaia per questo troppo schematico e possa offrire un
contributo, per quanto modesto, a una ripresa di studi sul conflitto operaio
nell 'Italia contemporanea.
Abbiamo cercato, nel corso del lavoro, di utilizzare quanto piu ampia
mente possibile le fonti a disposizione: testimonianze dei protagonisti
(sindacalisti, militanti dei partiti di sinistra o dei gruppi dell'estrema sini
stra, ma anche semplici operai), raccolte di volantini e documenti prodotti
dai sindacati, dai partiti e dai gruppi, appunti e pagine di diario (in qual
che caso inediti)4, articoli dell'epoca comparsi su vari quotidiani e setti
manali (politici e d'opinione), nonche saggi tratti da riviste di vario gene-
re dei nastri trasportatori in perenne movimento. E quel reparto speciale che erano le pres
se, dove ci si parlava all'orecchio come gli innamorati perche senno non ci si sentiva nep
pure a dieci centimetri di distanza".
e
4. La maggior parte di questo materiale stato consultato presso gli archivi della Fon
dazione Vera Nocentini, dell'Istituto piemontese Antonio Gramsci e del Centro studi Piero
Gobetti (Fondo Marcello Vitale). In quest'ultimo caso, ci e stato segnalato che, poiche
I' archivio e in corso di riordino, e possibile che le collocazioni da noi indicate risultino
modificate nei prossimi mesi.