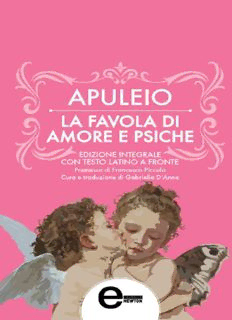Table Of Content170
Prima edizione digitale: luglio 2011
1995, 2009, 2010 Newton Compton editori s. r. l.
©
Roma, Casella postale 6214
ISBN 978-88-541-3403-4
www.newtoncompton.com
Edizione digitale a cura della geco srl
Lucio Apuleio
La favola di Amore e Psiche
Cura e traduzione di Gabriella D’Anna
Premessa di Francesco Piccolo
Edizione integrale con testo latino a fronte
Newton Compton Editori
Premessa
La prima domanda che conviene fare con calcolata ingenuità, rileggendo oggi
la favola di Amore e Psiche, è perché nel nostro immaginario si sia fermato il
dolore e non la felicità. Perché, se qualcuno ci chiede di ricordare, ci viene in
mente Psiche che prende la lucerna per illuminare il volto del suo amante
sconosciuto, ormai sicura che le apparirà davanti agli occhi un serpente dalle
spire mostruose. E invece si trova davanti Amore in persona (chissà se si può
dire: in carne e ossa). Oppure – appena dopo – Amore che vola via offeso dal
tradimento della promessa da parte di Psiche (verrò da te ogni notte, le dice, ma
non cadere nella tentazione di voler conoscere chi sono), e lei che si aggrappa
al suo piede e cerca di volare via con lui – e lo fa, fino a quando conserva le
forze, poi crolla al suolo. Perfino il gruppo scultoreo di Canova, che pure
rappresenta i due nell’attimo della passione amorosa, o nell’attimo che la
precede, ci sembra, forse condizionati dalla memoria narrativa, che racconti
l’ultimo momento di felicità prima del dolore. Come se fossimo condizionati
dalla luce necessaria per osservare l’opera, poiché è proprio la luce il punto di
partenza della colpa.
Il momento della perdita. Come Orfeo che si volta a guardare Euridice: aveva
promesso di non farlo fino a quando tutti e due fossero in salvo, ma il dubbio
che lo stia seguendo soltanto l’ombra della donna amata, e non lei per davvero,
lo spinge a voltarsi. E così la perde per sempre.
Ma il fatto è che Psiche non perderà Amore per sempre. E allora chissà
perché nell’immaginario si è fermato il dolore e non la felicità, visto che la
favola di Apuleio finisce molto bene.
Nel momento che tutti ricordiamo – che poi è il momento grazie al quale
quella favola esiste e ha avuto fortuna, il momento intorno al quale Apuleio fa
ruotare non solo il senso della favola che racconta, ma anche tutto il senso del
libro a cui quella favola appartiene, e cioè L’asino d’oro –, nel momento in cui
Psiche rompe il patto con Amore, la situazione della sua vita è la seguente: non
sa chi sia l’amante che giace con lei tutte le notti, con cui si sente pure felice,
ma la promessa che ha fatto le fa crescere nell’animo (grazie anche alla spinta
delle sorelle invidiose) il dubbio di accoppiarsi ogni notte con un mostro, al
quale oltretutto sarebbe stata destinata; ha (appunto) due sorelle invidiose e
terribili che cospirano contro la sua felicità e soprattutto contro la sua
sterminata ricchezza; non sa che sua suocera è Venere, e nemmeno Venere
sospetta che suo figlio si sia innamorato di una comune mortale, e se lo sapesse
diventerebbe piuttosto aggressiva; Psiche in definitiva non sa di essere in una
situazione eccezionale, e quindi non può godersela fino in fondo. Non si può dire
che sia in una situazione di serenità o appagamento.
Dopo l’atto di tradimento, e dopo aver attraversato un percorso di sofferenza,
necessario a ogni sacrificio, una sofferenza che comprende la delusione di
Amore e la rabbia di Venere, si ritrova in questa situazione finale: si sposa con
Amore, Venere si placa, le sorelle si buttano dalla rupe e si sfracellano al suolo,
beve il siero dell’immortalità e diventa una dea e – per la gioia di tutti noi –
nasce una figlia meravigliosa dal nome Voluttà.
Non male.
Eppure, la memoria, il nostro immaginario, la rappresentazione artistica,
tutto è concentrato sul momento del tradimento. Il resto della favola ci interessa
meno. Come se l’unico valore che possiamo attribuire all’amore fosse tragico,
in un modo in cui il dolore abbia un valore indelebile e la felicità appaia sempre
trascurabile. Bisogna rassegnarsi: così sono gli esseri umani.
Come se tutte le favole dovessero per forza di cose arrivare a un amore
eterno, ma essendo una convenzione, diventa immediatamente trascurabile. Del
resto, anche per Apuleio, come abbiamo detto, quella di Amore e Psiche è una
favola negativa– cioè, anche per lui il lieto fine è un evento trascurabile, nella
funzione che la favola deve avere all’interno del progetto-libro. È possibile che
questa storia se la sia inventata lui, tra l’altro. Non è sicuro, ma non è escluso.
E lo ha fatto per raccontarla nel bel mezzo di un libro intitolato Le metamorfosi,
che poi Sant’Agostino indica nel De Civitate Dei come Asinus aureus. L’asino
d’oro.
All’inizio della vicenda, un giovane chiamato Lucio, appassionato di questioni
come magia o soprannaturale, si trova in Tessaglia, paese delle streghe. È
ospite in casa del ricco Milone, la cui moglie Panfila esercita di nascosto le arti
della magia. Lucio giace qualche volta con la serva Fotide, che una notte gli
permette di spiare la sua padrona che grazie a un unguento si trasforma in
uccello e vola via. Lucio – spinto da un’incontrollabile curiosità – decide di
imitarla. Ma usa l’unguento sbagliato. E così viene trasformato in asino, pur
conservando la facoltà umana di pensare e di sentire. L’antidoto ci sarebbe:
delle rose che Lucio deve mangiare per sciogliere l’incantesimo. Ma uno dei
motivi per cui quest’opera di Apuleio è ritenuta un romanzo sta proprio nel fatto
che prima che riesca a riprendere sembianze umane, Lucio deve attraversare
lunghe e dolorose traversie.
Durante una di queste, in una caverna di briganti, Lucio ascolta la lunga e
bellissima favola di Amore e Psiche, narrata da una vecchia a una fanciulla
rapita dai malviventi. La favola viene raccontata da Apuleio, dal narratore (che
è lo stesso Lucio), dalla vecchia, con identica intenzione: dimostrare che la
curiosità ha conseguenze disastrose. A Lucio, prima che si trasformasse in
asino, sono già state raccontate due lunghe storie nelle quali in pratica lo si
diffidava da una eccessiva curiosità per le arti magiche. Non avendone fatto
tesoro, era stato condannato. Lucio, insomma, ha già commesso l’errore che
commetterà Psiche. Il vizio della curiosità. Lo stesso vizio che avvolgerà Psiche
non una, ma ben due volte durante il corso di questa storia. E la natura
esemplare della storia sta nella condanna della curiosità. Quindi, il fatto che
nell’immaginario dei secoli successivi il valore stia nel dolore causato dal
tradimento del patto da parte di Psiche, è nelle intenzioni dell’autore. Psiche
non imparerà nulla dalla sofferenza che provoca la sua curiosità, visto che
poche pagine dopo, in un momento delicato, commetterà un errore identico: è
una – anzi, l’ultima – delle prove cui Venere la sottopone per tortura, per
vendetta, e infine, più o meno inconsapevolmente, per capire e far capire a noi
lettori che questa donna bellissima ha le qualità, il coraggio, la fortuna e la
sfacciataggine per diventare la dea che diventerà. Venere la spedisce agli inferi
a prendere da Proserpina «un poco della tua bellezza, almeno quanta ne serve
per una sola breve giornata». Psiche, tra mille peripezie, riesce a ritornare
dagli inferi con il vasetto, ma la tentazione di usare un po’ di bellezza anche per
lei, per apparire ancora più bella quando Amore la vedrà, la spinge ancora una
volta a curiosare: apre il vasetto. Dentro non vi trova la Bellezza, ma un sonno
infernale, dal quale infine potrà salvarla solo Amore.
Che lo farà. E quindi anche il secondo errore, a dire il vero, non determinerà
un finale tragico.
Perché noi tutti siamo Psiche? Questa è la domanda fondamentale che
dobbiamo porci, noi lettori di oggi. Per appassionarci alla favola d’amore basta
e avanza la favola in sé, la strada che congiunge l’inizio alla fine. Ma per farci
sentire in sintonia con Psiche, ci vuole qualcosa in più. E c’è. È la sua
condizione di essere umano qualunque – certo, è bellissima, ed è per questo
motivo che viene scelta per avere a che fare con una prova così difficile, ma,
almeno all’inizio, non è più che un essere umano normale – di qualità speciale,
ma non più di un essere umano. Ecco: questa donna normale si avvia ad
affrontare una storia tra divinità e mostri, in cui il quesito della sua esistenza
futura, che alla fine non si sentirà di ignorare, è se il suo corpo e la sua
passione vengano donati tutte le notti a un essere divino o a un essere
mostruoso. Che poi è la domanda che chiunque di noi si è fatto, svegliandoci
una (o probabilmente, più di una) notte, osservando accanto la persona amata
che dorme, e con la complicità delle ore buie, che rendono sopra le righe tutti i
sentimenti e le preoccupazioni, le paure, le angosce e il senso profondo della
vita, ci siamo chiesti, mentre vedevamo il torace gonfiarsi e sgonfiarsi in modo
regolare: chi è questo essere umano a cui sto concedendo il mio amore, le mie
giornate, il mio futuro? È l’essere speciale che mi sembra di aver intuito o è un
mostro che mi sembra di temere?
Psiche non lo sa; ma quel che è peggio, è che le è stato chiesto di non
scioglierlo, questo dubbio.
Prova a resistere alla curiosità; ma non resisterà. Così, alla fine scioglierà il
dubbio e per lei la differenza tra il divino Amore e il serpente mostro sarà netta
(grazie al cielo, tutta a favore del primo). Invece, per quanto ci riguarda – ed è
il motivo fondamentale per cui la favola di Amore e Psiche ci sta ancora così
tanto a cuore – lo scioglimento del dubbio rimane più difficile. Deve essere
questo il sentimento liberatorio che proviamo quando Psiche decide di guardare
il volto del suo amore misterioso. Perché noi, pur sapendo che non deve farlo,
nel più profondo del nostro cuore speriamo che lo faccia. Così almeno lei potrà
capire. Visto che a noi pare sia stato assegnato – o possa essere assegnato – un
destino diverso: e cioè che quella lampada non illuminerà mai abbastanza, non
farà mai totale chiarezza, al massimo suggerirà, ma sarà sempre come stare in
penombra. Non ne saremo mai sicuri. Così accade a noi, oppure così temiamo
possa accadere a noi (che in fondo fa lo stesso).
Per questo motivo siamo così appassionati e complici di Psiche: perché lei
chiarisce una volta per tutte ciò che a noi forse non sarà mai chiaro in modo
definitivo.
Questo è il punto centrale, anche se sotterraneo, potremmo dire quasi
inconscio, in cui la favola di Amore e Psiche e la condizione attuale del mondo
comunicano ininterrottamente. Quello che forse più evidentemente ci riguarda –
e, ripetiamo, poiché è evidente, passa sotto traccia, senza che ne avvertiamo la
sostanza. Il mondo, tuttora, e forse anche di più, è composto da divinità da una
parte, da mostri dall’altra. E in mezzo ci siamo noi esseri umani. E ancora di
più, oggi, i mostri e le divinità si confondono in modo incomprensibile e
numeroso, tanto che noi esseri umani siamo degli inabili Psiche che giriamo
sempre con la lanterna accesa, ma il nostro problema è che non si vede poi
tanto la differenza tra la bellezza di Amore e le mostruose spire del serpente. La
società ha costruito un mito doppio, sempre costante, quasi dopato. Molti esseri
umani sono fanaticamente alla ricerca dell’identificazione con la divinità, che è
un modo per diventare divinità essi stessi, e qualcuno, se non ci riesce, pur di
non limitarsi a restare essere umano, dà la sua disponibilità a trasformarsi in
mostro. Così procedendo, i due estremi si confondono, e confondono chi rimane
in mezzo, frastornato: l’essere umano normale.
Nonostante le intenzioni di Apuleio, quindi, siamo dalla parte di Psiche.
Perché vuole sapere, vuole conoscere fino in fondo. Perché non si accontenta di
una felicità insperata –un grande palazzo dove abitare, ricchezze senza fine, e
un amore notturno che le dà soddisfazione. Vuole sapere tutto, non resiste, è
debole come un essere umano e assetato di conoscenza come un essere umano.
Vuole, in più, accogliere le sorelle per mostrare e raccontare.
E qui sta la differenza tra Psiche e le sorelle. Prima di arrivare al rischio
definitivo, quello che Psiche si prende decidendo di illuminare il volto
dell’amante misterioso, il racconto passa per un altro rischio, che lo riguarda
direttamente: quello dell’assenza di narrazione. Quando le due sorelle fanno
visita al palazzo, si rendono conto della fortuna di Psiche, e mettono in moto il
sentimento dell’invidia. E cosa produce questo sentimento, come primo atto?
L’assenza del racconto. Come possono contrastare la felicità di Psiche, prima
ancora di instillare in lei il dubbio fatale, che porterà prima al dolore
insopportabile e poi alla felicità più alta e definitiva? Non dicendo a nessuno ciò
che hanno visto: «Non sono veramente felici quelli di cui nessuno conosce la
felicità».
È vero. Ma è più profondamente vera l’essenza a cui conduce l’intuizione: se
non c’è racconto, non c’è vita. Se la felicità o l’infelicità di Psiche non arrivano
fino a noi tramite la forma narrazione che attraversa secoli e secoli, Psiche
svanisce nel nulla. E con questa conclusione, le sorelle infatti tentano di
condurre la favola nel dirupo dell’autodistruzione. Se la loro operazione fosse
riuscita, nemmeno noi sapremmo nulla, né di Psiche né di Amore né di Venere
né delle sorelle.
Ma le favole, le storie, trovano in sé persino il valore dell’indicibile. E con un
colpo di coda, la favola riagguanta il sentimento dell’invidia e lo fa crescere
ancora, lo fa lievitare fino al punto in cui la mancanza di racconto non basta più
alle sorelle, ma viene voglia di aggiungere una volontà di distruzione della
felicità di Psiche. È l’errore che commettono. La distruzione, invece di
distruggere il racconto, lo alimenta. Lo salva. Lo tira via dal nulla. Quindi, il
racconto si salva dall’autodistruzione, con la volontà di distruzione dei
personaggi “cattivi”, che ritorna a essere narrazione viva. E mette in moto tutto
il resto. Mette in moto, attraverso l’invidia, il dubbio; e attraverso il dubbio, la
curiosità. E non ci sarà più modo di arrestare il tramandarsi della favola di
Amore e Psiche.
A proposito del disinteresse del genere umano per il lieto fine, la questione
della curiosità è molto interessante. Per concludere, possiamo ridefinire la
percezione iniziale di una favola dolorosa nonostante tutto, formulando
un’ipotesi che muova dal seguente assunto, sia ipotetico sia estetico: chissà
quanti Orfeo hanno avuto la forza di non girarsi a controllare che davvero
Euridice li stesse seguendo. Chissà quante Psiche si sono lasciate inebriare da
prodezze sessuali notturne con l’amante sconosciuto, senza avere voglia di
capire davvero chi fosse. Il risultato di quel coraggio, di quella fiducia, di quella
mancanza di curiosità, è semplice, definitivo, sorprendente: le loro vicende non
sono diventate narrazioni. Sono state valutate come trascurabili dalla
letteratura. Un altro modo, più virtuoso, quasi eroico, di distruggere la
narrazione. Così la letteratura dimostra di essere fatta di curiosità e debolezza.
Di un ingrediente composto da curiosità e debolezza. A prescindere dal fatto che
poi le cose vadano a finire male o bene. Ha bisogno, la letteratura, di
raccontare il cedimento, fosse anche, come è per Apuleio, per renderlo
esemplarmente negativo. E in qualche modo la letteratura – più forte della
volontà di chi la fa – soddisfa a tal punto questo desiderio di cedimento, che la
sua negatività diventa l’unico elemento interessante dell’amore; oppure,
addirittura, finisce per non essere negativa. Quasi quasi, diciamo noi che
leggiamo, se Orfeo non si fosse girato, se Psiche non avesse tentato di
conoscere, allora noi non avremmo creduto alla forza del loro amore. Come se
l’amore forte si esprimesse soltanto attraverso la debolezza. Ed è per questo
motivo, supponiamo, che ci consola di una storia d’amore solo la parte più
dolorosa, e ci disinteressiamo del lieto fine.
FRANCESCO PICCOLO