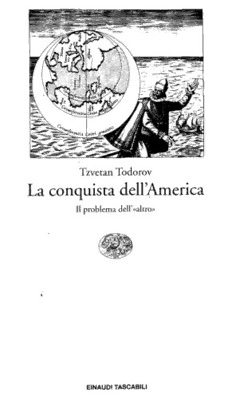Table Of ContentTzvetan Todorov
La conquista dell'America
Il problema dell' «altro»
EINAUDI TASCABILI
Dello stesso autore nel catalogo Einaudi
Critica della critica
I formalisti russi
Michail Bachtin
Noi e gli altri '
Racconti aztechi della Conquista
(con G. Baudot)
Le morali della storia
Tzvetan Todorov
La conquista dell‘America
Il problema dell‘«altro»
Nota introduttiva di Pier Luigi Crovetto
Einaudi
Titolo originale La conquete de l'Amérique. La question de l'autre
© 1982 Éditions du Seui!
© 1984 e 1992 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino
Prima edizione« Saggi,. 1984
Traduzione di Aldo Serafini
ISBN 88-06-12826-4
Indice
p. VII Nota introduttiva di Pier Luigi Crovetto
Parte prima Scoprire
5 La scoperta dell'America
17 Colombo ermeneuta
41 Colombo e gli indiani
Parte seconda Conquistare
6 5 Le ragioni della vittoria
77 Moctezuma e i segni
120 Cortés e i segni
Parte terza Amare
155 Comprendere, prendere e distruggere
177 Eguaglianzaoineguaglianza
204 Schiavismo, colonialismo e comunicazione
Parte quarta Conoscere
2 2 5 Tipologia dei rapporti con l'altro
246 Duran, o l'ibridazione delle culture
267 L'opera di SahagUn
Epilogo
297 La profezia di Las Casas
3II Nota bibliografica
Indice delle illustrazioni
?· 9 I. Navi e castelli nelle Indie occidentali.
In Epistoltl Cbristofori Colombi, Base! 1493. (Biblioteca N02ionale, Parigi).
2. Cristoforo Colombo
In Honorius Philoponus, Nova typis transacta nflfJigatio noui orbis Indiae Occi·
denta/is, Venezia 1621. (Biblioteca Nazionale, Parigi).
45 3· Colombo sbarca ad Haiti, incisione di Théodore de Bry.
In Americae pars quarta, Frankfurt 1;194. (Biblioteca N02ionale, Parigi).
79 4· Consulta2ione del libro divinatorio.
In Codice fiorentino, VI, 36. (Biblioteca Laurenaiana, Firenae).
I25 5· Doiia Marina tra Cortés e gli indiani.
In Uenzo de Tlaxcala, Antiguedades Mexicanas, México 1892.
I49 6. Il massacro perpetrato da Alvarado nel tempio di Città del Messico.
In D. Duran, Historia de las Indias de Nuew Espaiia .•• , México 1967.
I 59 7· Uno degli acrobati a2techi portati da Cortés alla corte di Carlo V,
disegno di C. Weidit2.
In Das Trachtenbucb uon Cbristopb Weiditz, Berlin 1927. (Biblioteca Nazionale,
Parigi). ·
I7I 8-9. Le crudeltà degli spagnoli, illustra2ioni di Théodore de Bry.
In B. de Las Casas, Breuisima relaciOn (trad. latina), Frankfurt 1;198. (Biblioteca
Nazionale, Parigi).
I93 Io. Uso delle pelli scuoiate.
In Codice fiorentino, II, 21. (Biblioteca Laurenaiana, Firenae).
2I5 II. Diego Rivera, Cortés e Las-Casas, affresco.
Palazzo N112ionale, Città del Messico.
2I9 I2. Scena di cannibalismo.
In Codice fiorentino, IV, 9· (Biblioteca Laurenaiana, Firenae).
22 7 I 3-I4. Sacrifici umani.
In Codice fiorentino, II, Appendice. (Biblioteca Laurenaiana, Firenae).
263 15. Ritratto di Moctezuma.
In Manoscritto Touar, John Carter Brown Library, R.I., Usa.
287 r6. Il serpente acquatico.
In Codice fiorentino, XI,,. (Biblioteca Laurenaiana, Firenae).
Nota introduttiva
La riproposta, a dieci anni dall'uscita per le Editions du
Seui! e a sette dalla prima traduzione italiana, di La conqui
sta dell'America·è occasione per rivedere alcuni dei giudizi af
frettati quanto ingenerosi di allora. Principale capo di impu
tazione a carico di Tzvetan Todorov, quello di aver sconfi
nato in territori altrui: un'accusa, insomma, di leso speciali
smo, di usurpazione delle competenze degli storici della
Conquista. A partire di qui, in molti procedettero a segnala
re errori e imprecisioni, insufficienti «contestualizzazioni»,
improvvide semplificazioni e omissioni, e via distinguendo
e censurando. Gli inviti a valutare il libro iuxta propria prin
cipia, suonarono cosi come voci e petizioni isolate.
E tuttavia appare oggi ancor piu chiaramente di allora che
il senso del libro di Todorov è un altro. Non una storia della
conquista dell'America (non fosse che per quella intenziona
le riduzione del campo di indagine all'ambito messicano, con
il sacrificio dell'area andina, segnata da una ben altrimenti
risoluta resistenza all'invasore) quanto una «storia della sco
perta che l'io fa dell'altro» (p. 5). Che Todorov abbia rivolto
la sua attenzione alle isole antillane, agli altipiani dell' Ana
huac e agli eventi che vi si svolsero negli anni che segnano
l'entrata «in questo nostro tempo cosi nuovo e cosi diverso
da ogni altro» (la definizione è tratta dalla Historia de las In
dias di Las Casas) è conseguenza del fatto che proprio allora,
su quegli scenari, si verificò «l'incontro piu straordinario
della storia occidentale», quello con l'« altro assoluto», con;<
il «diverso » per eccellenza. Che poi a questo evento l'autore
si accosti in veste piu «di moralista» che «di storico» dipen-
vm Pier Luigi Crovetto
derà segnatamente dall'esito di quell'impatto: «il piu grande
genocidio della storia dell'umanità» (p. 7), una sorta di an
ticipazione dei massacri di cui è costellata la storia della co
lonizzazione delle periferie del mondo. Nessuno stupore se
la storia diviene a pieno titolo esemplare, percorsa da com
mozione, indignazione e ammonimenti.
Alla luce di quanto detto, La conquista dell'America va
considerata per quello che è (e che il sottotitolo Il problema
dell'« altro» designa): parte di una tetralogia, dopo Il princi
pio dialogico del I 98 I, e prima dei Racconti aztechi della
Conquista del I983 (tr. it. Einaudi, I988) e del recentissimo
Noi e gli altri (sottotitolo: La riflessione francese sulla diversità
umana) del I989 (tr. it. Einaudi, I99I). Tetralogia che si
apre ne! nome di Michail Bachtin e nel segno del «dialogi
smo». E sintomatica, a precisare il ruolo dell'« altro» nel
«compimento dell'autocoscienza individuale», una citazione
da L 'autore e il personaggio nell'attività estetica, scritto dallo
studioso russo tra il I922 e il I924: «tutto ciò che tocco-a
cominciare dal mio stesso nome - perviene alla mia coscien
za dal mondo esterno, passando attraverso la bocca degli al
tri, con la loro intonazione, la loro tonalità emozionale, e i
loro valori. Inizialmente non prendo coscienza di me se non
attraverso gli altri...». Concetto che Bachtin precisa nel Do
stoevski;: «L'essere dell'uomo è una comunicazione profon
da. Essere significa comunicare. Essere significa essere per
l'altro e, attraverso l'altro, per sé. L'uomo non possiede un
territorio "interno" sovrano. Egli è integralmente e sempre
su una frontiera: guardando dentro di sé, guarda negli occhi
altrui o attraverso gli occhi altrui. Non posso fare a meno
dell'altro, non posso divenire me stesso senza l'altro».
Ora, per Todorov, quel che vale per gli individui, vale an
che per i gruppi (interni a una società o coincidenti con so
cietà distinte). Nel dialogo e nella comunicazione con l'I
slam, con l'Estremo Oriente e piu determinatamente con il
Nuovo Mondo, la cultura occidentale conquista piena co
scienza di sé e rappresenta il proprio passaggio da uno stadio
Nota introduttiva IX
«insulare» a uno «relazionale». È in forza di ciò che la sua
storia mitic~, fondata sul presupposto della centralità del suo
soggetto («E caratteristico di essa il fatto che il mondo reale
dell'esperienza sia interamente circondato da un mondo im
maginario abitato da dèi sovrumani da un lato e da mostri
subumani e innaturali dall'altro: uomini dalla testa di cane,
uomini con la coda, amazzoni, cannibali, giganti», E. Leach,
«Anthropos», in Enciclopedia Einaudz), diviene laica e poli
centrica. La storia della Conquista si converte cosi in una in
trigante avventura semiotica. I cui esiti si giocano anche, se
non soprattutto, nei termini di un «dialogo» con l'altro e nel
sempre piu pieno riconoscimento della sua «diversità e auto
nomia». Un dialogo che, attraverso quella forma superiore
di egualitarismo che è il prospettivismo lascasiano («nel qua
le ognuno ~ messo in ra~porto co!l i v~~pri, anzic?é e~
sere comrrusurato a un Ideale umco », !(>: ~32ft condurra a fi
ne secolo all'inquietante relativismo dètfJél'infinito, univer
so e mondi di Giordano Bruno: «"Cossi non è piu centro la
terra che qualsivoglia altro corpo mondano, e non son piu
certi determinati poli alla terra che la terra sia un certo e de
terminato polo a qualch' altro punto dell'etere e spacio mon
dano; e similmente de tutti gli altri corpi; li quali medesimi,
per diversi riguardi, tutti sono e centri e punti e zenithi ed
altre differenze. La terra, dunque, non è assolutamente in
mezzo all'universo, ma al riguardo di questa nostra reggio
ne" (Dialogo II). Non solo la terra-annota Todorov-non
è piu il centro dell'universo, ma nessun punto fisico lo è; la
stessa nozione di centro ha senso solo in relazione ad un pun
to di vista particolare: centro e periferia sono nozioni pura
mente relative, come quelle di civiltà e di barbarie (e ancor
piu di,queste). "Nell'universo non è mezzo né circonferenza,
ma, se vuoi, in tutto è mezzo ed in ogni punto si può prende
re parte di qualche circonferenza a rispetto di qualche altro
mezzo o centro" (Dialogo V)» (pp. 233-34).
Come riuscirono sparute minoranze di europei ad aver ra
gione di immense moltitudini? A questo proposito, gli storici
forniscono le loro ineccepibili spiegazioni: il peso delle armi
x Pier Luigi Crovetto
da fuoco, il ruolo dei cani e dei cavalli, in generale uno squi
librio tecnologico a favore degli invasori; da ultimo, le pro
fonde divisioni in campo indigeno, che consentirono al con
quistador di guadagnare alla propria causa legioni di alleati.
In aggiunta a tutto ciò, Todorov sottolinea con particolare
vigore lo «scarto» nella «percezione» degli avversari. li fatto
è - argomenta - che gli europei parvero agli indigeni d'A
merica, immersi nella loro «intransitiva» insularità, esseri
sovrumani, stravaganti centauri («alcuni credettero che ca
vallo e cavaliere fossero una sola persona»), reincarnazioni
o figure del dio civilizzatore Quetzalcoatl, partito verso
Oriente e di cui si attendeva come prossimo il ritorno. Non
sarà un caso se, al disorientamento che consegue a questa
usurpazione di prerogative divine da parte degli stranieri,
corrisponderà la caduta di decifrabilità del mondo («La com
prensione è perduta, la saggezza è perduta», Chilam Balam),
l'improvvisa afasia dei libri sacri («Chi sarà il profeta, chi sa
rà il sacerdote che rivelerà il vero senso della parola contenu
ta in questo libro?», la renitenza degli dèi a favorire il riscat
to di un universo avvilito («Essi chiesero loro di assisterli e
conceder loro la vittoria sugli spagnoli e sugli altri loro nemi
ci. Ma doveva essere troppo tardi, perché non ebbero piu ri
sposta dai loro oracoli; pensarono allora che gli dèi fossero
diventati muti o fossero morti» (pp. 75-76).
Un libro profondamente «dialogico» nella sua struttura
profonda, dunque; e che si presenta dialogico anche in su
perficie. A colloquiare tra loro sono i testi, a volte noti, so
vente tratti da archivi polverosi e inaccessibili. E un libro,
inoltre, serratamente strutturato: diviso in quattro parti, in
titolate con quattro predicati in serie ascendente: «scopri
re», «conquistare», «amare», «conoscere». Per ciascuno di
essi, un soggetto esemplare: Cristoforo Colombo incarna la
«figura» dello scopritore, Hernan Cortés quella del conqui
statore; quindi Bartolomé de Las Casas, difensore degli in
digeni, e infine Duran e Sahag6n, religiosi etnologi tra i tanti
che nel primo secolo dopo la conquista spirituale si dedicaro
no a raccogliere i reperti del patrimonio delle culture sconfit-