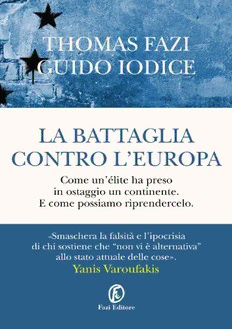Table Of ContentLe terre
237
2
I edizione digitale: marzo 2016
© 2014 Thomas Fazi
First published by Pluto Press, London
© 2016 Fazi Editore srl
Via Isonzo 42, Roma
Tutti i diritti riservati
Titolo originale: The Battle for Europe: How an Elite Hijacked
a Continent – and How We Can Take It Back
ISBN: 978-88-9325-014-6
www.fazieditore.it
www.facebook.com/fazieditore
@FaziEditore
www.youtube.com/EditoreFazi
Google plus Fazi Editore
3
Thomas Fazi - Guido Iodice
LA BATTAGLIA
CONTRO L’EUROPA
4
Indice
Prefazione
Introduzione
1. Le vere cause della crisi europea
2. Le conseguenze economiche di Angela Merkel
3. Una via d’uscita dalla crisi
5
LA BATTAGLIA CONTRO L’EUROPA
6
Prefazione
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla
vostra sete di totale devastazione andate a frugare anche il
mare. Avidi se il nemico è ricco e arroganti se è povero.
Gente che né l’Oriente né l’Occidente possono saziare.
Solo voi bramate possedere con pari smania ricchezza e
miseria. Rubano, massacrano, rapinano, e con falso nome
lo chiamano impero. Rubano, massacrano, rapinano, e con
falso nome lo chiamano nuovo ordine. Laddove fanno il
deserto, lo chiamano pace.
PUBLIO CORNELIO TACITO
Parafrasando Tacito, potremmo dire: «Hanno fatto un deserto e ora la
chiamano ripresa». A otto anni dallo scoppio della crisi finanziaria, l’Europa è
stremata dall’austerità, dalla stagnazione economica, da disuguaglianze sempre
più gravi e dal crescente divario tra paesi del centro e della periferia. La stessa
parola “crisi”, che rimanda a un fenomeno di rottura e di breve periodo, è ormai
inadeguata a descrivere quello che appare come un cambiamento strutturale –
ma forse sarebbe meglio dire una ristrutturazione deliberata – dell’economia e
della società. La democrazia viene esautorata a livello nazionale e non viene
sviluppata a livello europeo. Il potere è sempre più concentrato nelle mani di
istituzioni tecnocratiche che non rispondono delle loro decisioni e in quelle dei
paesi più forti dell’Unione. Allo stesso tempo, cresce in tutto il continente
un’ondata di populismo, con l’affermarsi in alcuni paesi di pericolosi movimenti
nazionalisti. Eppure non vi è ancora un consenso – non dico a livello
mainstream, ma neanche a sinistra – sulle ragioni che ci hanno condotto fino a
questo punto, e su come uscirne. Uno dei motivi che mi hanno spinto a iniziare
l’edizione inglese di questo libro (The Battle for Europe, Pluto Press), nell’estate del
2012, era precisamente la mancanza di un’analisi esaustiva, critica e accessibile
di quello che stava accadendo, che fosse in grado di integrare in un unico
quadro analitico le diverse crisi che componevano “la crisi”. Per come la vedevo
– e per come la vedo ancora oggi –, si trattava di un problema politico ancor
prima che teorico: il fatto che le politiche di austerità imposte
dall’establishment europeo, che sarebbero state impensabili solo qualche anno
prima, incontrassero relativamente poca resistenza poteva imputarsi in buona
parte all’incapacità dei cittadini di comprendere le dinamiche in corso. E
7
dunque di reagire. Oggi non si può certo dire che le cose siano migliorate. Anzi:
per certi versi sono addirittura peggiorate. Il perdurare della crisi economica e la
vergognosa gestione della vicenda greca hanno sì trasformato la crisi in un
argomento di dibattito diffuso – e questo è senz’altro un elemento positivo –,
ma hanno anche determinato un progressivo imbarbarimento del dibattito
pubblico, sempre più dominato da logiche nazionalistiche («prima gli italiani») e
semplificazioni illusorie e solo apparentemente radicali («fuori dall’euro»). Nel
frattempo molti dei miti fondativi alla base del “regime di austerità” –
dobbiamo stringere la cinghia perché stiamo finendo i soldi; abbiamo vissuto al
di sopra delle nostre possibilità; il problema è l’eccessivo debito pubblico ecc. –
si sono persino rafforzati. Per quanto mi riguarda, rispetto a quando è uscita
l’edizione inglese, a inizio 2014 – e dunque rispetto ad alcune delle proposte in
essa avanzate –, sono diventato molto meno ottimista sulla capacità dei
movimenti europei antiausterità di ottenere un cambio di rotta senza un
ribaltamento radicale degli equilibri politici nei singoli Stati membri e
nell’eurozona nel suo complesso. Pur criticando la superficialità di certe
posizioni che potremmo definire “neosovraniste”, riconosco che è necessario un
riposizionamento da parte di tutti coloro che – come me – si sono a lungo
identificati in una posizione di “Europa democratica e di sinistra” che
immagina(va) di poter riformare l’eurozona e l’Unione Europea in una direzione
più democratica e progressista (keynesiana). Da un lato bisogna prendere atto
che i tedeschi (e la loro galassia) non saranno mai disposti ad accettare – almeno
nel breve termine – una riforma dell’eurozona in questo senso. Dall’altro, però,
bisogna anche ribadire che l’uscita individuale e unilaterale di un singolo paese
(come può essere la Grecia, ma lo stesso discorso vale anche per l’Italia), al fine
di recuperare la tanto agognata “sovranità monetaria”, rimane una pericolosa
illusione nel momento in cui i rapporti di forza sono fortemente sbilanciati –
ovunque – a favore del capitale e in cui la deflagrazione incontrollata della zona
euro rischierebbe di precipitare l’Europa e l’economia globale nel caos
finanziario, in quella che Barry Eichengreen ha definito una «Lehman al
quadrato». In questa fase, dunque, la prospettiva per chiunque voglia allargare
nuovamente la sfera pubblica al fine di rilanciare l’occupazione e gli
investimenti non può che essere quella di trasformare i rapporti di forza – sia
all’interno dei singoli paesi che tra i paesi stessi – per riuscire a incidere sui
processi reali invece di subirli passivamente (a prescindere dall’obiettivo
strategico che uno si dà). Il che vuol dire che il lavoro che ci aspetta è lungo e
faticoso, e che non esistono scorciatoie o soluzioni miracolistiche. In
quest’ultimo anno e mezzo, ho anche approfondito alcuni aspetti della crisi e
cambiato opinione su altre questioni. Considero dunque la presente edizione
italiana – rivista, approfondita, aggiornata e adattata per l’Italia insieme a Guido
8
Iodice, cofondatore e animatore del sito Keynes blog, con cui ho intrecciato nel
tempo un proficuo scambio intellettuale, a partire dalla nostra comune
ammirazione per il celebre economista britannico – un importante passo avanti
rispetto all’originale. E, sperabilmente, l’inizio di un percorso comune con tutti
coloro che, come noi, non hanno nessuna intenzione di morire “austeriani”.
THOMAS FAZI
Gennaio 2016
9
Introduzione
Si narra che quando il ministro delle Finanze di Luigi XIV di Francia, Jean-
Baptiste Colbert, chiese a un gruppo di mercanti – oggi diremmo di
imprenditori –– cosa avrebbe potuto fare il governo per aiutare il commercio,
uno di loro, chiamato Legendre, abbia risposto semplicemente: «Lasciateci fare».
L’espressione laissez faire, che oggi in Italia traduciamo con ‘liberismo’, divenne
da allora sinonimo di libertà di impresa, libero commercio e Stato minimo,
contrapposta alle idee di Colbert e dei mercantilisti, che vedevano invece per lo
Stato un ruolo attivo e interventista in campo economico. La vulgata vuole
quindi che i liberisti siano coloro che si oppongono alle barriere doganali, alle
tasse, alle regolamentazioni eccessive e, soprattutto, alla spesa pubblica.
Generazioni di economisti, filosofi, politici, hanno sviluppato una dottrina
secondo la quale meno lo Stato si occupa di economia, più questa sarà capace di
prosperare da sola. Il ruolo del pubblico, al più, consiste nel garantire i contratti
attraverso l’applicazione del codice civile e nell’occuparsi della polizia a difesa
della proprietà. Eppure, a ben vedere, vi è un abisso tra la dottrina e la pratica.
Un abisso che è diventato talmente evidente tra il 2007 e il 2008 da non poter
essere più nascosto.
Quando la crisi scatenata dallo scoppio delle bolle immobiliari negli Stati
Uniti e in Europa ha cominciato a far crollare, una dopo l’altra, banche piccole
e grandi, quasi tutti coloro che fino al giorno prima avevano predicato il ritiro
dello Stato dalla sfera economica si sono dovuti barcamenare per giustificare i
salvataggi bancari di quegli istituti too big to fail, troppo grandi per fallire. L’Italia
è stata solo marginalmente sfiorata dal fenomeno, eppure anche da noi, di
fronte al possibile fallimento di Monte Paschi, i campioni del liberismo Michele
Boldrin e Oscar Giannino si appellarono al governo addirittura per
nazionalizzare la storica banca senese. Qualcuno, invero, cercò di tenere il
punto. Quando nel settembre del 2008 il governo americano “lasciò fare” e
Lehman Brothers fallì, l’economista italiano Francesco Giavazzi scrisse che
quello era un bel giorno per il capitalismo. Il contagio finanziario globale che ne
seguì dimostrò al di là di ogni ragionevole dubbio che Giavazzi sbagliava e che
l’errore del “lasciar fare” e del permettere che una banca diventi troppo grande
non può essere corretto lasciando fare ancora e permettendo che essa fallisca. In
altre parole, il mercato non si ripara da solo.
Ma è l’origine stessa della crisi finanziaria del 2008 che risulta, a un’analisi
10