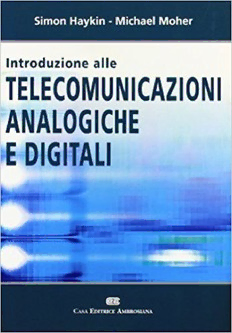Table Of Content&LL&J m•.m.rnrn rma;; I U
POOTECNICO DI BARI
Fmà d'ingegneria
BIBLIOTECA
.J.V.. ., ..
Arnmio .
)3
~!.to .......... ...
{1td
Val.N . ...
TELEC U IC ZI NI
l ICHE
E I IT LI
···--., __
Titolo originale: !ntroduction to Anafog and Digitai Communications, second ed.
All Rights Reserved. This translation published under license.
Copyright© 2007 John Wiley & Sons, lnc.
Copyright per l'edizione italiana© 2007 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche)
sono riservati per tutti i paesi.
Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) possono essere effettuate,
nel limite del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto
dal'art. 66, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tal/ fotocopie possono essere
effettuate negli esercizi commerciali convenzionati SIAE o con altre modalità indicate da SIAE.
Per riproduzioni ad uso non personale (per esempio: professionale, economico o commerciale)
l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine
non superiore al 15% delle pagine del presente volume.
Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno Inoltrate a:
Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione
delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
Corso di Porta Romana 108
20122 Milano
e-mail: [email protected] e sito web: www.aidro.org
~editore, per quanto di propria spettanza, considera rare !e opere fuori del proprlo catalogo editoriale.
La riproduzione degli esemplari esistenti nelle biblioteche di tal/ opere è consentita, non essendo
concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo
dell'editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.
Traduzione: Gennaro Boggia, Cataldo Guaragnella, Piero Guccione (cap. da 1 a 5)
Gabriella Saddemi (cap. da 6 a 11 e appendici)
Revisione: Ciro Cafforio (cap. da 1 a 5), Emilio Matricciani (cap. da 6 a 11 e appendici)
Realizzazione editoriale: Epitesto, Milano
Impaginazione: BaMa, Vaprio d'Adda (Ml)
Copertina: Luca Ronca
Prima edizione: luglio 2007
Ristampa
4 3 2 o 2007 2008 2009 2010 2011
..
Realizzare un libro è un'operazione complessa, che richiede numerosi controlli: ~
sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra loro. L'esperienza
suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori.
Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro rivolgersi a:
C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana
via Gargano 21, 20139 Milano
fax 02 52202260
e-mail: [email protected]
Sul sito www.ceaedizioni.it è possibile verificare se sono disponibili errata corrige per questo volume.
Accedendo, attraverso il menu sulla sinistra, alla pagina Per l'università, è possibile visualizzare l'elenco
dei volumi per i quali è disponibile un errata corrige cliccando sulla voce Errata corrige presente nella
diverse categorie dell'elenco degli strumenti per lo studio. Nel caso, è possibile scaricare il relativo PDF
alla sezione Servizi della scheda dedicata al volume, raggiungibile cliccando sul titolo del volume stesso.
Stampato da La Fenice Grafica
via Roma 71, Borghetto Lodigiano (LO)
per conto della C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana,
via Gargano 21, 20139 Milano
Ai pionieri delle telecomunicazioni del XX secolo che,
grazie alle loro teorie matematiche e ai loro geniali dispositivi,
hanno cambiato il nostro pianeta in un villaggio globale
Un corso introduttivo sulle comunicazioni analogiche e digitali è fondamentale nel curri
culum triennale in ingegneria elettronica. Il corso è normalmente inserito tra i corsi base.
Tipicamente, si assume che lo studente abbia conoscenze di analisi matematica, elettro
nica, segnali e sistemi e, possibilmente, di teoria della probabilità.
Avendo ben presente la natura introduttiva del corso, un testo consigliato deve
essere facile da leggere, accurato, e contenere un'abbondanza di esempi significativi,
problemi ed esercizi con il computer. Questi contenuti del libro sono necessari per faci
litare l'apprendin::iento dei fondamenti dei sistemi di telecomunicazione a un livello
introduttivo, ma in modo efficace. Il libro è stato scritto con tutti questi obiettivi ben
chiari in mente.
Data la natura matematica della teoria delle telecomunicazioni, è piuttosto facile per
il lettore perdere di vista il lato pratico dei sistemi di comunicazione. Attraverso tutto il libro
abbiamo fatto ogni sforzo per non cadere in questa trappola. L'abbiamo fatto muovendoci
attraverso la trattazione del soggetto in modo ordinato, sempre tentando di mantenere la
trattazione matematica a un livello facile da capire ed evidenziando la rilevanza pratica
della teoria ogni qualvolta sia appropriato.
[ Struttura. logica del testo
Per facilitare e rafforzare l'apprendimento, la struttura e il formato del libro sono stati
scelti in modo da ottenere i seguenti risultati:
"' motivare a leggere il libro e ad apprendere da tale lettura;
.. enfatizzare i concetti base da un punto di vista "sistemistico" facendo questo in modo siste
matico;
0 dovunque appropriato, inserire esempi ed esperimenti su computer in ogni capitolo, per
illustrare applicazioni della teoria pertinente;
0 fornire problemi svolti a valle della discussione di concetti fondamentali per aiutare il let
tore a sottoporre a verifica e a padroneggiare i concetti in discussione;
'" fornire ulteriori problemi in fondo a ogni capitolo, alcuni di natura avanzata, per esten
dere la teoria esposta nel testo.
~~ Organizzazione del testo
1. Motivazione Prima di essere coinvolti in profondità nello studio delle comunicazioni ana
logiche e digitali, è imperativo che il lettore sia motivato a usare il testo e ad apprendere suo
tramite. A tale fine, il Capitolo 1 inizia con una carrellata storica sui sistemi di telecomu
nicazione e le loro importanti applicazioni.
2. Teoria della modulazione Le comunicazioni digitali hanno soppiantato le comunicazioni
analogiche come metodo dominante di trasmissione. Anche se, in effetti, queste due forme
di comunicazione funzionano in modi diversi, la teoria della modulazione è alla base di
entrambe. Inoltre, è più facile capire questo importante soggetto trattando i suoi concetti
fondamentali applicati alla trasmissione analogica ed estendendoli poi alla trasmissione
digitale. Ancora, la modulazione d'ampiezza è più semplice da presentare della modula
zione angolare. Altro punto molto significativo è il fatto che per capire la teoria della modu
lazione è importante che la teoria di Fourier sia padroneggiata in precedenza. Con questi
punti ben presenti, i Capitoli dal 2 al 7 sono organizzati nel seguente modo:
il Capitolo 2 è dedicato a rivedere la rappresentazione di Fourier di segnali e sistemi;
<l>
VII
VIH Prefazione ISBN 978-88-408-1387-5
" i Capitoli 3 e 4 sono dedicati alle comunicazioni analogiche, con il Capitolo 3 che copre
la modulazione d'ampiezza e il Capitolo 4 che tratta della modulazione angolare;
"' il Capitolo 5 sulla modulazione a impulsi copre i concetti relativi alla transizione da comu
nicazioni analogiche a comunicazioni digitali;
'" i Capitoli 6 e 7 sono dedicati alle comunicazioni digitali, con il Capitolo 6 che copre la tra
smissione di dati in banda base e il Capitolo 7 che copre la trasmissione dati passa banda.
3. Teoria della probabilità e rivelazione di segnali Come l'analisi di Fourier è fondamentale per
la teoria della modulazione, così la teoria della probabilità è fondamentale per la rivela
zione dei segnali e per valutare le prestazioni di un ricevitore in presenza di rumore addi
tivo. Poiché la teoria della probabilità non è critica per la comprensione della modulazione,
abbiamo intenzionalmente ritardato la rassegna di teoria della probabilità, segnali casuali
e rumore fino al Capitolo 8. Quindi, con una buona comprensione della teoria della modu
lazione applicata alle comunicazioni analogiche e digitali e avendo a disposizione i concetti
rilevanti di teoria della probabilità e i modelli probabilistici, il terreno è pronto per rivisi
tare i ricevitori per comunicazioni analogiche e digitali, come di seguito riassunto:
" il Capitolo 9 discute il rumore nelle trasmissioni analogiche;
il Capitolo 10 discute il rumore nelle trasmissioni digitali. Poiché le trasmissioni analogi
1;
che e digitali operano con modalità differenti, è naturale osservare alcune differenze fon
damentali nel trattare gli effetti del rumore in questi due capitoli.
4. Rumore Lo studio introduttivo delle comunicazioni analogiche e digitali è completato nel
Capitolo 11. Questo capitolo illustra il ruolo nei sistemi di telecomunicazione di modula
zione e rumore secondo quattro punti:
"' per prime vengono descritte le sorgenti fisiche di rumore, sostanzialmente termico e impul
sivo;
"' come secondo punto, vengono introdotte le metriche di cifra di rumore e di temperatura
di rumore;
" al terzo punto si spiega come la propagazione interviene a determinare l'intensità del
segnale nelle telecomunicazioni via satellite o nelle comunicazioni terrestri via radio;
"' infine, mostriamo come i calcoli di intensità di segnale e di rumore possono essere com
binati per fornire una stima del rapporto segnale/rumore, la fondamentale figura di merito
per i sistemi di comunicazione.
5. Esempi a tema Per illustrare importanti applicazioni pratiche della teoria delle comunica
zioni, esempi a tema sono inseriti ovunque si ritenga appropriato. Gli esempi sono tratti sia
dal mondo delle comunicazioni analogiche, sia da quello delle comunicazioni digitali.
6. Appendici Per fornire materiale di supporto al testo, alla fine del libro sono incluse otto
appendici, che coprono i seguenti argomenti, presentati nell'ordine:
"' rapporti di potenze e decibel;
" serie di Fourier;
., funzioni di Besse!;
"' la funzione Q e la sua relazione con la funzione errore;
., diseguaglianza di Schwarz;
"' tavole matematiche;
1• procedure Matlab per esperimenti su computer relativi a problemi nei Capitoli 7-10;
., risposte agli esercizi.
Prefa z.ione
7. · Annotazioni. Inserite in tutto il libro, vengono fornite per stimolare il lettore interessato ad
approfondire argomenti avanzati mediante riferimenti bibliografici selezionati.
8. Materiale ausiliario Il libro è sostanzialmente autosufficiente. Un glossario dei simboli e
una bibliografia sono forniti alla fine del testo. Come aiuto al docente del corso che utilizzi
il testo, un dettagliato Manuale delle soluzioni per tutti i problemi, quelli all'interno del
testo e quelli inseriti alla fine dei capitoli, sarà reso disponibile attraverso l'editore John
Wiley and Sons.
Il testo può essere usato per un corso introduttivo sulle comunicazioni analogiche e digi
tali in modi differenti, in funzione del background degli studenti e degli interessi didattici
e delle responsabilità dei professori interessati. Qui di seguito si presentano due possibili
modelli di come questo possa essere fatto.
MODELLO m CORSO A: UN UN!CO CORSO DA DUE SEMESTRI
(A.1) Il primo semestre del corso sulla teoria della modulazione consiste dei Capitoli da 2 a 7
incluso.
(A.2) Il secondo semestre sul rumore nei sistemi di comunicazione consiste dei Capitoli da 8 a
11 incluso.
MODELLO DI CORSO B: DUE CORSI SEMESTRAU, UNO SULLA TRASMISSIONE
ANALOGICA E L'ALTRO SULLA TRASMISSIONE DIGHALE
(B.1) Il primo corso sulle comunicazioni analogiche comincia dal materiale di rassegna del
Capitolo 2 sull'analisi di Fourier, seguito dal Capitolo 3 sulla modulazione analogica e dal
Capitolo 4 sulla modulazione d'angolo; quindi procede con una rassegna delle parti di
rilievo del Capitolo 8 sul rumore e finisce con il Capitolo 9 sul rumore nelle comunica
zioni analogiche.
(B.2) Il secondo corso sulle comunicazioni digitali inizia con il Capitolo 5 sulla modulazione a
impulsi, continua con il Capitolo 6 sulla trasmissione dati in banda base e il Capitolo 7
sulle tecniche di modulazione digitale, per proseguire con una rassegna degli aspetti più
rilevanti della teoria della probabilità nel Capitolo 8 e finire con il Capitolo 10 sul rumore
nelle comunicazioni digitali.
Simon Haykin
Ancaster, Ontario, Canada
Michael Moher
Ottawa, Ontario, Canada
I
Capitolo l Introduzione 1
1.1 Inquadramento storico
1.2 Applicazioni 4
1.3 Risorse principali e requisiti operativi 13
1.4 Teorie alla base dei sistemi di comunicazione 14
1. 5 Osservazioni conclusive 16
I
Capitolo 2 Rappresentazione di Fourier di segnali e sistemi 19
2.1 La trasformata di Fourier 20
2.2 Proprietà della trasformata di Fourier 26
2.3 La relazione inversa fra tempo e frequenza 39
2.4 La funzione delta di Dirac 42
2. 5 Trasformate di Fourier di segnali periodici 49
2.6 La trasmissione di segnali attraverso sistemi lineari.
Rivisitazione della convoluzione 52
2. 7 Filtri ideali passa basso 59
2.8 Correlazione e densità spettrale: segnali a energia finita 69
2.9 Densità spettrale di potenza 77
2.10 Calcolo numerico della trasformata di Fourier 79
2.11 Esempio a tema: doppino intrecciato per telefonia 87
2.12 Sommario e discussione 89
Problemi aggiuntivi 90
Problemi avanzati 9 5
~ Capitolo 3 Modulazione d'ampiezza 99
3.1 Modulazione d'ampiezza 100
3.2 Pregi, limiti e varianti della modulazione d'ampiezza 111
3.3 Modulazione in doppia banda laterale e portante soppressa 112
3.4 Ricevitore di Costas 118
3.5 Multiplazione con portanti in quadratura 120
3.6 Modulazione in banda laterale unica 121
3.7 Modulazione in banda vestigiale 128
XIII
Indice ISBN 978-88-408-1387-5
3.8 Rappresentazione passa basso di onde modulate e di filtri
passa banda 134
3.9 Esempi a tema 139
3.10 Sommario e discussione 144
Problemi aggiuntivi 145
Problemi avanzati 14 7
149
4.1 Definizioni base 150
4.2 Proprietà delle onde modulate angolarmente 151
4.3 Relazioni tra onde PM e FM 156
4.4 Modulazione di frequenza a banda stretta 157
4.5 Modulazione di frequenza a banda larga 161
4.6 Banda occupata da portanti modulate FM 167
4.7 Generazione di onde FM 169
4.8 Demodulazione di segnali FM 171
4.9 Esempio a tema: multiplazione stereo nel broadcast FM 179
4.10 Sommario e discussione 181
Problemi aggiuntivi 182
Problemi avanzati 184
® Capitolo 5 Modula~ione inipulsivag passaggio dalle
t
liJ comunicazioni analogiche a quelle digitali 187
5.1 Campionamento 188
5.2 Modulazione impulsiva d'ampiezza 195
5.3 Modulazione impulsiva di posizione 199
5.4 Completamento della transizione da analogico a digitale 200
5.5 Processo di quantizzazione 202
5.6 Modulazione impulsiva codificata 203
5. 7 Modulazione delta 208
5.8 Modulazione impulsiva a codifica differenziale 213
5.9 Codici di linea 216
5 .1 O Esempi a tema 21 7
5 .11 Sommario e discussione 221
Indice XV
Prbblemi aggiuntivi 223
Problemi avanzati 225
229
6.1 Trasmissione numerica in banda base 230
6.2 Il problema dell'interferenza intersimbolica 231
6.3 Il canale di Nyquist 233
6.4 Lo spettro dell'impulso a coseno rialzato 235
6.5 Trasmissione multilivello in banda base 242
6.6 Il diagramma a occhio 243
6.7 Esperimento al calcolatore: i diagrammi a occhio per i sistemi binari
e quaternari 24 7
6.8 Esempio a tema: l'equalizzazione 249
6.9 Sommario e discussione 253
Problemi aggiuntivi 254
Problemi avanzati 256
ii: Capitolo 7 Tecniche di modulazione numerica in canali
~
[ passa banda 259
7 .1 Alcuni preliminari 2 5 9
7 .2 Modulazione numerica binaria d'ampiezza
(Binary Amplitude-Shift Keying) 262
7.3 Modulazione numerica di fase (Phase-Shift Keying) 266
7.4 Modulazione numerica di frequenza (Frequency-Shift Keying) 278
7.5 Sommario dei tre schemi binari di segnalazione 286
7 .6 Schemi di modulazione numerica non coerente 288
7. 7 Schemi di modulazione numerica M-aria 292
7.8 Corrispondenza tra le forme d'onda modulate
e le costellazioni di punti nello spazio dei segnali 296
7.9 Esempi a tema 299
7. l O Sommario e discussione 305
Problemi aggiuntivi 306
Problemi avanzati 308
Esperimenti al calcolatore 309