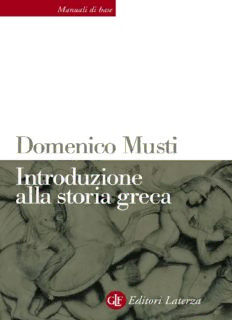Table Of ContenteBook Laterza
Domenico Musti
Introduzione alla storia greca
Dalle origini all'età romana
Per una visualizzazione ottimale si consiglia l'utilizzo del font Times New Roman
© 2012, Gius. Laterza & Figli
Edizione digitale: settembre 2013
www.laterza.it
Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Realizzato da Graphiservice s.r.l. - Bari (Italy) per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 9788858104200
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata
Prefazione
Nella versione ridotta che qui propongo della Storia greca. Linee di sviluppo
dall’età micenea all’età romana (1989), non posso rinunciare ad alcune
componenti essenziali, ma, nello sforzo di fornire un manuale più agile per
una prima informazione, ho voluto a) conservare alcuni dati essenziali; b)
eliminare in maniera coerente alcuni approfondimenti, che – chi vorrà – potrà
ritrovare nella versione originaria e integrale del manuale medesimo; c)
cogliere l’occasione per fornire alcuni aggiornamenti che consente (e al tempo
stesso raccomanda) il non breve lasso di tempo (quattordici anni circa)
intercorso tra la prima uscita del libro e questo compendio.
Per cominciare con i dati essenziali, non ho potuto rinunciare alla
indicazione e caratterizzazione di grandi soggetti storici, come popoli, città,
protagonisti, uomini politici, dinastie e principi regnanti, o come regioni e
territori di rilevanza storico-politica; né alla citazione di istituzioni e leggi, di
aspetti della cultura, della religione, della filosofia; né alla illustrazione di forme
dell’economia, della produzione e del commercio. Ho però dovuto ridurre il
peso della citazione e dell’analisi di fonti, che rappresentano l’oggetto di una
riflessione preparatoria, destinata a rimanere un po’ nascosta agli occhi di chi
desidera una sintesi di larga informazione e una introduzione alla materia. Per
la stessa ragione, tagli o ridimensionamenti hanno riguardato anche l’apparato
illustrativo, le note in calce al testo, la bibliografia e, in parte, le stesse note
integrative. Ovviamente, neanche questa versione vuole rinunciare a delineare
un profilo dello sviluppo storico del mondo greco che sia scientificamente
valido: perciò agli autori antichi si lascia uno spazio e si fanno richiami
adeguati alla loro importanza, in particolare per la storia politica, dedicando
una speciale attenzione alla storiografia, ma senza neanche sacrificare del tutto
la letteratura di altro genere; lo stesso criterio ha ispirato i riferimenti ad aspetti
artistici e religiosi.
Viceversa, qualche arricchimento, rispetto all’edizione originaria,
nonostante la forte riduzione quantitativa e gli evidenti limiti di spazio di
questo manuale, è assicurato dall’aggiornamento che l’attuale edizione ha
comportato. Forse l’incremento più significativo (anche se non unico) risulta
dalle notizie sulle iscrizioni micenee in Lineare B, scoperte a Tebe, e dai
riferimenti ad altre novità archeologiche ed epigrafiche, che ogni studioso di
storia del mondo antico deve tenere presenti. Ma non è da sottovalutare il
paradossale vantaggio che concede all’autore la brevità che si impone a un
manuale destinato a una informazione preliminare: il ‘vantaggio’ di dover
mirare a una formulazione essenziale delle idee-guida, nella rappresentazione
della storia di un popolo, cioè di una società, delle sue istituzioni, delle sue
vicende, della sua anima. Spero che la scelta sia stata felice e la brevità buona
consigliera.
D.M.
Roma, settembre 2002
Introduzione
Va premesso un quadro della storia degli studi, soprattutto delle grandi
opere di consultazione che costituiscono le pietre miliari della ricerca. Occorre
partire almeno da quella straordinaria stagione di riflessioni critiche, di
emergente e rinnovato interesse archeologico e nuovi scavi, di fondazione di
nuove tecniche d’indagine e d’esposizione, che corrisponde più o meno al
secondo quarto del XVIII secolo (1725-1750). È questa infatti l’epoca in cui,
per la storia romana, si segnalano le ricerche critiche sui primi secoli di quella
storia, di Louis de Beaufort (1738), in cui in Italia si avviano gli scavi di
Ercolano e di Pompei e si riscopre Paestum (1738-1748): il periodo in cui, per
effetto di trasformazioni che sono insieme della cultura (preilluministica ed
illuministica) e del modo di governare, anche la scienza dell’antichità muove i
suoi primi passi nella direzione in cui ancora oggi tutto sommato prosegue,
svincolandosi parzialmente e però anche progressivamente dai moduli
umanistici, i quali erano ispirati a un gusto antiquario, che si esercitava sui
temi limitati e specifici della tradizione medesima (sentita come un inventario
di exempla morali) e dalla convinzione di continuarla. Tutto il Settecento
illuminista, riformatore, rivoluzionario, appare come prefazione alla nascita
delle prime opere sistematiche sull’antichità classica, nel senso moderno. Al
solito, la ricerca su Roma è ancora una volta quella che fa da battistrada: così la
epocale Römische Geschichte di Barthold Georg Niebuhr (1811, 1a ed.) precede
la ricerca sull’economia pubblica ateniese di August Boeckh, Die
Staatshaushaltung der Athener, 1817 (o la Geschichte hellenischer Stämme und Städte
di Karl Otfried Müller, 1824; 2a ed., curata da F.W. Schneidewin, 1844). Nel
campo della ricerca epigrafica, d’altra parte, fu con la collaborazione di
Niebuhr che nacque il progetto dello stesso Boeckh per un Corpus
Inscriptionum Graecarum (CIG, 4 voll., 1828-1877). Niebuhr era del resto
studioso del mondo greco, oltre che di quello romano. Si deve poi a U. von
Wilamowitz-Moellendorff, nel 1906, l’avvio del progetto di revisione e
sistemazione delle epigrafi dell’intera grecità: il progetto delle Inscriptiones
Graecae (IG) in 15 volumi (e più fascicoli), che doveva realizzarsi solo in parte,
e dapprima nella veste della cosiddetta editio maior, quindi in quella più agile e
funzionale della seconda edizione (editio minor), dal 1913.
Le scoperte archeologiche di Paestum e l’avvio degli scavi regolari di
Ercolano e di Pompei (1738-1748) aprono quel nuovo capitolo dello studio
dell’antichità che matura nell’età contemporanea.
Dopo il periodo preparatorio del Settecento, in cui si segnalano storie
greche di studiosi britannici come J. Gillies (1786) e W. Mitford (1784-1794),
si assiste a una seconda grande stagione, della quale potremmo indicare come
punto d’arrivo, sotto il profilo metodologico, il 1870. Con Boeckh e con
Müller la storia greca si presentava ormai come storia di istituzioni e di popoli.
È anche naturale che agli inizi della manualistica greca si presentino visioni
complessive della grecità, centrate intorno a una ‘tesi’: l’esaltazione
appassionata, e in parte anche unilaterale, della democrazia ateniese nella
History of Greece del liberale inglese George Grote (12 voll., London 1846-
1856), che si inseriva in una tradizione di opere inglesi, di storia greca,
ideologicamente improntate, pur se con orientamenti diversi (quelle di J.
Gillies e W. Mitford, già ricordate, e l’importante History of Greece del
conservatore C. Thirlwall). La History of Greece di G. Grote ha certamente il
merito di fissare l’attenzione su quello che a tutt’oggi vale come l’esperimento
politico centrale dell’antichità greca. Una ‘tesi’ e una visione di fondo e il gusto
per la storia regionale si coniugano ancora nell’opera di Ernst Curtius, autore
di una Griechische Geschichte (3 voll., Berlin 1857-1867), ma, già prima, di
un’opera sul Peloponneso, in 2 voll. (1851-1852). Nella stessa parte
dell’Ottocento (ante 1870), in cui vedono la luce opere generali di grande
impegno, impostate su una ‘tesi’ o un problema centrale, si colloca la
Geschichte Alexanders des Grossen (1833), seguita dalla Geschichte des Hellenismus
(2 voll., 1836-1843) di Johann Gustav Droysen (nella seconda edizione, 3
voll., 1877-1878, il titolo di Geschichte des Hellenismus era esteso anche al I
volume). Con l’opera del Droysen la ricerca sulla storia greca reagiva
tempestivamente alla tentazione – spesso nella pratica manualistica però
riaffiorante – di considerare il periodo dopo la battaglia di Cheronea (338
a.C.) come un’epoca di declino del mondo greco, come l’inizio della sua fine,
si fondava dunque la possibilità di concepire la storia della grecità come storia
della cultura, vista nel suo stretto intreccio con la politica: per il Droysen
all’ellenismo era sottesa un’unità di fondo, che ad esempio – com’è soprattutto
nella prima edizione – è riconosciuta nella funzione di preparazione della
humus storica del Cristianesimo. Il termine ellenismo non doveva piacere a tutti:
così il Grote, che pur estendeva, col XII volume, la sua History of Greece fino al
periodo che noi chiamiamo ellenistico, rivolgendo la sua attenzione,
nell’ultimo capitolo, a quelle che egli chiama hellenic (non Hellenistic) cities,
critica come fuorviante l’uso del termine Hellenism per indicare gli Stati e la
cultura di mistione etnica nati dalla conquista di Alessandro; per lui Hellenism
poteva indicare solo la grecità del periodo dell’autonomia (l’uso del termine per una
cultura orientale permeata di grecità doveva essergli sgradito, nella sua visione
elleno-e atenocentrica, e apparirgli linguisticamente improprio ed equivoco).
In questa fase (primi due terzi dell’Ottocento) la ricerca di una posizione
unitaria nella descrizione dei fatti della storia greca è evidente, e anche – non si
può negarlo – giustificata. Dopo il 1870 (e la data costituisce davvero quasi
uno spartiacque) molte cose cambiano, con una velocità e una intensità che
hanno pochi riscontri in altre epoche. È ormai l’età del positivismo; è anche
l’epoca dominata, anche se ovviamente non esclusivamente rappresentata,
dall’apporto della tedesca Altertumswissenschaft (scienza dell’antichità). Si
sviluppano le cosiddette Hilfswissenschaften (scienze ausiliarie) della storia, che
presto però aspirano a una loro autonomia: archeologia, epigrafia, papirologia,
numismatica, metrologia; si moltiplicano ricerche, scavi, studi, raccolte di
corpora, a seconda della specializzazione di ciascuna disciplina. È anche, per i
testi letterari, il periodo delle grandi edizioni critiche, come anche quello della
scoperta di nuovi testi: una data certamente epocale è nella identificazione ad
opera dell’inglese Frederic Kenyon (1890; pubblicazione nel 1891) di un
papiro londinese contenente gran parte del testo della Athenaíon Politeía
(Costituzione degli Ateniesi) di Aristotele. Sul piano della ricerca archeologica,
basti menzionare le straordinarie scoperte di Heinrich Schliemann (1822-
1890) a Troia, Tirinto, Micene, Orcomeno, Itaca, che rinnovano
completamente la base documentaria della conoscenza del mondo descritto da
Omero. Località di Creta sono oggetto di scavi di archeologi italiani (a Haghia
Triada e Festo, Federico Halbherr, dal 1884), inglesi (Arthur Evans a Cnosso)
e di altri paesi.
La Geschichte des Altertums di Eduard Meyer comprende 5 volumi in più
tomi (1884-1902); il I e il II volume sono dedicati all’Oriente antico, i
successivi alla storia dei Greci fino all’età di Filippo II. L’idea centrale del
Meyer è quella di una storia ‘universale’, che abbracci l’Oriente e l’Occidente:
la sua conoscenza delle lingue orientali, la sua vasta esperienza egittologica gli
consentono di dare quindi uno spazio amplissimo all’antefatto orientale della
storia greca.
Per caratteristiche particolarissime si segnala la Griechische Geschichte di Karl
Julius Beloch, comparsa dapprima in 3 volumi (1893-1904), poi, in una 2a ed.
in 4 volumi, di cui ciascuno diviso in 2 tomi (1912-1927). Il I tomo di ciascun
volume è espositivo, narrativo, anche se già imposta, nella narrazione e nelle
note, interpretazioni e discussioni critiche; l’apparato più propriamente
erudito, fatto di ulteriori discussioni e di dati cronologici, genealogici,
insomma di tutto un bagaglio filologico assai esteso, è concentrato utilmente
nel II tomo di ogni volume. Con Beloch, la prospettiva storica torna a farsi
decisamente ellenocentrica; l’opera riusciva a estendersi fino alla pace di
Naupatto (217 a.C.), cioè fino alla vigilia dell’intervento militare romano in
Grecia. Il prodotto storiografico è di altissimo livello critico; sarebbe
impensabile prendere posizione, su qualunque tema della storia greca del
periodo ricordato, senza passare attraverso una prima, profonda riflessione
sulle pagine di Beloch. È anche vero tuttavia che nel rigido positivismo del
Beloch (che gli suggeriva un’attenzione notevolissima agli aspetti della società
e dell’economia, della demografia e della geografia, e questo già nel primo
tomo di ciascun volume) era presente la convinzione di fondo che la veridicità
delle fonti antiche dovesse essere sempre dimostrata: in dubio, si direbbe, contra
reum. Moltissime delle conclusioni del grande Beloch restano ancor oggi
valide, soprattutto per i volumi II-IV della sua Geschichte, cioè per il periodo
che va dall’età delle guerre persiane sino al 217 a.C.; invece, la cronologia
ribassista delle tirannidi arcaiche e il modo stesso di argomentare sulla
tradizione relativa alla migrazione dei Dori nel Peloponneso appaiono oggi
suscettibili di revisione.
Sarebbe comunque errato ed ingiusto limitare a Beloch questa caratteristica
metodologica: essa è presente in una miriade di lavori minori di autori diversi,
nei decenni che vanno dal 1870 alla I guerra mondiale. Tanto benemerita fu
quell’epoca nella produzione di edizioni e commentari di autori, quanto, assai
spesso, distruttiva nell’esegesi storica. Di questo spirito innovatore, e spesso
ipercritico, sono per quell’epoca partecipi così gli scritti dei filologi come
quelli degli storici. Al confronto, sembra quasi di cogliere voci di altra epoca –
e invece si tratta solo di portavoci di altre esigenze o di altri ambienti culturali
–, quando si leggono le pagine della Griechische Kulturgeschichte dello storico di
Basilea Jacob Burckhardt (in realtà, elaborazione postuma di appunti delle sue
lezioni, pubblicata in 4 volumi a cura di Jacob Oeri tra il 1898 e il 1902), in
cui assolvevano un ruolo centrale la categoria concettuale dell’‘agonismo’ e
l’immagine dell’uomo greco come ‘uomo agonale’.
A parte va considerato l’apporto della ricerca sociologico-istituzionale
francese, o francofona in generale, che si estende dalle forme originarie delle
strutture sociali agli aspetti del vivere quotidiano, degli individui come degli
stessi Stati: tutto un bagaglio di temi e di nozioni non-avvenimentali, nella cui
presentazione, in ragione stessa del contenuto, era meno assillante il problema
fondamentale della critica delle fonti, quello del valore della cronologia, degli
eventi e dei personaggi storici presentati dalla tradizione. Mi riferisco alle
ricerche di P. Guiraud sulla proprietà fondiaria nell’antichità e sulla
manodopera industriale nell’antica Grecia (1893; 1900), agli studi del belga H.
Francotte sull’industria greca (1900-1901), a quelli di L. Gernet
sull’approvvigionamento di grano nell’Atene del V-IV secolo (1909), o di
Gustave Glotz sul lavoro nel mondo greco (1920) o su La cité grecque (1a ed.,
1928), che continua ed aggiorna il tema della celebre opera di N.D. Fustel de
Coulanges su La cité antique (1864).
Le opere di Fr. Lenormant (1881-1884) sulla Magna Grecia, e di A. Holm
(1870-1898) e di E. Freeman (1891-1894) sulla Sicilia antica, corrispondono
alle esigenze critiche poste dall’età positivista, che per la Sicilia antica e la
Magna Grecia erano tanto più valide, quanto più si doveva rispondere
all’obbligo di confrontare e coordinare i dati della tradizione letteraria con
quelli archeologici e numismatici. In questo campo lo spirito di esplorazione è
stato sempre decisivo (si trattava di scoprire vestigia greche all’interno o al di
sotto d’un contesto diverso): e l’opera di Paolo Orsi in Sicilia (dove
l’archeologo trentino continuava l’opera di J. Schubring, di A. Salinas, di F.
Cavallari), come in Italia meridionale, rappresenta forse il momento decisivo
del progressivo passaggio dall’età dei viaggiatori a quella degli esploratori e
scavatori di resti archeologici.
Si possono dunque distinguere, all’interno della ricerca moderna e
contemporanea sul mondo greco, fino alla prima guerra mondiale, tre grandi
periodi: quello che va dal 1725 ca. alla fine del XVIII secolo; quello che dai
primi dell’Ottocento giunge al 1870 ca.; quello compreso tra questa data e gli
anni 1914-1918.
Il resto è bibliografia, ed è anche l’ultima fase della storia della ricerca,
caratterizzata, già a una prima considerazione, dai seguenti tratti. 1) Il
moltiplicarsi e infittirsi delle ricerche particolari. 2) Il massiccio apporto dei
più diversi paesi alla storia degli studi, come chiaro riflesso di quella profonda
interazione fra le culture di ogni continente, che gli eventi della prima e
soprattutto della seconda guerra mondiale hanno decisamente accelerato. 3) Il