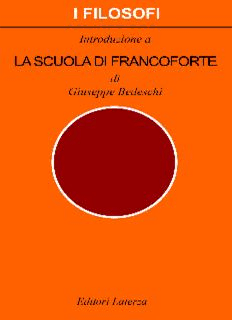Table Of Content© 1985, Gius. Laterza & Figli
Prima edizione 1985
INTRODUZIONE A
DI
LA SCUOLA FRANCOFORTE
DI
GIUSEPPE BEDESCHI
EDITORI LATERZA
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nel febbraio 1985
nello stabilimento d·arti grafiche Gius. Laterza &. Figli, Bari
CL 20.2567-1
ISBN 88-420.2567-4
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
PREMESSA
La maggior parte degli studi sulla Scuola di Franco
forte è apparsa nella seconda metà degli anni Sessanta
e nella prima metà degli anni Settanta: fu quello, infatti,
il periodo d'oro del ' recupero ' di autori come Hork
heimer, Adorno, Marcuse (il quale conobbe un succes
so mondiale soprattutto con L1uomo a una dimensione,
pubblicato nel 1964 ), Benjamin, Fromm, ecc., i cui scritti,
apparsi in gran parte negli anni Trenta e Quaranta,
furono riesumati e tradotti nelle principali lingue occi
dentali, fino a divenire i ' manifesti filosofici ' della ' nuo
va sinistra'. Come è noto, il 1968 fu l'anno magico di
questo movimento. Ma esso fu solo l'inizio di un periodo
che si sarebbe protratto (almeno per ciò che riguarda i
suoi effetti sulla mentalità diffusa) per parecchi anni
ancora (grosso modo, per un decennio): il periodo della
guerra nel Vietnam, con la profonda impressione che
essa esercitò sull'opinione pubblica del mondo intero;
delle rivolte studentesche nei campus americani, presto
diffusesi anche nell'Europa occidentale; del maggio fran
cese e della ' rivoluzione culturale ' cinese; del guevarismo,
ecc. Simboli, questi, di un'epoca in cui la trasformazione
rivoluzionaria della società sembrava essere all'ordine del
giorno, secondo un progetto che appariva tanto più esal
tante in quanto avrebbe dovuto realizzarsi in base a
moduli interamente nuovi rispetto alle altre esperienze
rivoluzionarie del Novecento (in primo luogo rispetto
all'esperienza sovietica, finita, dopo il terrore staliniano,
in una sorta di totalitarismo burocratico, che aveva spento
ogni vitalità della ' società civile ').
La Scuola di Francoforte aveva espresso, già a partire
dagli anni Trenta, queste esigenze di rinnovamento del
l'idea e della pratica della rivoluzione. I suoi temi cen
trali erano stati infatti l'equiparazione di fascismo, stali
nismo e società unidimensionale (la società industriale
avanzata, dominata dalle regole ferree dell' ' apparato ' e
plasmata dall'industria culturale, cioè dalla mercificazione
di tutta la vita spirituale); la critica della scienza e delle
sue applicazioni tecnologiche, che comportavano inevita
bilmente il dominio dell'uomo sull'uomo (a differenza di
quanto aveva pensato il marxismo classico, che aveva
ritenuto scienza e tecnologia in qualche misura neutrali,
usabili, quindi, sia dalla borghesia sia dal proletariato-per
fini, ovviamente, diversi, anzi opposti); l'esigenza di una
liberazione ' totale ', che, per essere davvero tale, avrebbe
dovuto passare prima di tutto attraverso una completa
rigenerazione della persona umana (di qui gli studi sulla
' personalità autoritaria ', e il tentativo di rinnovare e di
completare il marxismo con tematiche psicoanalitiche);
la constatazione del venir meno del potenziale rivoluzio
nario della classe operaia nei paesi più sviluppati, e l'indi
viduazione dei nuovi soggetti rivoluzionari negli intel
lettuali non conformisti, ovvero non addomesticati dal
' sistema', negli emarginati, negli oppressi per motivi raz.
ziali, nei popoli del terzo mondo; e altri temi ancora,
che esamineremo nel corso del presente lavoro.
Oggi che il decennio apertosi col 1968 è ormai pas
sato (tanto passato, che sembra lontano da noi addirit
tura decine d'anni, poiché, come è noto, il tempo cronolo
gico non coincide col tempo storico); oggi che i suoi miti
sono stati impietosamente smentiti uno dopo l'altro, e
sembrano appartenere a una sorta di infanzia dell'uma
nità; oggi che gli intellettuali sono divenuti più sobri e
- recuperata gran parte del pensiero realistico-' bor
ghese ' che avevano imprudentemente rimosso (da Weber
4
a Kelsen, da Pareto a Schumpeter, da Mosca ad Aron) -
sembrano ormai dediti a ricerche positive sui congegni
economici, sociali e politici delle società in cui viviamo,
per dominarne, per quanto è possibile, i giganteschi e
certamente inquietanti problemi; oggi, dicevamo, anche
un fenomeno culturale come la Scuola di Francoforte può
essere esaminato con il necessario distacco. E non è detto
che non se ne possano ricavare u ti H indicazioni e inse
gnamenti.
Analizzando, infatti, l'esperienza della Scuola di Fran
coforte, è giuocoforza fare i conti con alcuni dati di fondo,
che potranno forse dispiacere ma che non possono essere
negati: in primo luogo, il persistere e il continuo ripre
sentarsi del pensiero utopico all'interno di società sempre
più caratterizzate da un possente sviluppo della scienza,
dell'industria e della più sofisticata tecnologia; in secondo
luogo, il rampollare del mito (nelle vesti di una critica
- che è piuttosto un rifiuto - della società industriale
avanzata) da un complesso dottrinale e da una tradizione
intellettuale -il marxismo -che sembrano essere carat
terizzati invece da una ispirazione fortemente realistico
e da una profonda adesione ai valori illuministici e ai
risultati pratici della rivoluzione industriale. Sebbene que
sti due importanti temi non siano al centro di questo
libro, essi possono essere in qualche misura riproble
matizzati e rischiarati da una ricostruzione analitica della
oroduzione teorica della Scuola di Francoforte (che è,
invece, il tema vero e proprio del libro). Le principali
conclusioni, a questo proposito, il lettore le troverà nel
capitolo finale (Epilogo), conclusioni che l'autore di que
ste pagine ha ritenuto di poter ricavare dall'analisi com
plessiva dell'esperienza della Scuola: si tratta però di
appunti schematici e di ipotesi che richiedono ulteriore
approfondimento ed elaborazione.
Devo, infine, al lettore un ulteriore chiarimento. La
mia ricostruzione dell'esperienza ' francofortese ' si ferma
al 19 50, cioè alle soglie del ritorno di Horkheimer e
Adorno in Germania. E ciò per due motivi (che sono poi,
in fondo, un motivo solo): in primo luogo, perché il
5
ritorno in Germania dei due principali esponenti dell'Isti
tuto per la Ricerca Sociale incise fortemente sulla compo
sizione dell'Istituto medesimo (parecchi suoi autorevoli
membri, infatti, restarono negli Stati Uniti); in secondo
luogo, perché la ripresa dell'attività dell'Istituto a Franco
forte si giovò dell'apporto di una generazione più gio
vane (Habermas, Schmidt e altri), la cui formazione e le
cui esigenze determinarono una fase sostanzialmente nuova
della Scuola. Perciò gli scritti successivi al 1950 degli espo
nenti ' francofortesi ' sono rimasti quasi completamente al
di fuori del quadro tracciato nelle pagine che seguono.
1. LA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO
PER LA RICERCA SOCIALE E LA PRIMA FORMULAZIONE
DELLA c TEORIA CRITICA· 1
L'Istituto per la Ricerca Sociale fu fondato nel 1922,
a Francoforte, da un gruppo di intellettuali marxisti. Essi,
in un primo tempo, avevano pensato di chiamarlo Isti
tuto per il marxismo, ma poi questa idea fu abbandonata
per motivi di opportunità accademica. Benché, infatti,
l'Istituto fosse autonomo finanziariamente (era sorto gra
zie a una generosa donazione di un ricco industriale, Her
mann Weil, padre di uno dei soci fondatori, Felix Weil),
esso fu affiliato all'università di Francoforte e fu ricono
sciuto dal ministero dell'Istruzione: ciò gli dava notevoli
vantaggi di stabilftà e di prestigio (fra l'altro, sulla base
dell'accordo stipulato col ministero, il direttore dell'Isti
tuto doveva essere un professore ordinario di università).
Con tale riconoscimento accademico, l'Istituto per la Ri
cerca Sociale divenne il primo organismo universitario
tedesco dichiaratamente marxista e formato interamente
da marxisti.
Il primo direttore dell'Istituto fu un economista, Kurt
Albert Gerlach, che però non poté dare la propria im
pronta all'istituzione da lui diretta, perché morl preco-
6