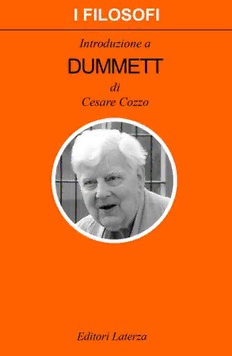Table Of Content© 2008, Gius. Laterza & Figli
Prima edizione 2008
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché
non danneggi l'autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un
libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la
conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai dan
ni della cultura.
INTRODUZIONE A
DUMMETT
DI
CESARE COZZO
EDITORI LATERZA
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nell'ottobre 2008
SEDIT -Bari (Italy)
per conto della Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-420-8811-0
MICHAEL DUMMETT
I. INTRODUZIONE
1. Una variegata personalità
V'è chi1 allude al frammento di Archiloco che ispirò
lsaiah Berlin: «la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una
grande», e paragona Michael Dummett alla volpe, cioè lo po
ne fra coloro che «perseguono molti fini, spesso disgiunti e
contraddittori [. .. ] non unificati da un principio morale o
estetico>>2• Filosofo del nesso fra metafisica e teoria del signi
ficato. Pioniere dello studio dei giochi di carte, a cui dobbia
mo «il più importante libro sulle carte mai scritto»3• Fautore
dell'impegno sociale e politico dei cattolici4• Logico matema
tico che ha introdotto una logica intermedia5• Esponente an-
1 G. Sundholm, Vestzges o/ Realism, in The Philosophy o/ Michael Dum
mett, a cura di B. McGuinness e G. Oliveri, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht-London 1994, p. 165.
2 I. Berlin, Russian Thinkers, Penguin, London 1978, trad. it. di G. For
ti, Il riccio e la volpe, Adelphi, Milano 1986, p. 71.
3 S. Mann, Playing Cards, inMichaelDummett: Contributions to Philosophy,
a cura di B.M. Taylor, Nijhoff, Dordrecht-Lancaster 1987, p. 195. Il libro così
descritto è M. Dummett, The Game o/Tarot, Duckworth, London 1980.
4 Cfr. M. Dummett, Catholicism and the World Order, Catholic Institute
for International Relations, London 1979.
5 Cfr. M. Dummett, A Propositional Calculus with Denumerable Matrix,
in «TheJoumal of Symbolic Logio>, XXIV (1959), pp. 97-106. Sulle logiche
intermedie cfr. Introduzione, in P.L. Minari, Indagini semantiche sulle logiche
intermedie proposizionali, Bibliopolis, Napoli 1989.
3
tirazzista6. Indagatore di sistemi elettorali7• Autore di un li
bretto sulla grammatica e lo stile8.
Un punto unificante9 è il fiducioso sforzo di comprendere
la realtà umana e renderla razionale, senza rinunciare alla criti
ca, né a proposte di cambiamento contrarie alle tendenze do
minanti. Fiducia, qualcuno aggiungerà, che ha radici nella fe
de. I frutti sono nelle attività politiche di Dummett. Ma anche
nel progetto di una teoria del funzionamento del linguaggio, o
nelle obiezioni a usi logici consolidati, nell'approccio rigoroso
ai procedimenti elettorali, o nel rifiuto delle concezioni magi
che dei tarocchi. Ritrarre il carattere variegato della persona
cercandone l'unitarietà è però incombenza di biografo che qui
non si assolverà. In un'introduzione alla filosofia di Dummett
si parlerà solo del filosofo. Lo scopo introduttivo comporta ri
duzione e semplificazione: al prezzo di trascurare temi altri
menti significativi, si privilegeranno le strutture portanti del
suo pensiero e la cura di esporle con chiarezza costringerà a da
re un'immagine più rigida e schematica dell'originale.
2. Il giovane Dummett a Oxford nel dopoguerra
Nato a Londra il 27 giugno 1925, dopo aver servito nell'e
sercito britannico Michael Dummett studiò filosofia a Oxford
dal 1947 al 1954, quando trionfava la 'filosofia del linguaggio
ordinario'. In un'intervista del 1987 egli così racconta il clima
di Oxford in quegli anni:
la maggior parte dei filosofi in questa università era convinta che tut
to il lavoro interessante in filosofia si svolgesse a Oxford. Sbalorditi-
6 Cfr. A. Durnmett e M. Dummett, The Role of Government in Britain's
Racial Crisis, in ]ustice First, a cura di L. Donnelly, Sheed & Ward, London
Sidney 1969, pp. 25-78; M. Durnrnett, On lmmigration and Refugees, Rou
tledge, London 2001.
7 Cfr. M. Dumrnett, Voting Procedures, Oxford University Press, Oxford
1984; Id., Principles o/E lectoral Reform, Oxford University Press, Oxford 1997.
8 M. Durnrnett, Grammar and Style, Duckworth, London 1993.
9 Cfr. A. Matar, From Dummett's Philosophical Perspective, de Gruyter,
Berlin-New York 1997, pp. 1-7.
4
vo quanto ne fossero compiaciuti. Certamente pensavano che in
America non si facesse nulla di molto valore, e ancor meno valore fi
losofico attribuivano a ciò che avveniva sul continente europeo.
Wittgenstein insegnava ancora a Cambridge. Pochi avevano idea di
quel che insegnasse; gli altri se lo chiedevano - tutti sapevano che era
importante, senza sapere cosa fosse. Ma a parte Cambridge, tutto
quel che in filosofia avesse valore accadeva a Oxford.10
Le due figure più influenti erano Gilbert Ryle e John L.
Austin. L'influenza di Ryle fu per Dummett prevalentemente
di carattere critico. Lo indusse a un pregiudizio sfavorevole
nei confronti di Rudolf Carnap. Negli Stati Uniti considerato
un maestro, Carnap era per Ryle «il peggiore filosofo, un filo
sofo colpevole di errori banali»11. Così Dummett per molto
tempo non lesse Carnap.
Dell'influenza di Austin, leader della ordinary language
school, Dummett ha sempre pensato che fosse nociva. La filo
sofia a Oxford si era sviluppata in modo abbastanza indipen
dente dall'insegnamento di Wittgenstein a Cambridge che, al
meno all'inizio, non era ben noto. Anni dopo, tuttavia, Dum
mett avrebbe descritto la filosofia del linguaggio ordinario co
me una «caricatura»12 delle idee dell'ultimo Wittgenstein.
Malgrado l'opposizione al sistema fosse comune a Wittgen
stein e alla filosofia del linguaggio ordinario di Austin,
la grande differenza fra Wittgenstein e ciò che Austin quantomeno
professava, o insegnava, era questa: Wittgenstein cominciava sempre
con problemi filosofici e lottava con essi, mentre Austin riteneva che
i problemi fossero dovuti a confusioni, fraintendimenti del linguag
gio [ ... che] dobbiamo dimenticare i problemi. Dobbiamo comincia
re a guardare le parole, come vengono usate, farne analisi molto pre
cise, e così via, indipendentemente da quali siano i problemi filoso-
10 J. Schulte, Interview, in M. Dummett, Origins o/A nalytical Philosophy,
Duckworth, London 1993, p. 168.
11 F. Pataut, An Anti-Realist Perspective on Language, Thought, Logie and
the History o/ Analytic Philosophy: An Interview with Michael Dummett, in
«Philosophical Investigations», XIX (1996), p. 12.
12 M. Dummett, Can Analytical Philosophy Be Systematic, and Ought It to
Be? (1975),inid., TruthandOther Enigmas, Duckworth, London 1978,p. 445.
5
fici, e allora vi sarà un miracolo e tutti i problemi filosofici si dissol
veranno. 0
La pretesa di accantonare i problemi filosofici limitandosi
ad analizzare l'uso di singoli enunciati, rinunciando a teorie
generali del funzionamento del linguaggio, è chiamata da
Dummett «particolarismo»14• Il particolarismo peccava di su
perficialità: dettagliate e sottili descrizioni di usi linguistici ri
correvano con acritica noncuranza a concetti psicologici e se
mantici (esprimere un atteggiamento, comunicare un'opinio
ne, respingere una domanda ecc.) che una seria riflessione fi
losofica sul linguaggio dovrebbe spiegare. Invece le analisi di
quei filosofi (identificabili più con i seguaci di Austin, che con
il maestro) davano tali concetti per scontati e, in particolare,
usavano il concetto di verità come se fosse stato già del tutto
chiaro il rapporto fra verità e significato. Le 'descrizioni del
l'uso', lungi dal dissolverli, inconsapevolmente pullulavano di
problemi filosofici.
Il principale tutor di Dummett nel college di Christ
Church, nel quale fu undergraduate fino al 1950, era James
O. Urmson, della cerchia di Austin. Dummett riuscì però ad
avere come tutor esterno al college Elizabeth Anscombe, al
lieva e futura curatrice degli scritti di Wittgenstein. L'insegna
mento di Anscombe fu impegnativo, Dummett racconta: «era
sempre particolarmente critica quando scrivevo cose su cui
mi aspettavo che fosse d' accordo»15. In seguito Anscombe e
suo marito Peter T. Geach, entrambi cattolici, divennero ami
ci personali di Dummett. Anche da Geach Dummett dichia
ra di aver imparato molto, soprattutto su Friedrich Ludwig
Gottlob Frege16.
13 Pataut, An Anti-Realist Perspective on Language cit., p. 12.
14 Dummett, Can Analytical Philosophy Be Systematic, and Ought It to
Be? cit., p. 445.
15 M. Dummett, IntellectualAutobiography, in The Philosophy o/Michael
Dummett, a cura di RE. Auxier e L.E. Hahn, Open Court, Chicago-La Salle
(Ill.) 2007' p. 9.
16 Cfr. M. Dummett, The Interpretation o/Frege's Philosophy, Duckworth,
London 1981, p. XV.
6