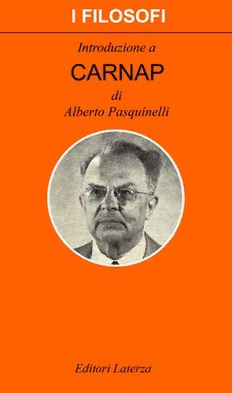Table Of ContentPrima edizione 1972
INTRODUZIONE A
CARNAP
DI
ALBERTO PASQUINELLI
EDITORI LATERZA
I. IL MANIFESTO VIENNESE
Nell'agosto del 1929, Hans Hahn, Otto Neurath
e Rudolf Carnap apposero .Je proprie firme alla pre
fazione di 1Vissenschaftliche Weltauffassung. Der
\Viener Kreis, un opuscolo di appena sessanta pagine,
che, edito entro il medesimo anno nella capitale
austriaca, per i tipi di Arthur Wolf, e sotto gli
auspici della Società Ernst Mach 1, era destinato a
costituire il manifesto del ·celebre Circolo di Vienna.
Esso rappresentava il frutto di una stretta collabo
razione fra i tre autori, i quali, dedicando espressa
mente la loro opera a Moritz Schlick, intendevano
con ciò rendere affettuoso omaggio al ' padre ' del
cenacolo vicnnese 2•
I « Verein Ernst Mach », assoctaztone culturale fondata
a Vicnna nel novembre del 1928, per iniziativa di Moritz
Schlick e di altri pensatori viennesi, alol scopo di diffon
dere la loro nuova « concezione scientifica del mondo », ar
t::omento su cui in effetti verte il presente capitolo. Si noti
che, delle circa sessanta pagine, di cui consta il ' manifesto '
pubblicato a cura della Società Ernst Mach, appena trenta
sono di testo, mentre le rimanenti includono notizie bio
bibliografiche c indici.
2 Dopo essersi laureato a Berlino, con una dissertazione
di ottica teorica scritta sotlo h guida di Max Planck, e dopo
aver pubblicato alcuni lavori di notevole interesse epistemo
logico (Raum tmd Zeit in der gegenwiirtigen Pbysik, Berlin
1917; Allgemcine Erkemtlnislebre, Berlin 1918), Morirz Schlick
iniziò il proprio insegnamento universitario a Vienna nel
1922, ove fu nominato titolare della cattedra di Filosofia
delle scienze induttive, già tenuta dal Mach e dal Boltzmann.
7
Sul significato e sulla portata del Circolo di
Vienna nella storia della filosofia contemporanea si
sono avute non poche discussioni, al punto che oggi
i tratti generali della sua dottrina possono - entro
certi limiti - venir ritenuti abbastanza noti 3• Pro
prio per questo, il primo compito da assolvere qui
è circoscrivibile al riesame specifico del contenuto
del manifesto in questione, al fine tanto di sottoli
ncarne le principali tesi, quanto - soprattutto -
di chiarirne l'intrinseco rapporto col pensiero car·
napiano.
L'opuscolo siglato da Hahn, Neurath e Carnap
si apre con un paragrafo riguardante la « preistoria »
del gruppo vienncse, paragrafo che ne identifica gli
antesignani in una serie di scienziati c fùosofi « cri-
Secondo la testimonianza di Herbert Fcigl, « il Circolo di
Vienna ebbe origine nel 1923 da un seminario diretto dal
prof. Moritz Schlick. [ .•. ] Le. sue lezioni vienncsi erano in
cominciate l'anno prima, c verso il 1925 tale nucleo diede
vita a un gruppo di studio solito a riunirsi il giovcdl sera ».
Per· la sua dinamica ed equilibrata personalità, il suo ragiO.:
nato e convincente impegno, Schlick risultò senza dubbio uno
dei più autorevoli promotori, se non proprio l'unico leader
originario, del Circolo di Vicnna, alla cui genesi tuttavia
contribul certo anche la più remota iniziativa di Hans Hahn,
Philipp Frank c Otto Ncurath, i quali, già intorno al 1907,
s'incontravano abitualmente il giovedl sera in un caffè vien
nesc per discutere eli li.!osofia della scienza. Non a caso, nel
suo necrologio del collega e amico, il Frank ricordò Hahn
come « il vero fondatore del . Circolo di Vienna ». Comun
que, a parte ogni altra considerazione, resta il fatto che solo
dopo la venuta di Schlick .nella capitale austriaca, solo dopo
la costituzione da lui ivi propiziata della Società Ernst Mach,
nonché, in ispecie, dopo il riconoscimento tributatogli dagli
amici viennesi con la stampa e con la dedica di lVissenschaft
liche \Veltauffammg, il locale movimento filosofico divenne
operante e cospicuo internazionalmente. .
3 Al riguardo si possono vedere, per esempio, V. KRAFT,
The Vienna Circle, trad. ingl., New York 1953, nonché, in
lingua italiana, F •.B ARONE, Il treopositivismo logico; Torino
1953, e J. }ORGENSEN, Origit:i e sviluppi dell'empirismo lo
gico, in AA.VV., Neopositivismo e Ultità della scien;:a, trad.
it., Milano 1958, pp. 123-249.
8
tici »,·articolata problematicàmente, dall'antichità al
l'evo attuale:
l. Positivismo ed empmsmo: Hume, gli iluml inisti;
Comte, Mill, R. Avenarius, Mach. 2. Fondamenti, scopi
e metodi della scienza etnpirica (ipotesi in fisica, geome-·
tria, ecc.); Helmholtz, Riemann, Mach, Poincaré,. Enri
ques, Duhcm, Boltzmann, Einstein. 3. Logica formale e
sue applicazioni: Leibniz, Peano, Frcge, Schri:ìder; Rus
sell, \Vhitehcad, Wittgenstein. 4; Assiomatica: : Pasch;
Peano, Vailati, Picri, Hilbert. 5. Eudemonismo e socio
/ogia positivistica: Epicuro, Hume, Bentham, Mill; Com
te, Feuerbach, Marx, Spcnccr, Miiller-Lyer, Popper-Lyn
kcus, Cari Menger · (padre) 4.
Alla venuta di Schlick da Kiel, nel 1922; e al
conseguente, determinante, impulso per gli studi
filosofici in Vienna, è dedicato il paragrafo succes
.
sivo,· la cui concisa tematica conclude il primo capi
tolo, consentendo quindi d'introdurre organicamente
l'argomento centrale di tutto Io scritto, ossia la « con�
cezione scientifica del mondo ». Questa costituisce
l'oggetto del secondo capitolo e,· data la sua rile
vanza precipua, richiede di venir illustrata con op
portune. considerazioni.
« Versare il vino nuovo in botti nuove»: ecco
come. Philipp Frank ha ben caratterizzato metafori�
camente la prospettiva insita nella wissenschaftliche
\Veltauf]assrmg, intento· della quale risulta essere
- appunto - non solo la sintesi enciclopedica del
sapere scientifico contemporaneo attraverso l'esplicita
unificazione del suo linguaggio su rigorose basi inter
soggeùive, ma anche, in ispecie, lo sviluppo di una
gnoseologia alfine 9avvero conforme agli esiti più
rivoluzionari e intellettualmente significativi della
stessa scienza odierna 5• Si tratta di un orientamento
affatto umanistico, · ove l'antico principio dei sofisti
'
4 \Vimsm chaftliche Weltaujfassung. Der Wiener Kreis,
Wicn 1929, pp. 12-3.
s In -un dichi:�rato spirito galileiano: cfr. ivi, p. 16.
9
« l'uomo è la misura di tutte le cose » viene riba
dito con aperto rilievo programmatico 6• Né la teo
logia, né la metafisica possono perciò vantare genuini
titoli di validità conoscitiva, mostrandosi, in fondo,
radicate su congerie di pseudoproblemi. L'ufficio del
la filosofia finisce col consistere proprio nella chiari
ficazione sia dell'insensatezza gnoseologica, che vizia
i discorsi teologici e metafisici, sia della precisa por
tata informativa, che contraddistingue invece gli as
serti scientifici 7•
Cosl, emergono due attributi assolutamente basi
lari della concezione del mondo propugnata dai vien
nesi: circoscrivendo - mediante la critica linguistica
della teologia e della metafisica - il campo della
conoscenza al dominio della cognizione empirica, essa
appare, da un lato, una rinnovata forma di empi
rismo o positivismo, mentre, dall'altro, rivendicando
come strumento sistematico di chiarificazione filoso
fica il metodo dell'analisi logica del linguaggio appena
delineato dal Russell e dal Wittgenstein, attinge una
profonda originalità rispetto alla tradizione psicolo
gizzante della medesima gnoseologia empidstico-posi
tivistica 8•
Più specificatamente, l'applicazione costruttiva del
metodo dcii 'analisi logica a partire dal materiale
empirico, identificabile con complessi dati sensoriali,
viene intesa come Konstitutiomtbeorie, cioè come
edificazione di un sistema di concetti adeguato per
la scienza unitaria, in quanto, sulla base d'idee rite-
6 lvi, p. 15.
7 lvi, pp. 17-8. L'immediato termine di confronto pole
mico del movimento viennesc fu costituito soprattutto dalla
tradizione ftlosofica dell'idealismo tedesco e dai suoi epigoni
antintellettualisti, allora dominanti nelle università della Ger
mania c dell'Austria. Suggestivi rilievi in proposito, sotto
forma di critica della • filosofia accademica', o • ncgativismo ',
sono espressi da R. vo:-� MISES nel suo Klcines Lcbrbucb des
Positivismus, The Haguc-Chicago 1939 (trad. it • .M anuale di
critica scientifica e filosofica, Milano 1950).
8 Wissemchaftliche \Veltau/]assrmg, cit., p. 19.
lO
nute primarie a livello fenomenico, permetta d'intro
durre ogni ulteriore nozione attraverso esatti proce
dimenti dcfmitori o riduttivi 9• Lo schema di siffatta
ricostruzione concettuale risulta già limpidamente ab
bozzato nella prima grande opera del Carnap: Der
logische Aufbatt der We lt (Berlin-Schlachtensee 1928,
oggetto del capitolo che segue), onde la «concezione
scientifica del mondo » si rivela in sostanza profilata
anzitutto quale «c ostruzione logica del mondo »; im
plicando una teoria del conoscere che attribuisce
valore dominante - quantunque non esclusivo -
alle considerazioni strutturali, per la loro puntuale
efficacia nell'individuare, fra le relazioni intrinseche
dell'esperienza, le sue stesse condizioni di attendibilità
intersoggettiva 10•
Dopo l'enunciazione di queste tesi generali, il
successivo capitolo di \Vissenschaftliche ì,Ve ltauffas
stmg ne svolge in modo continuo alcuni temi parti
colari. Preliminarmente è affrontata la questione dei
« fondamenti dell'aritmetica », a proposito della qua
le si ribadisce l'importanza delle recenti dottrine
logicista, formalista e intuizionista. Dall'insieme dei
loro contributi, vagliati con atteggiamento convenzio
nalmente impregiudicato, emerge l'inderogabile esi
genza di concepire la matematica come disciplina
analitica (priva di contenuto reale e stabilita secondo
puri canoni assiomatici), nonché di rigettarne sia
l'interpretazione sintetico-aprioristica di Kant, sia
quella sperimentale-induttiva di John Stuart Mill 11•
P�ssando all'esame del problema dei « fonda
menti della fisica », il quadro s'allarga notevolmente.
Viene concentrata l'attenzione, oltre che sulla ric-
9 I�i, pp. 19-20.
IO I vi, p. 20.
Il lvi, pp. 21-2. Queste considerazioni metamaternatiche
sono precedute da un breve cenno, mirante a sottolineare la
previa importanza della cosiddetta 'riforma della logica', ossia
la moderna rinascita della logica formale promossa da Leibniz,
L:tmbert, Boole, Venn, Frege, Schrodcr, Peano, Whitehead
e Russcll.
11
chezza . sistematica e sulla pregnanza empirica . del
metodo ipotetico-deduttivo, sul nuovo e più preciso
significato assunto nella ricerca attuale dai concetti
chiave di spazio, tempo, causalità, probabilità, e si
mili. Alle filosofie che, come il kantismo, pretendono
di sostenere l'assoluta certezza della scienza, si con
trappongono in maniera decisiva le implicazioni epi
stemologiche della teoria della relatività e della teoria
dei quanti. La stessa idea di regolarità naturale, in-
sieme con quella di processo induttivo, soggiace al
l'istanza di una seria revisione, nel momento in cui
s'impongono cogentemente il riconoscimento della
possibilità di leggi statistiche, accanto alle leggi inec
cepibili, nonché l'analisi nomologico-funzionale, in
vece che antropomorfica, della nozione di_ causa 12;
Per integrnre il discorso sull'aritmetica e sulla
fisica, viene considerata brevemente _la questione dei
« fondamenti della geometria », in rapporto alla quale
assume rilievo ·preponderante il chiarimento :del co
spicuo scarto gnoseologico che sussiste fra l'accezione
astratta e quella empirica della scienza geometrica
nel suo insieme: mentre l'una conduce soltanto. a
espressioni logico-formali, l'àltra dà origine a espres-
sioni di natura descrittiva 13•
_
Infine, il capitolo si conclude con alcuni cenni
intorno al problema dei « fondamenti » tanto della
« biologia » e della « psicologia », quanto delle
« scienze sociali ». Anche nella fattispecie viene de
nunciata l'inconsistenza di termini precariamente de
finiti, come c entelechia', c anima', c spirito dei po
poli', ecc., a favore dello sviluppo d'indagini sui fe
nomeni umani non più vitalistiche, mentalistiche, o
comunque metafisicheggianti, bensl comportamentisti
che, storico-economiche e, in ogni caso, adeguata
mente motivate sotto il profilo linguistico, argomen
tativo e fattuale 14•
'2 lvi, pp. 22-4.
13 lvi, p. 25.
!4 lvi, pp. 26-7.
12