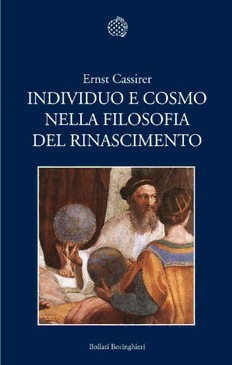Table Of ContentNuova Cultura
241
Ernst Cassirer
Individuo e cosmo
nella filosofia del Rinascimento
A cura di Friederike Plaga e Claus Rosenkranz
Introduzione di Maurizio Ghelardi
Traduzione e curatela di Giovanna Targia
EDIZIONEINTEGRALE
Bollati Boringhieri
© 2002Felix Meiner Verlag, Hamburg
Titolo originale Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, contenuto
in Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance.
Die platonische Renaissance in England und die Schule von Cambridge
(Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe ECW, Bd. 14)
© 2012Bollati Boringhieri editore
Torino, corso Vittorio Emanuele II, 86
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
isbn 978-88-339-8140-6
Illustrazione di copertina: Raffaello Sanzio, La scuola di Atene(1509-10), part.
Vaticano, Stanza della Segnatura.
Schema grafico della copertina di Pierluigi Cerri
www.bollatiboringhieri.it
Indice
ix Che cosa significa orientarsi nel pensiero,
di Maurizio Ghelardi
Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento
1 Dedica
3 Introduzione
9 1. Niccolò Cusano
54 2. Cusano e l’Italia
84 3. Libertà e necessità nella filosofia del Rinascimento
139 4. Il problema del rapporto soggetto-oggetto nella filosofia
del Rinascimento
Appendici
215 Niccolò Cusano, Idiota. Libro III: La mente
277 Charles de Bovelles, Il libro del sapiente
Postfazione
439 Storia di un testo e della sua ricezione in Italia,
di Giovanna Targia
463 Indice dei nomi
Che cosa significa orientarsi nel pensiero
Maurizio Ghelardi
Testo epigrafe, testo epigrafe, testo epigrafe, testo epi-
grafe, testo epigrafe, testo epigrafe.
Nome Cognome
1. Cassirer ad Amburgo e la Biblioteca Warburg
Sono gli ultimi mesi del 1921: dal 16 aprile Aby Warburg è rico-
verato a Kreuzlingen e Fritz Saxl, nelle vesti di direttore reggente,
presenta il primo rendiconto annuale della Kulturwissenschaftliche
Bibliothek Warburg (KBW): «I professori Cassirer, Reinhardt, Rit-
ter, Wolff, Junker e il dottor Panofsky – vi si legge – sono diven-
tati stabili frequentatori e sostenitori della Biblioteca. Si è pure
dato il caso che il professor Cassirer, in una grande conferenza
tenuta alla Società per le scienze religiose di Amburgo – tra i cui
fondatori figura anche il professor Warburg –, abbia affrontato
argomenti che in precedenza gli erano estranei, e che adesso egli ha
sviluppato grazie all’utilizzo della Biblioteca. Si tratta di questioni
che il professor Cassirer ha intenzione di ampliare in una grande
opera».1
La conferenza a cui Saxl si riferisce, che Cassirer aveva tenuto
il 14 luglio 1921 alla Religionswissenschaftliche Gesellschaft, ave-
va avuto per oggetto la Begriffs- und Klasseneinteilung im mytischen
und religiösen Denken. Il testo, grazie a Fritz Saxl,sarà pubblicato
nel 1922 nel primo volume delle «Studien der Bibliothek War-
burg», col titolo Die Begriffsform im mythischen Denken.2Qui, pun-
tualmente, si legge che si tratta solo del «primo abbozzo» e «dello
schizzo» di un disegno più ampio, che avrà al centro la filosofia del-
1iTilmann von Stockhausen, Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Architektur,
Einrichtung und Organisation, Dölling und Galitz, Hamburg 1992, p. 127.
2iCfr. Ernst Cassirer, Die Begriffsform im mythischen Denken, in «Studien der Bibliothek
Warburg», I, 1922, pp. 1-62, ora in Id., Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, XVI: Auf-
sätze und kleine Schriften 1922-1926, a cura di Julia Clemens, Meiner, Hamburg 2003, pp.
3-73; trad. it. La forma di concetto nel pensiero mitico, in Id., Mito e concetto, a cura di Ric-
cardo Lazzari, La Nuova Italia, Firenze 1992, pp. 3-93.
x Maurizio Ghelardi
le forme simboliche, di cui l’autore annuncia, a breve, la pubblica-
zione del primo volume.3
La conferenza non segna però solo l’esordio di Cassirer ad
Amburgo come professore di filosofia, ma anche l’inizio di uno sta-
bile e duraturo legame con l’ambiente warburghiano. Emblemati-
ca, in tal senso, resta una testimonianza di Fritz Saxl: la Biblioteca
Warburg aveva fatto a Cassirer l’impressione di non essere una col-
lezione di libri, bensì un insieme di problemi, e inoltre di essere la
biblioteca di un uomo ancora nel pieno delle forze, sebbene adesso
fosse costretto a vivere «nell’oscurità, dietro una porta che sem-
brava non dovesse per lui mai più aprirsi».4
D’altronde, la chiamata di Cassirer ad Amburgo non era certo
stata agevole, ma tortuosa e irta di difficoltà.
La neonata Università era stata fondata, con una legge provviso -
ria del 31 marzo 1919, sulla base dell’Allgemeines Vorlesungswesen,
creato nel lontano 1837, a cui nel 1908 era stato associato il Kolo-
nialinstitut. Nel 1916 William Louis Stern, docente di psicologia
sperimentale, al quale era stato chiesto di accollarsi anche l’inse-
gnamento di filosofia generale, aveva cercato di proporre per que-
sta disciplina Ernst Cassirer. Ma i due «pareri» (Gutachten), che si
era soliti richiedere in queste occasioni, erano stati negativi. Alois
Riehl e Carl Stumpf avevano infatti sostenuto che Cassirer era
ancora in tutto e per tutto un allievo e se guace di Hermann Cohen,
suo maestro, assieme a Paul Natorp, negli anni di Marburgo.5Die-
tro il manto del giudizio scientifico si nascondevano però ben altre
motivazioni, che concernevano, probabilmente, la fede religiosa di
Cassirer. Non a caso, tre anni dopo, non appena si era ripresenta-
ta l’occasione, Stern aveva confidato all’amico Jonas Cohn: «pur-
troppo […] la scelta è limitata dal fatto che sono ebreo e, nono-
stante la rivoluzione, è impossibile pretendere che l’Università
ac cetti due ebrei come rappresentanti della filosofia; dunque riten-
go che anche questa volta la candidatura di Cassirer sia destinata a
cadere».6 Certo è che restava pur sempre l’obbligo, da parte del-
l’Università, di nominare un filosofo che, secondo la commissione
che era stata chiamata per redigere la graduatoria, doveva essere un
3iCfr. Ernst Cassirer, Vorwort, in Die Begriffsform im mythischen Denkencit., p. v; trad.
it., p. 3, ove Entwurfè tradotto con «progetto».
4iFritz Saxl, Ernst Cassirer, in Paul Arthur Schilpp (a cura di), The Philosophy of Ernst Cas-
sirer, Open Court, La Salle (Ill.) 1949, p. 49.
5iCfr. Thomas Meyer, Ernst Cassirer, Ellert & Richter, Hamburg 2006, p. 84.
6iIbid., p. 85.