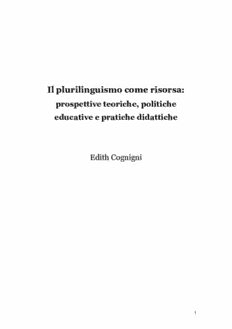Table Of ContentIl plurilinguismo come risorsa:
prospettive teoriche, politiche
educative e pratiche didattiche
Edith Cognigni
1
Apprendere una seconda lingua non equivale ad aggiungere
delle stanze alla propria casa costruendo un’aggiunta sul
retro: è la ricostruzione di tutte le pareti interne
(Cook, 2002).
Alla mia famiglia, “risorsa” inesauribile.
2
Indice
Introduzione ......................................................................................... 5
Parte prima ........................................................................................... 9
Coordinate teoriche e politiche linguistiche educative ........................ 9
Introduzione ................................................................................ 10
Capitolo 1. Il bi/plurilinguismo: un’introduzione .............................. 12
1.1 Evoluzione del concetto di bi/plurilinguismo: una sintesi .... 12
1.2 Definire il bi/plurilinguismo: alcune prospettive disciplinari
...................................................................................................... 14
1.3 Bilinguismi e plurilinguismi: principali classificazioni ......... 19
1.3.1 Il fattore età ............................................................................... 19
1.3.2 Interdipendenza linguistica e ruolo del transfer ...................... 21
1.3.3 L’organizzazione cognitiva delle lingue .................................... 23
1.3.4 Uso funzionale delle abilità linguistiche................................... 25
1.3.5 Valore sociale e rappresentazioni delle lingue ......................... 26
1.4 Valorizzare il plurilinguismo: benefici e qualche falso mito . 31
Capitolo 2. Plurilinguismo e educazione linguistica .......................... 35
2.1 Il multilingual turn nelle scienze del linguaggio ................... 37
2.2 Il multi-/plurilinguismo nelle politiche linguistiche europee:
competenze chiave ....................................................................... 40
2.3 La competenza plurilingue e pluriculturale: dal Quadro
Comune al Companion Volume .................................................. 45
2.4 L’educazione plurilingue e interculturale nel contesto europeo:
alcuni quadri di riferimento ......................................................... 51
2.4.1 Le lingue dell’educazione ......................................................... 54
2.4.2 Il curricolo plurilingue ............................................................. 57
2.4.3 Competenze e risorse dell’apprendente ................................... 61
2.5 Educazione linguistica e plurilinguismo: la prospettiva italiana
...................................................................................................... 66
2.5.1 L’educazione linguistica in Italia: un concetto precursore ....... 67
2.5.2 L’educazione plurilingue nelle politiche educative italiane ...... 71
Parte seconda ...................................................................................... 79
Verso una didattica plurilingue: ......................................................... 79
3
approcci, esperienze, contesti ............................................................ 79
Introduzione .................................................................................... 80
Capitolo 3. L’éveil aux langues per educare ...................................... 83
alla diversità linguistico-culturale ...................................................... 83
3.1 Dalla Language Awareness all’éveil aux langues ................. 83
3.2 Diffusione e contesti di applicazione dell’éveil aux langues 88
Capitolo 4. La didattica integrata delle lingue: .................................. 98
il transfer come potenziale di apprendimento .................................. 98
4.1 Sviluppo e caratteristiche della didattica integrata delle lingue
...................................................................................................... 98
4.2 Dalla DIL al curricolo plurilingue ....................................... 102
4.3 Didattica integrata e insegnamento bi/plurilingue ............ 106
4.4 Pratiche didattiche e contesti di applicazione della DIL ..... 108
Capitolo 5. L’intercomprensione tra lingue affini ............................. 115
come approccio didattico .................................................................. 115
5.1 L’intercomprensione tra lingue affini: una definizione ........ 115
5.2 Intercomprensione e abilità di ricezione .............................. 116
5.3 Dall’intercomprensione all’intercomunicazione ................. 126
5.4 Progetti, pratiche e contesti d’insegnamento dell’IC .......... 130
Capitolo 6. Il translanguaging ........................................................ 142
come pratica didattica inclusiva ....................................................... 142
6.1 Gli studi sul translanguaging: un’introduzione ................. 142
6.2 Dal plurilinguismo al translanguaging: una svolta
epistemologica? ......................................................................... 144
6.3 Praticare il translanguaging: dalla progettazione didattica alle
attività in classe.......................................................................... 148
6.4 Diffusione e contesti di applicazione del translanguaging:
l’apporto italiano ......................................................................... 157
Conclusioni: premesse per una “via italiana” alla didattica
plurilingue ..................................................................................... 163
Riferimenti bibliografici ................................................................. 167
4
Introduzione
Recentemente molti studi su comunicazione e educazione in contesto
multilingue hanno portato all’adozione di un nuovo paradigma
nell’insegnamento delle lingue, secondo cui i ricchi repertori linguistici
presenti in classe non sono più intesi unicamente come una
caratteristica– o perfino un problema da gestire – degli apprendenti,
un aspetto di cui eventualmente tenere conto in una prospettiva
contrastiva. Da una visione prevalentemente monolingue
dell’insegnamento linguistico che privilegiava l’immersione totale
nella lingua obiettivo e una prospettiva ‘verticale’ dell’apprendimento
delle lingue, la glottodidattica del nuovo millennio si è
progressivamente orientata verso una “svolta plurilingue” (Conteh e
Meier, 2014), che vede nella capacità dell’apprendente di saper gestire
più lingue e varietà linguistiche un plusvalore e una risorsa per
l’apprendimento e per la comunicazione interculturale.
Quali possono essere i benefici del plurilinguismo in senso ampio e,
più specificamente, rispetto all’apprendimento di ulteriori lingue?
Perché si dovrebbero valorizzare la diversità linguistica e le
competenze plurilingui presenti in classe? Quali politiche linguistiche,
europee e nazionali, ne costituiscono le premesse orientandone le
direzioni? Quali approcci didattici, infine, possono facilitare la
gestione di questo potenziale, spesso sottostimato, facendone una
risorsa per l’apprendimento autonomo e guidato?
Questi ed altri quesiti sono al centro del volume in cui il plurilinguismo
è considerato innanzitutto un tratto endogeno dello spazio linguistico
italiano, oltre che una conseguenza delle migrazioni attraverso cui
numerose altre lingue e varietà di lingue si sono aggiunte al già ricco
panorama sociolinguistico del Paese. Concepito in questo senso
ampio, il plurilinguismo viene interpretato come una condizione che
accomuna la gran parte degli alunni nei vari contesti educativi
nazionali, siano essi ‘italiani’ o ‘di cittadinanza non italiana’, nelle varie
declinazioni possibili che i due termini possono assumere
(dialettofoni, stranieri neo-arrivati, seconde generazioni, figli di
coppie miste…). A questa pluralità linguistica di cui sono testimoni
alunni ‘stranieri’ e non, sempre più spesso si accompagna infatti una
storia familiare di migrazione o di temporanea mobilità che accomuna
5
ormai ‘italiani’ e ‘stranieri’. La pluralità dei riferimenti linguistici e
culturali che questo processo implica costituisce dunque un fertile
terreno di confronto negli odierni contesti educativo-formativi italiani,
i quali sono chiamati non solo a prenderne atto, ma anche a valorizzarli
e a farne una risorsa educativa intorno a cui articolare percorsi ed
attività didattiche che mirino ad un’effettiva inclusione, evitando
visioni esotizzanti o dicotomiche tra “noi” e “l’altro”.
Per introdurre tale tematica, nella prima parte del volume si fornisce
una sintesi delle principali prospettive disciplinari sul
bi/plurilinguismo in quanto fenomeno individuale e delle sue
classificazioni più diffuse in letteratura, proponendone una rilettura
critica in chiave plurilingue, anche attraverso esempi tratti dal
contesto italiano.
La necessità di questo cambiamento di prospettiva è fortemente
auspicato da anni anche dalle politiche linguistiche educative europee
e nazionali, attraverso la diffusione di documenti, linee guida, e con la
promozione di azioni di cui si fornisce un quadro critico nel secondo
capitolo. Vi si sottolinea, in particolare, la portata innovatrice
dell’educazione linguistica democratica quale concetto precursore
dell’odierna nozione di educazione plurilingue e interculturale di
matrice europea, e cornice concettuale per una possibile “via italiana”
alla didattica plurilingue.
La seconda parte del volume prende quindi in esame gli approcci1 e le
strategie didattiche ritenuti più appropriati alla messa in opera di una
didattica plurilingue, focalizzando ciascuno dei quattro capitoli su un
diverso approccio plurale (éveil aux langues, didattica integrata delle
lingue, intercomprensione tra lingue affini) o sul translanguaging. A
partire da un inquadramento storico, ciascun approccio viene
presentato nelle sue caratteristiche distintive e potenzialità, fornendo
spunti operativi ed esempi di attività sperimentate in diversi contesti
educativo-formativi italiani e esteri.
1 Si adotta qui il termine ‘approccio’ in conformità con l’uso che se ne fa nella versione
originale del Carap e nelle sue varie traduzioni (approche, approach, approccio…),
in linea con la nozione epistemologica di ‘approccio’ in glottodidattica. Gran parte
degli approcci plurali, come il translanguaging, sono interpretabili come “filosofie
di fondo” in grado di generare “metodi” per l’educazione linguistica e, attraverso
questi ultimi, l’implementazione di metodologie e tecniche afferenti al “mondo
dell’azione didattica” (Balboni, 2015: 9-10).
6
Si tratta di approcci contigui che spesso si sovrappongono o si
integrano tra loro, oggetto di ricerca ed applicazione in varie parti del
mondo. Alcuni di questi sono presenti da tempo nei curricoli di diverse
realtà scolastiche europee e nord-americane, dove sono proposti ai fini
dell’implementazione di un’educazione plurilingue e interculturale.
Sebbene anche nel nostro Paese siano presenti diverse
sperimentazioni e pratiche didattiche ispirate a questi approcci,
restano ancora poco noti o applicati. Ad eccezione di qualche recente
volume sul tema (ad es. Calò, 2015 per gli approcci plurali), i numerosi
contributi che se ne sono finora occupati si concentrano per lo più su
uno di questi approcci singolarmente, oppure sono in lingua straniera
e/o trattati in numerosi articoli e riferimenti, limitando così la
possibilità di una loro effettiva diffusione nella scuola italiana. Il
volume mira dunque a darne una panoramica integrata ed aggiornata,
che chiarisca l’opportunità e il senso di ciascuno degli approcci
summenzionati, mettendone in luce le possibili criticità e le condizioni
di applicabilità in vari contesti educativi.
7
Legenda delle sigle2
L1 = lingua della prima socializzazione, non sempre coincidente con la
lingua di scolarizzazione.
L2 = lingua seconda, ovvero una lingua appresa nel contesto in cui si
parla; secondo un’ottica acquisizionale può riferirsi anche a qualsiasi
lingua appresa dopo la L1.
LS = lingua straniera, ovvero una lingua diversa da quella del contesto
in cui si vive e generalmente appresa attraverso percorsi di istruzione
formale.
Ln = lingua aggiuntiva, ovvero una lingua successiva a L1 e L2/LS in
apprendenti già bi/plurilingui (n > 2).
LO = lingua di origine, ovvero una lingua familiare o della comunità di
appartenenza in apprendenti con background migratorio.
EPI = educazione plurilingue e interculturale (cfr. §2.4)
EAP = éveil aux langues (cfr. cap. 3)
DIL = didattica integrata delle lingue (cfr. cap. 4)
IC = intercomprensione tra lingue affini (cfr. cap. 5)
2 Si esplicitano alcune sigle utilizzate nel volume, dando una breve spiegazione di
quelle inerenti alla lingua (L1, L2, LS, ecc.). Si rimanda ai paragrafi o capitoli del
volume indicati per una spiegazione delle altre nozioni.
8
Parte prima
Coordinate teoriche e politiche
linguistiche educative
9
Introduzione
È convinzione comune che il parlante bi/plurilingue sia colui che
possiede una competenza elevata in almeno un’altra lingua oltre alla
propria. In realtà, dare una definizione di che cosa sia il
bi/plurilinguismo è abbastanza complesso, data la varietà di nozioni e
parametri da considerare, nonché le numerose prospettive disciplinari
tramite cui il fenomeno è stato studiato. Questa complessità di nozioni
e parametri – tra cui, ad esempio il livello di competenza in entrambe
le lingue, l’età in cui si è iniziato ad imparare la/e lingua/e in oggetto,
la loro frequenza d’uso, ecc. − ha fatto sì che non esista un vero e
proprio consenso su tale concetto, mentre coesistono in letteratura
molteplici definizioni e classificazioni nate a partire dai parametri di
volta in volta adottati come punto di osservazione. Sono infatti molte
le discipline che si occupano di questo fenomeno, ognuna delle quali
ha posto l’accento su alcuni aspetti specifici. La sociolinguistica, ad
esempio, ha approfondito gli aspetti inerenti all’utilizzo e alla
commistione di diversi codici in contesto sociale, la psicologia si è
focalizzata soprattutto sui risvolti psicologici legati all’esperienza
bilingue, la sociologia ha esaminato il fenomeno in relazione alla
comunità in cui si sviluppa, le neuroscienze si sono soffermate sulle
caratteristiche cerebrali del parlante bilingue, mentre la didattica delle
lingue ha proposto metodologie di insegnamento appropriate in base
a quanto emerge da questi ed altri ambiti di ricerca, secondo la
prospettiva transdisciplinare che le è propria (Balboni, 2015).
Dati gli scopi di questo volume, nel primo capitolo di questa sezione si
forniscono alcune prospettive disciplinari sul bi/plurilinguismo,
funzionali a definire i contorni del fenomeno e trarne opportune
indicazioni per l’ambito educativo, di cui si tratterà più diffusamente
nei capitoli successivi. Molti di questi concetti e prospettive sono
infatti utili a comprendere gli sviluppi passati e futuri degli studi sul
bi/plurilinguismo e come essi abbiano progressivamente condotto alla
odierna nozione di plurilinguismo utilizzata in ambito educativo (cfr.
cap. 2). Una prima distinzione terminologica va operata tra i termini
‘bilinguismo’, ‘plurilinguismo’ e ‘multilinguismo’ che, seppure a volte
utilizzati in modo intercambiabile, fanno riferimento a fenomeni
parzialmente differenti nel contesto della ricerca scientifica e, come
illustrato nel capitolo 2, nell’ambito delle politiche linguistiche delle
istituzioni europee. In particolare, bilinguismo e multilinguismo
10