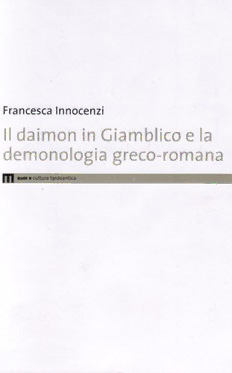Table Of ContentPremessa
Il titolo di questo lavoro richiede, innanzitutto, una dovuta
precisazione terminologica intorno al concetto precristiano di
6aiµrov (riferibile a quel sostrato religioso e culturale comune
mente chiamato paganesimo): un concetto più ampio e sfaccet
tato rispetto a quello dominante nel mondo odierno, se si consi
dera che la nozione del 6aiµrov comprende anche il significato e
le funzioni dell'angelo giudaico-cristiano. Ne1 secolo scorso una
certa tendenza alla demitologizzazione, che ha determinato la
scarsa popolarità delle entità angeliche e demoniche in quanto
figure già analizzate in passato, non ha tenuto conto delle istanze
storico-sociali che necessariamente accompagnano gli studi demo
nologici, nonché il ricco e brulicante immaginario di credenze alla
base: ancora sotto il pontificato di Woytila, Satana, padre della
menzogna, è ritenuto responsabile di tutti gli errori, malattie e
devianze, ad iniziare dall'aborto e dall'eutanasia.
Per quanto riguarda l'opera di Giamblico di Calcide, l'autore
su cui in particolare ci soffermeremo, la storiografia degli ultimi
cento anni presenta evoluzioni notevoli, probabilmente non
disgiunte dai condizionamenti socio-culturali subiti dai vari inter
preti. Alla nota tesi di E. Zeller secondo cui la scuola di Giamblico
sarebbe stata dominata da un'alterazione del carattere specula
tivo del sistema metafisico neoplatonico, e quindi, in sostanza,
da una degenerazione nell'irrazionalismo1, ha fatto seguito, negli
anni Venti del secolo scorso, la lettura di K. Praechter, che ha
1 Cfr. E. Zeller, R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, Firen
ze, La Nuova Italia, 1961, voi. VI, III, p. 10.
8 PREMESSA
al contrario ribadito il valore metafisico-speculativo del pensiero
giamblicheo, ponendo l'accento soprattutto sull'attività di esegeta
delle opere di Platone e di Aristotele2.
Negli ultimi decenni, in particolar modo a partire dalle ricerche
di G. Shaw3, si è fatto strada un nuovo concetto storiografico,
che recupera il fattore teurgia lasciato in subordine dal Praechter,
riabilitandolo e dotandolo di spessore filosofico; tra metafisica e
teurgia esisterebbe un nesso strutturale, in quanto la prima fonda
ontologicamente il culto, mentre la seconda sopperisce ail'incapa
cità della ragione di salvare l'anima umana, venendo a costituire
un'efficace alternativa alla contemporanea escatologia cristiana.
Questa teoria sembra valida ed apprezzabile anche perché presta
la dovuta attenzione all'aspetto storico, riconoscendo esplici
tamente l'imprescindibilità della metafisica neoplatonica dalle
esigenze religioso-ideologiche dell'epoca.
In tale ambito, la mia ricerca intorno alla demonologia di
Giamblico in rapporto alla tradizione precedente mira a puntua
lizzare ed approfondire alcuni concetti riferibili all'attuale
valutazione critica della filosofia del Calcidese, spunto per una
riflessione sulle interazioni tra la cosiddetta cultura "alta" e le
credenze "basse" e popolari, usualmente considerate tra loro
antitetiche. L'opera giamblichea che consente appieno la rico
struzione di una dottrina demonologica, il De mysteriis, auto
rizza ad annoverare il nostro autore tra i propugnatori di quella
teoria del 8aiµcov mediatore che fa capo al Simposio di Platone;
questa teoria risulta, come vedremo, sintesi teoretica del patri
monio religioso precedente, senza trascurare l'apporto delle
suggestive formulazioni pitagoriche che, con la loro equazione
demone-anima, paiono in stretta relazione con la tradizione
popolare. Queste formulazioni confluiscono nella concezione del
demone custode (oggetto di studio nel secondo capitolo), rile
vabile nel pensiero greco già a partire dall'epoca arcaica: nelle
2 Cfr. K. Praechter, Die Philosophie des Altertums, Berlin, Schwabe, 1926, p. 591.
3 G. Shaw, Theurgy. Rituals of unification in the neoplatonism of Iamblicus, in
«Traditio», 41, 1985, pp. 1-28.
PREMESSA 9
Opere e i giorni di Esiodo i oaiµoveç sono le anime degli uomini
di prima e seconda generazione, le razze d'oro e d'argento (i
primi dei quali sono terrestri, i secondi sotterranei), incaricate da
Zeus di proteggere e custodire i mortali; la categoria del demo
nico si presenta qui stratificata ed inserita in un progetto finali
stico preciso, non ancora rilevabile nei poemi omerici4• Vedremo
in che modo l'immagine dell'ente protettore dell'individuo, che
passa per un percorso piuttosto lineare da Socrate a Plotino,
viene rinnovata, con estrema coerenza e rigore, da Giamblico
nel nono libro dell'epistola a Porfirio.
Il terzo aspetto dell'indagine demonologica, quella sul demone
malvagio, impone una riflessione sul dualismo, inteso, da un
lato, come rimozione da parte della filosofia del "lato oscuro"
del divino, che, agli occhi del teologo, non può racchiudere in sé
nulla di diverso da una placida ed incorruttibile bontà; dall'altro,
come conseguenza dell'infrangersi di una visione compatta e
lineare del mondo, nella misura in cui si affacciano nuovi modi
di concepire lo Stato, la società, i reciproci rapporti tra gli uomini
e tra l'uomo e Dio, con particolare evidenza nel momento in cui
si diffonde una corrente ideologica incisiva e minacciosa come
il credo cristiano; il reale viene allora concepito a più livelli ed
acquista maggior spessore la personificazione metafisica del male,
di un'alterità quotidianamente percepita come la più temibile
avversaria dell'assetto costituito. Ci troveremo quindi ad affron
tare le interrelazioni tra oaiµrov, materia, problematica del male,
apologetica, esaminandone il significato in rapporto alle esigenze
epocali. Indubbiamente lo studio della demonologia acquista
senso se non si perde di vista l'importanza della valutazione
storica: questa consente di ipotizzare che la strutturazione meta
fisica giamblichea sia leggibile alla luce della realtà politica oltre
che religiosa, una realtà caratterizzata da un potere sempre più
stratificato, il cui sommo vertice si fa sempre più lontano, astratto
ed inconoscibile.
4 Per il 6aiµcov in Omero ed Esiodo si veda U. Bianchi, .1.101: AIEA. Destino, uomini
e divinità nell'epos, nelle teogonie e nel culto dei Greci, Roma, Signorelli, 1953.