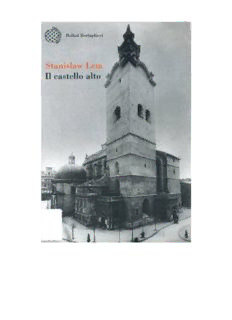Table Of ContentIl castello alto
Stanislaw Lem
Traduzione di Laura Rescio
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, 1999
© 2008 Barbara e Tomasz Lem
© 2008 Bollati Boringhieri editore s.r.l.,
Titolo originale Wysoki zamek
ISBN 978-88-339-1874-7
Ora mi accorgo di non essere affatto riuscito a realizzare la prima intenzione con
cui mi ero messo a scrivere: affidarmi alla memoria, seguirne docilmente i comandi
e addirittura, astenendomi da ogni riflessione, rovesciare da essa tutto ciò che
conteneva, come si rovescia il contenuto di una pentola sul tavolo, nella convinzione
che se una certa cosa era stata registrata, dovesse essere importante e che quindi ciò
che se ne riversava, come i frammenti di vetro colorato di un caleidoscopio rotto, si
sarebbe disposto in un disegno significativo. O forse non in un unico disegno, ma in
una molteplicità di disegni che si penetrassero a vicenda, cui sarebbe stato possibile
trovare svariate sistemazioni, benché in uno stato rudimentale, cautamente allusivo;
e così, grazie a questo stratagemma, più che raccontare in breve la mia infanzia, che
oggi costituisce soltanto un'idea astratta, una specie di me stesso spalmato lungo
diversi calendari, lungo quei foglietti neri e rossi, avrei delineato un ritratto - o il
meccanismo - della memoria, che non è un ripostiglio perfettamente passivo e a me
del tutto estraneo, un deserto capiente, una scrivania dell'anima con una quantità di
pertugi e nascondigli, ma non è neppure me. Non è me, perché rappresenta una forza
tutta sua, che non è avida delle stesse cose di cui lo sono io e non è sensibile o
indifferente verso le stesse cose cui lo sono io; infatti molte volte non ha registrato
ciò che avrei tanto desiderato ricordare e, al contrario, molte volte ha registrato ciò
che mi interessava di meno. E quindi è lei, non me, che avrei voluto indurre il più
possibile a rilasciare deposizioni intese a formare il suo stesso ritratto, di cui d'altra
parte ero pronto a prendermi la responsabilità, benché non avessi un completo
controllo su di lei né allora, né adesso. Doveva essere un esperimento i cui risultati
mi interessavano davvero, come se non si trattasse affatto di me, come se non fosse
da me che dovevano provenire le immagini e le relazioni, ma dalla bocca dì
qualcuno che non ero io. Solo, in qualche modo, quel qualcuno che si trovava dentro
di me tanto tempo fa era nascosto, come gli anelli interni di un albero risalenti al
tempo della sua infanzia e giovinezza, da una quantità di stratificazioni dell'età
matura. In questo senso si può affermare, ormai quasi letteralmente, che il giovane
alberello di decenni fa e contenuto all'interno dell'albero grande. Davvero non so
quando sia stata la prima volta che mi meravigliai di esserci e al tempo stesso mi
spaventai anche un po' della possibilità di non esserci affatto o di essere uno stecco,
o un soffione, una zampa di capra o una lumaca. O addirittura un sasso. A volte mi
sembra che sia accaduto ancor prima della guerra e dunque nel periodo qui
descritto, ma non ne sono totalmente certo. In ogni caso quella sensazione di
meraviglia non mi ha ancora lasciato, anche se non è diventata una fissazione. Poi
l'ho avvicinata da diverse parti, mi ci sono accostato in maniere diverse e a volte mi
capitava di riconoscere che ormai era totalmente priva di senso, una cosa di cui ci si
deve vergognare come di un'imperfezione. Ma poi di nuovo tornavo a domandarmi
perché nella mia testa i pensieri andavano proprio in quella direzione e non in
un'altra, che cosa li disponeva e li dirigeva; per qualche tempo fui abbastanza
convinto che la mia anima, e in particolare la mia coscienza, si trovasse in un punto
situato circa quattro o cinque centimetri all'interno del mio viso, dietro al naso, un
po' più in basso degli occhi. Perché proprio lì, non ho idea.
Era senz'altro una «subfilosofia», così come un tempo precedente, invece del
pensiero c'era stato un «subpensiero» o un «prepensiero». Anche questo, con tutto il
beneficio d'inventario, volevo allontanarlo dalla memoria. Doveva accadere
automaticamente, ma la fatica stava nel limitarsi esclusivamente ai ricordi, nello
svuotare, in un certo senso, quella pentola metaforica; però non ci sono riuscito.
Vedo che nel ricordare, volente o nolente, mettevo in ordine i ricordi stessi, così che
si disponessero a formare tracce che puntavano abbastanza chiaramente verso di
me, verso un me odierno, il cosiddetto letterato, cioè una persona che esercita una
delle professioni meno serie e più imbarazzanti: quella di produrre invenzioni
estremamente laboriose, cui si accompagnano varie definizioni erudite che non si sa
bene cosa vogliano dire, quale «tecnica della scrittura». Per quanto mi riguarda,
non posseggo alcuna tecnica del genere. In ogni caso, finora non me ne sono mai
accorto. E quindi, qualsiasi cosa si sia riversata dal sacco della memoria, subito, al
volo, è stata da me interpretata, anche se certo in maniera molto lieve. Qui non si
tratta di bugie drastiche, di alterazione. È avvenuto in maniera del tutto automatica e
in nessun modo intenzionale. Ma non voglio giustificarmi.
Soltanto adesso, un quarto di secolo più tardi, in seconda istanza, come un
detective che sulle tracce di un misfatto compiuto tenti, con un gioco di prestigio, di
ordinare quanto nell'accadere non era assolutamente ordinato e non indicava verso
la mia direzione odierna, vedo che tuttavia nel complesso si è creata una freccia che
punta verso di me. Questo è tanto più strano perché non ho mai ritenuto di essere
uno «scrittore nato», che hoc erat in votis. E continuo a pensarlo. Vuol dire che in
quella infanzia e nella stanza di sbratto che ne è rimasta doveva trovarsi tutta una
serie di tracce che si incrociavano, di percorsi da decifrare, da scoprire, per lo più
confusi, tronchi, che finivano in vicoli ciechi; forse non c'era nessuna traccia, ma
solo tanto spazio e a volte delle isolette sparse; eppure non era un caos totale, c'era
una casa, una scuola, dei genitori, e il fatto che, da piccolissimo, giocavo ad
appiccicarmi sul naso delle foglioline verdi e che da più grande indossavo una divisa
scolastica: tutto ciò già creava un ordine abbastanza netto. Ma forse era un ordine
come quello di una scacchiera vuota, dove si possono vedere delle strisce bianche e
nere che ne percorrono la lunghezza, trasversalmente, o in diagonale. Basta mettere
un piccolo impegno nello sguardo perché tutto si strutturi come vogliamo. La
scacchiera continua a essere una scacchiera e non vi vedremo nulla oltre a quello
che c'è davvero - quadrati bianchi e neri alternati – ed é solo l'ordine, la direzione,
la rotta che cambia d'improvviso. Forse qualcosa di stranamente simile e accaduto
con la scacchiera della memoria che è stata disposta qui. Non ho aggiunto nulla, ma
tra i molti ordini che si potevano trovare ne ho messo in risalto uno. È andata cosi
perché si cerca involontariamente un leitmotiv, un asse portante, una coerenza nella
vita? Per non ammettere nemmeno a me stesso che tante delle direzioni intraprese
sono state abbandonate, lasciate andare, sprecate? Forse solo perché si vuole che
ciò che è e ciò che e stato abbiano sempre avuto un senso ordinato e preciso, anche
se non e detto che sia stato per forza così? Come se non bastasse solo e
semplicemente vivere, non dico da adulti - quando lo stato ameboide, la mancanza di
significati chiari, non è accettabile - ma nell'infanzia? Volevo dar voce onestamente
al bambino, disturbandolo il meno possibile, e invece mi sono arricchito alle sue
spalle, gli ho frugato nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, per vantarmi davanti ai
vecchi di come prometteva bene, di come persino i suoi peccatucci fossero future
virtù in nuce, per giustificare in qualche modo quella rapina l'ho trasformato in un
bel cartello indicatore, in, quasi, un sistema. Così ho scritto un altro libro, come se
non avessi saputo fin dall'inizio, come se non avessi intuito che non avrebbe potuto
essere altrimenti, che ogni intenzione di austero riserbo che presiede alla
verbalizzazione dei ricordi è un'illusione. Ho detto anche troppo, ho commentato, ho
interpretato i segreti e i giochi altrui, perché non sono mica i miei, non li ho più, non
esistono, ho costruito un sepolcro per quel bambino, ce l'ho rinchiuso, con attenzione
e con cura, tranquillo, obiettivo, come se avessi descritto un personaggio inventato,
mai vissuto, che si può modellare secondo canoni estetici, seguendo la propria
volontà e un progetto. Non è stato un comportamento onesto. Non si fa così con un
bambino.
1.
Ricordate l'inventario delle cose misteriose trovate dai lillipuziani nelle tasche di
Gulliver? Quegli oggetti segreti e fantastici, come il pettine-palizzata, l'enorme
orologio dal rumore ritmico e molti altri, dallo scopo assolutamente incomprensibile?
Anch'io una volta sono stato un lillipuziano. Facevo conoscenza con mio padre
arrampicandomi su di lui quando stava seduto sulla sedia dall'alto schienale e
penetravo le tasche che lui mi consentiva tra quelle del suo abito nero odoroso di
tabacco e di ospedale. Nel taschino sinistro del panciotto portava un cilindro
metallico che assomigliava a un proiettile da caccia grossa e si svitava, mostrando
all'interno una piramide di piccoli imbuti nichelati infilati l'uno sull'altro, ognuno dal
calibro minore del precedente. Erano specoli. Nella tasca vicina c'era una matita che
all'epoca delle mie prime indagini era quasi del tutto consumata, in un'impugnatura
d'oro che, premuta - ma con una forza maggiore di quella che ero in grado di
esercitare io - faceva uscire di scatto la mina della matita. Nella redingote si trovava
una scatoletta di metallo, con un rivestimento interno di velluto, che si apriva con uno
schiocco piuttosto minaccioso, poi c'era un borsellino piccolo piccolo, ma non per le
monete, perché non conteneva altro che una strisciolina di pelle scamosciata che,
slacciando un bottone, si stendeva da sola. C'era anche una scatoletta d'argento con
un pulsantino sul coperchio e dentro una piastrina che sembrava d'argento con una
gomma piatta color viola scuro fissata alla parte inferiore, ma non ci si potevano
mettere le dita, perché si sporcavano immediatamente d'inchiostro; dalla parte
opposta della redingote c'era uno specchio rotondo con un buchino al centro,
incrinato, assicurato a un cinturino nero da una fibbia. Questo specchio mi ingrandiva
notevolmente il viso e il mio occhio diventava una sorta di immenso stagno dove
l'iride castana galleggiava come un pesce rotondo e le ciglia spesse erano come l'erba
cannella che cresce intorno allo stagno. A una catena d'oro era fissato, nel panciotto,
un orologio piatto, anch'esso d'oro, con tre casse. Aveva delle cifre che si chiamavano
romane e una piccola lancetta dei secondi. Io non ero capace di aprire da solo le casse
dalla parte posteriore e non sempre lo si poteva fare. Là dentro vivevano rotelline con
occhietti di rubino che luccicavano e giravano. Fu così che conobbi mio padre: da
vicino. Portava camicie bianche a righine nere con i polsini allacciati da bottoncini e
con il colletto duro trattenuto da bottoni fermacolletto. Sugli scaffali dell'armadio
della biancheria c'erano molti di questi colletti, ormai vecchi. Erano piacevoli da
toccare nella loro elastica rigidità e io avevo sempre l'impressione che se ne sarebbe
potuto fare qualcosa di interessante, di utile, ma non riuscivo mai a scoprire che cosa
esattamente. La cravatta era morbida, nera, sembrava un nastro e si annodava in una
specie di fiocco. Il cappello aveva bordi larghi e flosci e un elastico perfetto da tirare.
Mio padre si accompagnava con due bastoni di cui uno a volte si perdeva da qualche
parte; erano bastoni alquanto normali, mentre mio zio ne aveva uno interessante, con
una testa di cavallo d'argento; poi a volte veniva a trovarlo un signore indicibilmente
vecchio, che faceva fatica a muoversi e che usava ancora un altro bastone, dal pomo
d'avorio. Da vicino però non lo vidi mai, perché non appena arrivava mi nascondevo;
ansimava spaventosamente. Ignoravo che non lo facesse per spaventarmi. Anch'egli
doveva essere qualche zio, forse un prozio, ma a mio parere non lo sembrava per
niente.
Abitavamo al numero quattro di via Brajerowska, al secondo piano. Di solito io e
mio padre andavamo a passeggiare al Giardino dei Gesuiti, oppure salivamo per il
viale Mickiewicz, verso la chiesa ortodossa di San Giorgio. Non so perché mio padre
portasse il bastone, perché a quell'epoca non vi si appoggiava affatto. Nelle mattinate
d'inverno, quando nel Giardino c'era ancora troppa neve, passeggiavamo sulla
Marszalkowska, davanti all'Università Jan Kazimierz dove, sollevando la testa,
potevo guardare le enormi figure seminude di pietra con i loro strani cappelli,
immobili e intente a svolgere le loro incomprensibili funzioni: una stava seduta,
un'altra reggeva un libro aperto appoggiato su un ginocchio nudo. Tenere la testa
continuamente sollevata sarebbe stato estenuante, quindi di regola osservavo mio
padre che procedeva accanto a me più o meno all'altezza delle ginocchia, non molto
più in alto. Una volta mi accorsi che mio padre non portava le sue solite scarpe con le
stringhe, ma altre calzature che non conoscevo affatto, lisce, senza traccia di lacci.
Erano scomparse anche le sue ghette, da cui non si separava mai. «Dove hai preso
quelle scarpe?» gli chiesi stupito e allora dall'alto risuonò una voce sconosciuta: «Ma
che sfacciato!»
Non era affatto mio padre, ma un signore del tutto estraneo a cui mi ero aggregato
non so come; mio padre camminava una decina di passi dietro di me.
Rimasi allibito. Dev'essere stata un'esperienza straordinariamente sgradevole, visto
che riesco a ricordarmela così bene.
Il Giardino dei Gesuiti non era particolarmente grande, eppure una volta mi ci
smarrii; ma accadde così tanto tempo fa ed ero così piccolo che in realtà non è un mio
ricordo, me l'hanno solo raccontato. Tra alti arbusti che forse erano di nocciolo,
perché avevano i ramoscelli rossi, si trovava una grande botte d'acqua; a quanto pare
trent'anni dopo l'ho trasferita nel racconto intitolato Il giardino delle tenebre, A dire
la verità, il Giardino dei Gesuiti non aveva nulla di particolarmente attraente. Il parco
Stryjski era tutt'altra cosa. Là c'era un laghetto a forma di otto e a destra si apriva un
vialetto che andava fino alla fine del mondo. Forse perché non ci si avventurava mai,
non so. Forse me l'aveva detto qualcuno. O forse, tutto sommato, me l'ero inventato
io e per molto tempo fui persino incline a crederci. Il parco Stryjski aveva una
topografia complicata, oltre a essere meravigliosamente vicino all'area espositiva
della Fiera dell'Est. Estate e inverno lo dominava la torre quadrata di Baczewski,
completamente rivestita da file e file di bottigliette piene di un liquido colorato. Io ero
curioso di sapere se contenessero davvero liquore o solo acqua colorata, ma nessuno
lo sapeva.
Di solito al parco Stryjski si andava in carrozzella, mentre al Giardino dei Gesuiti
si arrivava a piedi. Ed era un peccato, perché la carreggiata davanti all'Università era
rivestita di speciali tavole di legno e gli zoccoli dei cavalli, nel colpirla, emettevano
un suono particolare, proprio come se li sotto si nascondesse un grande spazio vuoto.
Questo non significa che andare a passeggiare così vicino non mi facesse piacere.
All'entrata del giardino stava seduto un uomo con la ruota della fortuna. Qualche
volta riuscivo a vincere dei portasigarette di latta con dentro nastrini gialli per tener
ferme le sigarette, ma nella maggior parte dei casi solo degli specchietti da tasca a
due facce. C'erano anche carretti che vendevano gelati ma non mi era permesso
mangiarli. E poi, quando fui un po' più grande, a volte incontravo anche Anusia. La
vecchietta, che non era molto più alta di me e portava occhiali dalla montatura
metallica e un paniere pieno di ciambelline, era stata un tempo la mia prima
bambinaia. Le ciambelline erano due per cinque groszy, quelle che preferivo, oppure
più grosse, una per un cinquino. Una moneta da dieci groszy si chiamava «sestino»:
erano un sacco di soldi.
Dal giardino si tornava a casa direttamente oppure facendo il giro da piazza
Smolka, con al centro la sua statua in pietra, per comprare frutta o addirittura la
composta di ciliegie in una scatoletta di latta, che era una ghiottoneria rara, nel
negozio di Orenstein. Nella vetrina c'erano sempre piramidi di piccole mele
vermiglie, arance e banane con un adesivo ovale con su la scritta Fyffes. Ricordo
questa parola, ma non so che cosa potesse significare. Poco più avanti, dove iniziava
la via Jagielloriska, c'era il cinema Marysierika. Non mi piaceva affatto, perché ci
andavo con mia madre quando, evidentemente, non sapeva cosa farmi fare. Non
capivo quel che accadeva sullo schermo. Mi annoiavo a morte. Spesso finiva che,
pian piano, di soppiatto, dalla poltrona mi lasciavo scivolare a terra e iniziavo a
esplorare a quattro zampe il freddo pavimento circostante, aggirandomi tra le gambe
degli spettatori, ma presto anche questa attività mi veniva a noia. Allora dovevo
aspettare la fine del film. I signori e le signore sullo schermo aprivano e chiudevano
la bocca senza produrre alcun suono, si sentiva solo una musichetta. Prima di
pianoforte, poi forse prodotta dai dischi di un grammofono.
Ma insomma, dovevamo tornare a casa. Da piazza Smolka si passava attraverso via
Podlewski, una strada insignificante, e poi per certe viuzze, via Chopin e via
Moniuszko, dove un forte odore di caffè torrefatto preannunciava l'imminente
comparsa della nostra casa. Il portone di ferro era nero e pesante, subito seguito da
dei gradini di pietra. Dalla scala posteriore, quella della cucina, non si doveva
passare: era a chiocciola, molto tortuosa, ed emetteva un sordo rimbombo metallico.
Mi attirava moltissimo, ma probabilmente nel cortile da cui si dipartiva vivevano dei
ratti. Una volta, dovevo avere sui dieci o undici armi, ne comparve uno addirittura in
cucina. Fu un momento terrificante: quando cercai di colpirlo con l'attizzatoio mi
saltò sul petto, io fuggii e non so nulla della sua sorte successiva.
Abitavamo in sei stanze, ma io non ne avevo una tutta per me. Accanto alla cucina
c'era un vano di passaggio con un bagno dietro a una porta dipinta dello stesso colore
della parete, un logoro sofà, una credenza vecchia e brutta e, sotto la finestra, gli
armadietti in cui mia madre conservava le provviste. Sul corridoio si aprivano le
porte della sala da pranzo, dello studio di mio padre e della camera da letto dei miei
genitori; porte separate conducevano a una zona proibita, dove si trovavano la sala
d'aspetto dei pazienti e l'ambulatorio di mio padre. Abitavo quindi ovunque e in
nessun luogo. All'inizio dormivo con i miei genitori, poi su un divano letto in sala da
pranzo; tentavo di stabilirmi definitivamente da qualche parte, ma per un motivo o
l'altro non ottenevo mai risultati. Quando faceva caldo occupavo il piccolo balcone di
pietra su cui si affacciava lo studio di mio padre e da lì sferravo attacchi alle case
circostanti, i cui camini fumanti si trasformavano in navi da guerra. Sul balcone mi
piaceva anche giocare a Robinson Crusoe o a me stesso su un'isola deserta. I miei
interessi, fin da piccolissimo, si aggiravano attorno a sensazioni di tipo gastronomico,
quindi l'accumulo di cibo era la questione fondamentale. Dunque chicchi sgranati di
mais in piccoli cartocci, o addirittura fave, quando veniva la stagione; ciliegie,
materia prima per le munizioni, perché i noccioli erano ottimi proiettili per armi
leggete oppure bastava stringerli forte e lasciarli sgusciare dalle dita. A volte
caramelle Hopjes al caffè che non finivano mai, a volte avanzi dei dolci del pranzo
sottratti a tavola. Mi circondavo di piattini, sacchettini, cartocci e iniziavo la vita
difficile, irta di pericoli dell'uomo solitario. Ero un peccatore, addirittura un
criminale, avevo di che rimettere. Avevo pure imparato a svaligiare il cassetto
centrale della credenza in sala da pranzo, dove mia madre conservava i dolci e le
torte: estraevo il cassetto superiore e con un coltello staccavo dei cerchi di pasta
dolce, calcolando l'operazione in modo tale che al primo colpo d'occhio non si
potesse notare l'assottigliamento. Poi raccoglievo le briciole e le mangiavo, e infine
leccavo accuratamente il i, coltello, arma del delitto, allo scopo di cancellare ogni
traccia. Spesso dentro di me la prudenza lottava con un'oscura passione per i canditi
che decoravano i dolciumi e più di una volta depredavo la superficie glassata,
spogliandola delle scorze d'arancia, dei frutti e dell'erba cannella che scricchiolavano
dolci sotto i denti, creando vuoti impossibili da nascondere. Poi attendevo le
conseguenze della mia sciagurata azione con una sensazione di ineluttabilità e di
stoica disperazione al tempo stesso.
Durante le mie sieste sul balcone avevo come vicini due oleandri in grandi
recipienti di legno, uno dai fiori bianchi, l'altro dai fiori rosa; convivevo con loro
secondo le leggi della neutralità e la loro presenza non mi faceva né caldo né freddo.
Anche dentro l'appartamento c'erano un po' di piante degenerate, lontane e stentate
parenti della flora del sud, qualche palma che, in uno stato di prolungata agonia color
ruggine, non riusciva a morire definitivamente, un filodendro dalle foglie metalliche e
un piccolo pino o forse un abete, non so, che ogni anno emetteva ciuffetti di giovani
aghi profumati color verde pallido.
Nella camera da letto due cose erano legate alle mie primissime fantasticherie: il
soffitto e una grande cassa di ferro. Vi dormivo quando ero ancora molto piccolo e
spesso osservavo il soffitto, dove gli stucchi di gesso imitavano le foglie di quercia,
con in mezzo delle ghiande nettamente in rilievo. Le mie visioni prima di
addormentarmi si aggiravano in qualche modo attorno a quelle ghiande che mi
davano molto da riflettere, anzi, per meglio dire, la loro contemplazione occupava
parecchio spazio della mia vita psichica. Desideravo strapparle via, ma non sul serio,
come se già allora avessi capito che l'intensità dei sogni è più importante dei risultati
ottenuti. Qualcosa di quella mistica infantile passò poi alle vere, comuni ghiande; per
anni togliere loro le cupolette continuò a sembrarmi un'azione speciale, che apriva la
strada a qualcosa di insolito, una sorta di importante trasformazione. Mi costa un
grande sforzo, forse inutile, rivelare quanto questo fosse importante per me.
Nella stanza da letto dove dormivo, sì, forse proprio in quella, erano morti i miei
nonni. E al nonno era appartenuta la cassa di ferro, un oggetto molto pesante, grande,
inservibile, una specie di forziere che risaliva ai tempi in cui non esistevano ancora
gli scassinatori professionisti, ma solo ladruncoli primitivi sotto ogni punto di vista,
che nella loro ingenuità si servivano, al massimo di un bastone o di una mazza. La
cassa di ferro era accanto a una porta sempre ermeticamente chiusa che divideva la
camera da letto dei miei genitori dalla sala d'aspetto dei pazienti. Aveva due ampie
maniglie e un coperchio piatto, scolpito con un motivo di foglie, al cui centro si
apriva uno sportellino quadrato. Lo sportellino, quando lo si spingeva di lato in un
certo modo, scattava, mostrando la serratura; l'astuzia di nasconderla, a considerarla
oggi, era ingenua in maniera commovente. Allora però la cassa nera mi sembrava
opera di chissà quali specialisti raffinati e già solo la chiave, grande come il mio
avambraccio, destava in me un'ammirazione straordinaria. Per poterla girare nella
serratura dovetti aspettare, con impazienza, di crescere molto, finché finalmente una
volta, afferrandola con due mani e con sforzi eccezionali, ci riuscii.
A dire il vero, sapevo che la cassa non conteneva tesori veri e propri. C'erano sul
fondo dei vecchi giornali ingialliti, delle carte e una scatola di legno piena di
bellissime banconote da mille marchi che risalivano ai tempi della grande inflazione.
Provavo addirittura a giocare con quelle banconote e anche con quelle da cento rubli,
che erano ancora più belle, d'un azzurro vivace, mentre i marchi, con la loro tonalità
brunastra, ricordavano un po' certe tappezzerie. A questo denaro era capitata qualche
storia incomprensibile che improvvisamente lo aveva privato della sua onnipotenza.
Se almeno non me l'avessero voluto dare, forse avrei creduto che gli fosse rimasta
una potenza residua, e solo momentaneamente assopita, garantita dalle cifre, dai
timbri, dalle filigrane, dai ritratti di uomini incoronati e barbuti nell'ovale. Ma potevo
farne ciò che volevo e quindi destava solamente quel disprezzo che si prova di fronte
a uno splendore che, come verità ultima, abbia dimostrato il suo vuoto. Su quelle
banconote non potevo dunque contare, solo su ciò che poteva accadere all'interno
della cassa nera quando stava chiusa a lungo, ed effettivamente era sempre chiusa,
con il mio tacito consenso, che naturalmente nessuno domandava. Sì, là dentro al
buio poteva pur succedere qualcosa. Per questo, aprirla era un atto di notevole
gravità. Anche in senso letterale. Il coperchio era enormemente pesante, con tre
lunghi chiavistelli sui lati. Bisognava sollevarlo e sostenerlo con una serie di supporti
speciali, altrimenti, cadendo, avesse potuto tagliarmi la testa, come mi assicuravano e
io ci credevo volentieri. Da una cassa come quella c'era da aspettarselo. Non era per
nulla simpatica né piacevole e nemmeno bella. Piuttosto cupa e brutta; tuttavia, per
molto tempo, feci affidamento sulla sua potenza interiore. Sul fondo aveva file di fori
ingegnosamente praticati per poterla avvitare ermeticamente al pavimento; un'ottima
idea. Ma le viti, ormai superflue, non c'erano più. Dopo qualche tempo, nascosta da
una vecchia coperta, era stata definitivamente inclusa nel numero dei mobili inutili,
degradata, non contava più. Solo occasionalmente ne mostravo la chiave a qualche
mio coetaneo: avrebbe potuto essere la chiave della città. Finché anche quella non si
perse chissà dove.
La stanza accanto alla camera da letto, lo studio di mio padre, ospitava la sua
grande libreria a vetri, chiusa, grandi poltrone di pelle e un tavolino rotondo, dalle