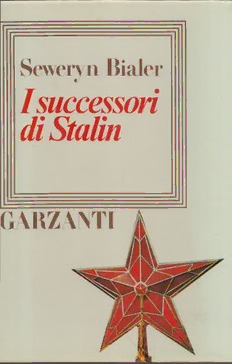Table Of ContentSeweryn Bialer
Isuccessori
di Stalin
GARZANTI
Dalla morte di Breznev (1982), in rapida
sequenza, si sono succeduti ben tre segretari
generali del PCUS, Jurij V. Andropov (no
vembre 1982 - febbraio 1984), Kostantin U.
Cernenko (febbraio 1984 - marzo 1985), fi
no alla nomina di Michail S. Gorbacev
(marzo 1985), che è anche il primo espo
nente della generazione post-staliniana a
raggiungere la più alta carica dell’Unione
Sovietica.
Comincia, in tal modo, a trovare concreta
rispondenza l’idea centrale del libro di Se-
weryn Bialer, secondo cui il «dominio della
generazione formatasi sotto Stalin sta vol
gendo al termine, ed il trapasso darà luogo
per la prima volta da decenni a reali impulsi
e a vere e proprie pressioni in direzione di
un cambiamento».
A sostegno della propria ipotesi di partenza,
Bialer ripercorre le tappe travagliate del
cammino percorso dalla società sovietica da
Stalin ad oggi, illustrandone puntualmente
caratteri e motivazioni, dalle linee di politi
ca economica a quelle di politica estera. Il
quadro che emerge è quello di una società
che, soprattutto a partire dal periodo
brezneviano, ha conseguito una sostanziale
stabilità politica, in larga misura a prezzo
dell’instabilità economica, e che quindi man
tiene un largo margine di provvisorietà, la
sciando ampi spazi alle decisioni dei suoi
massimi dirigenti. In tal senso Bialer forni
sce gli elementi fondamentali per un’infor
mazione corretta sugli aspetti e sui proble
mi della società sovietica attuale, rinviando
la risposta alla possibile svolta legata alla nuo
va generazione di dirigenti.
Seweryn Bialer è nato a Berlino nel 1927.
Ha compiuto gli studi universitari in Polo
nia divenendo membro dell’Accademia po
lacca delle Scienze. Nel 1956 è emigrato ne
gli Stati Uniti, dove ha svolto attività di ri
cerca presso la Columbia University su temi
relativi alla storia sovietica e specificata-
mente sulla questione della formazione dei
gruppi dirigenti e del processo decisionale
in Unione Sovietica. Attualmente è Profes
sor of Politicai Science presso la Columbia
University, Direttore del Research Institute
of International Change e membro del Co
mitato Esecutivo del Columbia’s Russian
Institute.
È autore di numerose pubblicazioni, fra cui
I generali di Stalin (1972); Radicalism in the
Contemporary Age (1977, 3 voli.) e The Do
mestic Context of Soviet Foreign Policy (1980),
di cui è stato coautore e curatore. Sue ricer
che sono state inoltre pubblicate in molte
riviste e volumi collettivi.
Negli ultimi anni Bialer ha rafforzato l’im
pegno pubblico e politico sempre su temi
relativi alla politica sovietica, con l’organiz
zazione di numerosi convegni fra istituti
americani ed europei, viaggi in Unione So
vietica e Qna, preparazione di materiali e
documentazioni per il Congresso degli Stati
Uniti e interventi su riviste e giornali ame
ricani quali «Foreign Affairs», «New York
Times», «Newsweek» e «Problems of Com
munism».
Per il centenario della rivoluzione russa
1917-2017
SEWERYN BIALER
I successori
di Stalin
GARZANTI
Prima edizione: novembre 1985
Traduzione dall’inglese di
Sergio Minucci
Titolo originale dell’opera:
«Stalin’s successors»
© Cambridge University Press, 1980
© Garzanti Editore s.p.a., 1985
Printed in Italy
I SUCCESSORI DI STALIN
Nota introduttiva
«Un mutamento nel sistema stalinista, e una tenace resistenza al muta
mento sono stati gli aspetti centrali della vita politica sovietica dalla morte
di Stalin in poi (...) Gli studiosi occidentali del mondo sovietico hanno per
cepito con lentezza questo conflitto dalle radici profonde. Abituata a vedere
solo una tradizione politica e quindi solo continuità nella storia sovietica, e
ad immaginare l’Unione Sovietica come un congelato sistema “totalitario”,
la maggior parte degli studiosi ha cominciato a pensare seriamente al muta
mento ed alle grandi controversie che esso ha provocato solo alla metà degli
anni Sessanta».1 In questi termini Stephen Cohen, biografo di Bucharin, ha
delineato i tratti essenziali della storiografia sull’Unione Sovietica, la «svol
ta» intervenuta — posso aggiungere — con le opere di Alexander Erlich e
Moshe Lewin, ed in tal modo egli ha anche indicato il quadro tematico og
getto dell’indagine storica attuale.2 Non vi è dubbio, infatti, che da sempre
la storia dell’Unione Sovietica è stata intrisa del giudizio politico espresso
sulla rivoluzione d’Ottobre, sulla società che ne è risultata, sullo stalinismo,
e, in generale, sull’ideologia che ufficialmente la distingue. Il concetto di
«totalitarismo» ha accompagnato gran parte delle ricostruzioni storiche delle
sue tappe, da Lenin a Stalin ed ai suoi successori, e quello di «continuità sto
rica» ne ha rappresentato la chiave interpretativa di fondo: «La formula di
governo del totalitarismo sovietico si basa su un equilibrio mobile di fasi al
terne di repressione e di distensione, ma il suo profilo essenziale rimane im
mutato. Il regime totalitario non perde le sue caratteristiche di stato di poli
zia; esso muore quando il potere viene strappato dalle sue mani»? Eppure, al
di là della messa in discussione dei concetti chiave della storiografia preva
lente sull’Unione Sovietica già accennati, essa si è certamente fermata alle
soglie delle necessarie conferme e precisazioni che quei termini implicavano.
Affermare, ad esempio, la sostanziale continuità di azione politica tra Lenin
e Stalin, significa sì opporsi alla corrente interpretazione esistente in Unione
Sovietica che la nega, ed indicare — al contrario — la «dipendenza» di en
7
trambi dalle condizioni storiche in cui avvenne la rivoluzione, ma implica
anche, inevitabilmente, far discendere l’azione del secondo da quella del pri
mo, renderli insomma anelli di un’unica inscindibile catena, che ha avuto
inizio nel 1917.
E ciò, inoltre, significa perdere di vista il singolare intreccio che è andato
a costituire la società sovietica, e al quale ciascuno dei due dirigenti ha con
tribuito specificamente. Diventano, in tal modo, meno rituali le parole con
cui Carr, nel 1955, concluse una polemica con Seton-Watson: «... il tentativo
di stabilire un parallelo fra l’attuale regime della Russia sovietica e un altro
qualsiasi ordinamento istituzionale o sociale del passato — sia esso l’autocra
zia zarista oppure la borghesia vittoriana serve solo a confonderci le idee. Si
tratta di un fenomeno nuovo nella storia, con meriti e difetti nuovi; farem
mo quindi meglio a cercare di valutarlo per quello che è.»4 Ed infatti, le rico
struzioni storiche dell’Unione Sovietica prevalenti nel secondo dopoguerra,
sono state caratterizzate da un approccio ideologico che unificava tendenzial
mente l’analisi storica con il giudizio politico, finendo per rendere «seconda
ria» la prima e «precario» per ciò stesso il secondo, al di là persino dei meriti
«pionieristici» acquisiti. A tali ricerche succedettero studi specifici, di tipo
quantitativo, che affrontarono aspetti e momenti particolari della storia so
vietica in gran parte trascurati precedentemente, senza la pretesa di vedere in
essi la conferma di ipotesi globali, ma certamente senza perdere di vista il le
game tra politica e ideologia che contraddistingue da sempre le vicende di
quel paese. La ricerca, tuttavia, di una chiave di lettura unitaria, o comunque
decisiva, rimase al fondo dell’approccio di entrambe le linee storiografiche
accennate, presente soprattutto nell’ambito anglosassone, condizionandone
spesso i risultati. Un’analisi storica di tipo «comparativo», che risulta in so
stanza la via più «facile» per una valutazione della storia sovietica, e, dall’al
tro versante, un approccio settoriale che periodizzi artificialmente l’insieme
degli avvenimenti o ne frammenti gli episodi, rappresentano le due secche in
cui spesso si è arenata la ricerca sulla storia sovietica. Si tratta, forse, a questo
punto, di far propria un’indicazione di uno studioso sovietico, che così si
espresse a tal proposito: «Al centro dell’analisi si deve porre non soltanto
l’arretratezza, ma la sua inconsueta unione con l’accelerazione; non soltanto
l’acutizzarsi dei conflitti sociali, ma un nuovo tipo di connessione nell’inter
cambiabilità di quei conflitti (...) Occorre guardare al conflitto più vitale, os
sia le forme e i mezzi più diversi dell’integrazione nella modernità».’ Defini
re, insomma, i caratteri specifici con cui l’Unione Sovietica ha vissuto il suo
processo di «modernizzazione» a partire dalla rivoluzione d’Ottobre, signifi
ca forse riuscire a delineare più precisamente i tratti della sua società civile
attuale, i problemi che la travagliano e che più compiutamente esprimono le
sue prospettive. Rimane, certamente, tuttora problematica la definizione
8