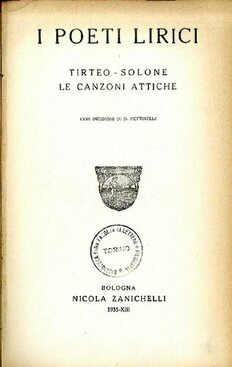Table Of ContentI POETI LIRICI
TIRTEO - SOLONE
LE CANZONI ATTICHE
CON INCISIONI 01 D. PETTINELLI
BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
1935-XUJ
L'EDITORE ADEMPIUTI I DOVERI
ESERCITERÀ J DIRITTI SANCITl DALLE LEGGI
Copyright 7935 by Casa Ed. N. Zanichelli
47ù
Officina Grafica A. Cacciari - Boloiroa, I, 1935-XIII
TIRTEO
•
I Lirici, IV • I
I
I
I
La leggenda di Tirteo è fra le piu note e popolari. Tren
tanove anni dopo la distruzione d' !tome, nell'anno 646 a. C.,
i Messèni, guidati da Aristòmene, si ribellarono agli Spar
tani, e li vinsero presso Dera. Aristòmene, rifiutato il titolo
di re, fu nominato duce con pieni poteri; e con ogni sorta
d'audacie continuò ad interrorire gli Spartani. I quali con
sultarono l'oracolo; e Apollo rispose che chiamassero come
consigliere un cittadino ateniese.
Gli Ateniesi, fra la repugnanza a facilitare ai loro ri
vali il possesso del Peloponneso, e il timore di disubbidire
ali' oracolo, scelsero la persona che meno semhrava adatta ad
assolvere il difficile c6mpito: Tirteo, maestro di scuola, zop
po e reputato demente.
Ma Tirteo con le sue elegie e coi suoi anapesti incorò
gli Spartani in guisa !,!le, che, abbandonata ogni idea di de
sistere, ripresero con nuovo ardore la guerra; e, dopo che
gli Arcadi ebbero abbandonati i Messèni, riuscirono a su
perare i nemici, e costringerli sul monte Ira. Dove questi,
del resto, resistettero ancora altri undici anni.
In questo periodo, sorti dissensi fra gli stessi Lacedèmoni,
Tirteo li compose con una poesia - o serie di poesie - det
ta· Eunomia : la saggia costituzione.
6 I LIRICI GRECI
Cosi Pausania {IV, 115 sg.); e molti scrittori greci e ro
mani narrano, su per giu, gli stessi fatti. I quali non of
frono veruna inverisimiglianza, verun elemento di sospetto,
anzi si accordano perfettamente con quanto si sapeva dell' an
tica costituzione e delle antiche vicende di Sparta. Ma dice
bene Cavallotti : « La critica non rispetta un bel niente. Anzi
basta che una stor·iella sia resa veneranda dai secoli e dalla
polvere, per eh' ella le manchi subito di venerazione».(')
Dice bene in genere, e benissimo rùguardo alla ipercritica
cosi detta scientifica, che ,imperversava mentre egli scriveva,
una cinquantina d'anni fa. E che di fronte a tutta la tradi
zione assumeva lo spirito d'un giudice scorbutico uso a non
tratt,ire che mariòli, e che, senza neanche proporsi il famoso
cui prodest, coinvolgeva tutti gli autori antichi nella suspicione
di mala fede e di menzogna.
iE nulla e nessuno andò salvo da quella nordica barba
rica furia di demolizione. Anche le vicende narrate da Pau
sania e da tutti gli storici del!' antichità furono dichiarate
f,ilse e inventate, e chimerica la figura di Tirteo, e le poe
sie che vanno sotto il suo nome falsificazioni del secolo quinto
(Thiersch, Schwartz, e via dicendo).
La critica itali,ina, in generale, reagi a queste esagera
zioni. E valgano per tutte le giudiziose parole di Valerio
Milio, che, nel proemio ad una sua raccolta dei frammenti di
Tirteo, fece una diligente acuta disamina della questione (2).
cc Come pensare che Tirteo e i suoi canti siano una inven
zione del secolo quinto, quando ali' antichità e alla genuinità
d'essi crede Platone, che è appunto di quell'età-?>>.
Davvero non so che cosa possa obiet,tare una persona
ragionevole.
(1) Cant'i e /rammentì di Tirteo, in Opere, voi. III, pai.. 29.
(2) / /rammenti di Tirteo, Messina, Trimarchi, 1898.
TIRTEO 7
*
* *
Distrutta la figura del poeta, riuscivi! ne;gata la genuinità
delle sue poesie. Ma questa era impugnata anche da molti
che ammettevano l'esistenza del poeta.
E per varie ra,gioni.
-1) iLo stile. - È - dicevano - quello attico del
quinto secolo : non ha nulla d'arcaico né di personale. E
non offre tracce, che pure ci dovrebbero essere, di dialetto
dorico.
In verità, si risponde, non m(\ncano dorismi (p. es. l' o:ç
breve nell'accusativo plurale). E lo stile è, né piu né meno,
lo stile letterario, derivato da Omero, comune a tutta la
Grecia di quel periodo, e massime alle co)llposizioni ele
giache.
2) Le esortazioni hanno carattere vago e poco perso
nale.
Si entri\ un po' nella pericolosa sfera del s~gettivo. Ad
ogni modo, bene ossertò il Weil che le tre elegie p1u
lunghe furono citate da Licurgo e da Stobeo a fini etici e
parenètici, e scelte in conseguenza fra quelle che servivano a
simile scopo : tali, cioè, che facessero astrazione dai particolari
specifici, per assurgere ad un v(\lore generale ed universale.
3) Scarseggiano i riferimenti storici.
Non è giusto. Nei frammenti di Tirteo citati dagli sto
rici non mancano riferimenti a fatti precisi. Basterebbe il
.preciso particolare dei venti anni che durò la guerra condotta
da T eopompo. Altri, e piu import(\oti, ne esistono nei nuovi
frammenti (').
4) La presenza di accenni mitologici; che sembrava
sconveniente a quest'età, a questo tipo di poesia.
( 1) V cdi oltre, pag. 67 sg.
8 I URICI GRECI
Anche qui soccorrono i nuovi frammenti, dove si conten
gono anche piu caratteristici riferimenti mitologici. Ma la
dimostrazione di autenticità si raggiunge ,!nche senza tener
conto di queste nuove preziose testimonianze.
*
**
Alcuni cnttc1 poi riconoscono per igenuine le elegie nel
le quali si contengono precisi riferimenti a determinati fatti sto
rici, e spurie le altre: vale a dire le piu famose (6, 7, 8),
su le quali, pe) volgere di tanti secoli, si determinò la
figura etica ed a~tistioa di Tirteo. Cosi, ultimamente, lo
Schachermeyr (1). E sostanzialmente lo aveva preceduto il
2
Wilamowitz (), respingendo la famosa elegia : TE-&vb.µ.EvctL
yàp xctÀòv, x. 't. À., che egli attribuisce ali' oratore Licurgo, e
l'altra conservata da Stobeo : Ou't' àv µ.'l 'Y)a ct[µ:11'1, x. 't. À. -·
Onde poi traccia l'immagine della poesia di Tirteo sui tre
o quattro brevi frammenti citati dagli storici. Procedimento
critico che fa pensare alle volontarie mutilazioni di certi
fanatici :barbari. Senza contare che, come osserva bene lo
Jager {'), quelle citazioni di storici erano quasi sempre a ten
denza, e perciò fatl,aci.
Ora, questi critici, in apparenza piu moderati dei distrut
tori radicali, sono, in realtà, anche meno assennati. Perché
le loro argomentazioni presuppongono come ;pacifico postulato
che un 1poeta greco del secolo settimo avanti Cristo dovesse
pensare ad introdurre nelle sue poesie tali indici di genuinità
(') Rheinisches Museum, N. F. 1932, 129 sg.
(2) T exlgeschichle der gricchischen Liri~er, 97 sg.
(3) Jiiger, Tyrlaios iiber die wahre ixps,,j, in Sitzungsberichte der
Wisscnscha/len, 1932, pag. 5 dell'estratto. Qualche cosa di simile aveva
già osservato il Milio, op. cii., pag. I sg.