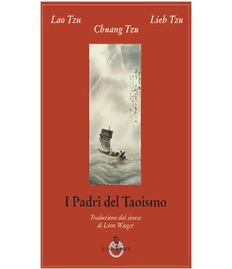Table Of Content1
Lao-tzu
Lieh-tzu
Chuang-tzu
I PADRI DEL TAOISMO
traduzione dal cinese di Leon Wieger
2
Titolo originale: Les Pères du Système Taoiste
Edizione tradotta e curata da Pietro Nutrizio
1994 Luni Editrice — Milano
5
Introduzione
Nella sua opera Il pensiero cinese, l'orientalista Marcel Granet, trattando del Tao
Te Ching dice a un certo punto: «Bisogna confessare che questo libro, tradotto e ritradotto
[nelle lingue europee], è propriamente intraducibile». Tale affermazione (che a giudicare
dalla poca intelligibilità di quasi tutte le traduzioni disponibili, è ugualmente applicabile
anche ai due libri di Lieh-tzu e di Chuang-tzu, del resto commentari del Tao Te Ching)
egli la fa poi seguire da questa spiegazione: «Le brevi sentenze che lo compongono erano
apparentemente destinate a servire come temi di meditazione. Sarebbe inutile cercare di
attribuire loro un senso unico o anche un senso in qualche modo definito». Questa espli-
cita dichiarazione di impotenza, che fa certamente onore all'onestà e alla sincerità dello
studioso francese, riassume bene il senso di disorientamento che gli specialisti in que-
stioni estremo-orientali provano di fronte ai tre capisaldi dell'intellettualità cinese.
Incomprensibile, dunque, il Tao Te Ching per degli Occidentali (perché questo vo-
gliono dire in fondo le brevi frasi che abbiamo citato)? Se questo fosse vero, ciò non fa-
rebbe in un certo senso che dar ragione a queste parole di René Guénon, autore di origine,
ma non di mentalità, europea, e, per quanto profondo conoscitore del pensiero orientale,
non certo un «orientalista»: «Tutti i tentativi che finora sono stati fatti per riavvicinare
l'Oriente e l'Occidente sono stati intrapresi a profitto della mentalità occidentale, e proprio
perciò sono falliti. Questo sia detto non soltanto per tutto quanto è propaganda aperta-
mente occidentale [...], ma anche per i tentativi che pretendono fondarsi sopra uno studio
dell'Oriente: si cerca molto meno di comprendere le dottrine orientali di quanto non si
tenti di ridurle alla misura delle concezioni occidentali; ciò che significa snaturarle com-
pletamente. Anche nei casi in cui non esiste l'intenzione cosciente e dichiarata di deprez-
zare l'Oriente, è nondimeno implicitamente sottinteso che tutto ciò che l'Oriente possiede
deve possederlo anche l'Occidente; ora, ciò è completamente falso, soprattutto per quanto
riguarda l'Occidente attuale. Così, grazie ad una incapacità di comprensione dovuta in
buona parte ai loro pregiudizi [...], gli Occidentali non riescono ad afferrare nulla dell'in-
tellettualità orientale, e anche quando immaginano di possederla e di tradurne l'espres-
sione, riescono soltanto a farne la caricatura, e nei testi e nei simboli che credono di spie-
gare non ritrovano se non quello che vi hanno messo essi stessi: delle idee, cioè, pura-
mente occidentali; il fatto è che la lettera di per se stessa non è nulla, e lo spirito gli
sfugge completamente».
E non è ciò che si ritrova, generalmente, nelle traduzioni dai testi antichi cinesi in
lingue occidentali, a partire dalla qualificazione di «filosofia» data al pensiero dei Taoisti,
fino a quel senso di frammentarietà e di incoerenza che non può che respingere il lettore,
anche il meglio intenzionato a cercare di capire qualcosa dell'Oriente? Ma perché questo
stato di cose?
Andando un po' più a fondo nell'esame del problema, in primo luogo perché «[...]
non basta conoscere grammaticalmente una lingua, né essere capaci di tradurre parola per
5
parola, anche correttamente, per penetrare lo spirito di una lingua e assimilare il pensiero
di coloro che la parlano e la scrivono. Si potrebbe anzi andare oltre, e dire che quanto più
una traduzione è scrupolosamente letterale, tanto più rischia di essere in realtà inesatta e
6
di deformare il pensiero, giacché non esiste, fra i termini di due lingue diverse, vera equi-
valenza, soprattutto se le due lingue sono molto lontane l'una dall'altra non soltanto filo-
logicamente, ma anche per la diversità delle concezioni dei popoli che se ne servono; ed è
proprio questo elemento che nessuna erudizione permetterà mai di penetrare. Occorre a
questo fine, ben altro che una vana "acritica testuale" che si dilunghi a perdita d'occhio su
questioni di dettaglio, o metodi da grammatici e "letterati", o quel sedicente "metodo sto-
rico" che viene applicato a tutto indistintamente».
In secondo luogo, perché l'abuso provocato più frequentemente proprio da questo
«metodo storico» a cui gli orientalisti sembrano attribuire le virtù più taumaturgiche «è
l'errore che consiste nello studiare le civiltà orientali come fossero civiltà scomparse da
molto tempo [...]. Si dimentica che le civiltà orientali, almeno quelle che ci interessano
attualmente [R. Guénon intende: quella indù, quella araba e, qui più rilevantemente,
quella cinese], si sono perpetuate fino a noi senza interruzione e hanno ancora dei rappre-
sentanti autorizzati, il cui parere vale, per comprenderle, ben più di tutta l'erudizione del
mondo; sennonché, perché si pensi di consultarli, non bisognerebbe partire dal singolare
principio che si sa meglio di loro qual è il vero senso delle loro proprie concezioni».
Tutto ciò, che di fatto è totalmente vero, non è però tutto, e si applica soltanto al
tipo di comprensione (o meglio, alla mancanza di comprensione) e ai metodi di indagine
degli orientalisti «ufficiali»; è evidente infatti che, proprio seguendo la logica stringente
di Guénon, non tutti gli Occidentali sarebbero condannati a non avere accesso alle forme
di pensiero, in questo caso, della Cina antica (e della Cina tout court, visto che la tradi-
zione cinese, anche quella profonda, «si è perpetuata fino a noi senza interruzione»).
Sfuggirebbero a questa interdizione quelli fra gli Occidentali che si fossero messi nelle
condizioni per la comprensione indicate più o meno direttamente da Guénon stesso nei
passi citati; ma, la domanda è: per quel che riguarda la Cina, se ne conoscono che si siano
messi in queste condizioni e, soprattutto, ce n'è qualcuno che abbia lasciato una traccia
reperibile in lavori accessibili al pubblico occidentale?
A quel che ci è dato di vedere, a parte il caso di R. Guénon stesso, ce ne sono stati
almeno due: Albert Pouyou, conte di Pouvourville, autore di due libri di ispirazione taoi-
sta di fondamentale importanza (La Voie métaphysique e La Voie rationnelle) e Léon
Wieger, autore della traduzione dei testi di Laotzu, Lieh-tzu e di Chuang-tzu che è qui
presentata per la prima volta in italiano. Del primo, la stessa storia esteriore testimonia
della prossimità ad ambienti taoisti, e del resto i suoi lavori furono pubblicati sotto il
nome cinese di Matgioi («Occhio del giorno»); del secondo si sa che era un missionario
gesuita, e che, giunto in Cina nel 1887 all'età di trentun anni, vi visse fino alla morte, che
avvenne nel 1933. Della sua comprensione delle dottrine profonde della razza cinese nes-
sun dato «storico» dà ragione, né ce n'è bisogno; l'unica prova che abbiamo di tale com-
p6 rensione, ma che è anche la più im portante, è costituita dai suoi lavori, di cui fa parte la
traduzione che il lettore troverà qui, e della quale lasciamo a lui giudicare.
Un omaggio, per quanto involontario, alla comprensione dei testi taoisti secondo il
loro spirito da parte del Wieger, proviene ancora da M. Granet, il quale, alla nota 10 del
cap. 3, libro IV dell'opera già citata, dice: «[...] Il Padre Wieger ha pubblicato una specie
di parafrasi del Lao-tzu, del Lieh-tzu e del Chuang-tzu; poco fedele nei particolari, essa
dà di queste opere un'idea piuttosto viva [...]». Ora, si confronti questo complimento a
denti stretti con quanto afferma R. Guénon nel cap. «Difficoltà linguistiche» della sua
Introduzione generale allo studio delle dottrine indù (pag. 48 dell'ed. citata), e si vedrà
quel che vogliamo intendere: «Per considerare sotto un altro angolo visuale, e quasi nel
7
loro stesso principio, le difficoltà che volevamo segnalare particolarmente in questo ca-
pitolo, possiamo dire che ogni espressione di un qualsiasi pensiero è di per sé necessaria-
mente imperfetta, dal momento che circoscrive e restringe i concetti per chiuderli in una
forma definita che non può mai essere del tutto adeguata, il concetto contenendo sempre
qualcosa di più della sua espressione, e addirittura immensamente di più quando si tratti
di concezioni metafisiche, che devono sempre tener conto dell'inesprimibile, in quanto fa
parte della loro stessa essenza aprirsi su possibilità illimitate. Il passaggio da una lingua a
un'altra, per forza di cose meno adatta della prima, non può insomma che aggravare que-
sta imperfezione originaria e inevitabile; ma quando si è giunti a cogliere in qualche
modo il concetto stesso attraverso la sua espressione primitiva, identificandosi per quanto
possibile alla mentalità di colui o coloro che lo hanno pensato, è chiaro che si può sempre
rimediare in larga misura a questo inconveniente, fornendo una interpretazione che, per
risultare intelligibile, dovrà essere un commento assai più che una pura e semplice tradu-
zione letterale. Tutta la difficoltà reale quindi risiede, in fondo, nell'identificazione men-
tale necessaria per giungere a questo risultato; è certo che al riguardo esistono persone del
tutto inadatte, ed è facile capire quanto ciò trascenda i limiti dei lavori di semplice erudi-
zione. È questa l'unica maniera davvero proficua di studiare le dottrine; per capirle biso-
gna, per così dire, studiarle "dal di dentro", mentre gli orientalisti si sono sempre limitati
a considerarle "dal di fuori"».
Il giudizio pur favorevole di Granet sulla traduzione del Wieger termina però con
le parole (da noi sostituite provvisoriamente da puntini di sospensione) «ma tendenziosa».
Questo sta a significare che al padre Wieger viene attribuita a debito la sua qualità di ge-
suita, che avrebbe pesato, secondo molti orientalisti (in testa a tutti quello di cui diremo
subito dopo, che esprime per lui un vero e proprio odio viscerale), sulle sue traduzioni.
Ora, noi non rileviamo nella traduzione del Wieger nulla di simile. Se alcune volte (ma
sono veramente pochissime, e noi le abbiamo sottolineate tutte nella nostra versione ita-
liana) egli fa in nota qualche osservazione che può corroborare la fondatezza di questa
accusa, non sarà forse perché un libro come il suo, ed al suo tempo, non avrebbe potuto
vedere la luce se egli non avesse detto almeno qualcosa che mettesse in evidenza la sua
appartenenza alla «Compagnia di Gesù»? La realtà secondo noi è ben altra: il bigottismo
che gli orientalisti gli attribuiscono non esiste che nelle loro menti, e il fatto che essi lo
accusino di una simile distorsione traduce soltanto in parole la repulsione che la loro
mentalità, eminentemente antitradizionale, non può non fargli provare di fronte all'ade-
renza del Wieger allo spirito della tradizione taoista.
Del resto, il pensiero del Wieger in proposito è ben espresso dalle parole con cui si
chiudeva la sua presentazione del libro, da noi non tradotta in questa sede: «Je me suis
efforcé de rendre ma traduction d'aussi facile lecture qu'il m'a été possible, sans nuire à la
fidélité de l'interprétation. Car mon but est de mettre à la porté de tou7 s les penseurs, ces
vieilles pensées, qui ont été depuis tant de fois repensées par d'autres, et prises par eux
pour nouvelles». [«Mi sono sforzato di rendere il più facile possibile la lettura della mia
traduzione, senza con ciò nuocere alla fedeltà dell'interpretazione. Giacché il mio scopo è
quello di mettere alla portata di tutti i pensatori questi vecchi pensieri, che sono stati da
allora tante volte ripensati da altri e da loro presi per nuovi»]. Che è, a ben considerare,
assai sottile, e ben degno del nobile umorismo che pervade questi testi, pur nella loro
quasi insondabile profondità.
Per concludere questo breve studio introduttivo, e benché questa sede si presti male
a trattare dei casi di singole persone non ci pare del tutto inopportuno dare almeno un
8
esempio specifico delle distorsioni che la mentalità occidentale può far subire alle idee
contenute nei testi che si leggeranno in questi antichi libri; e anche se le cose che si do-
vrebbero dire per rettificarle convenientemente, secondo i criteri dell'intellettualità tradi-
zionale, sarebbero troppe per affrontarle tutte qui, non possiamo esimerci dall'accennare
brevemente ad alcune di esse, che Ci sembrano le più importanti.
Uno «specialista» occidentale di questioni estremo-orientali, introducendo nel 1967
una traduzione del Tao Te Ching, concludeva il suo commento con queste considerazioni:
«[...] in fatto di politica interna, Lao-tzu non è maggiormente diretto. Proprio perché desi-
dera porsi "al di sopra del popolo", il suo Principe deve «abbassarsi a parole»; allora il
popolo non si accorgerà che è menato, e menato di brutto, che lo trattano come un "cane
di paglia». Contrariamente a quel che ripetono su Lao-tzu coloro che lo conoscono male,
la sua teoria del potere non è estranea a quella che elaborarono i rappresentati del fachià,
quei legisti, legalisti, o realisti che, portando alle loro estreme conseguenze i principi del
Tao Te Ching, tratteranno in effetti il popolo come "cani di paglia", e prepareranno il po-
tere assoluto di Z'in scie-huang-ti; ma se l'alternanza dei contrari governa il cosmo e le
società degli umani, se guerra e pace sono l'una nei confronti dell'altra come lo yang nei
confronti dello yin, come potrebbe lo stato di pace, tempo di riposo tra due massacri co-
smici, prevalere un giorno sull'alternanza irreprimibile del tao? Qualunque filosofia natu-
ralistica giustifica lo stato di guerra, che è quello della natura, vegetale e animale. Se mai
la pace avrà la meglio sulla guerra, non sarà certamente per merito degli aforismi di que-
sto Tao Te Ching, ma perché degli uomini ragionevoli, che non si mettono cioè l'intelli-
genza sotto i piedi, avranno sostituito all'ordine dello spreco — quello della natura —,
all'ordine degli ossari — quello di Dio —, un ordine contro natura, giuridico e morale; un
ordine intelligente; quello, precisamente, che ripudia Lao-tzu».
Difficilmente si potrebbero trovare da qualche altra parte, espresse in modo così
definito e tutte insieme, manifestazioni tanto chiare dell'incomprensione occidentale per
la dottrina tradizionale nella sua forma estremo-orientale; tanto più che il brano in que-
stione termina con questa frase finale: «E ora leggete il Tao Te Ching. Ma non dimenti-
cate che per gustarne le bellezze folgoranti, quelle della scrittura (lingua, rime, paralleli-
smi), bisogna assolutamente che impariate un po' di cinese. Capirete allora che queste
bellezze (in quanto tecniche, supremamente intelligenti) cancellano e negano i valori so-
stenuti dallo scrittore, chiunque egli sia, a cui dobbiamo questa aspra antologia».
Come se l'intelligenza che i Taoisti «si mettono sotto i piedi» fosse qualcosa di di-
verso dalle limitazioni dell'intendimento umano individuale abbandonato a se stesso, dal
quale possono nascere soltanto mostri (come dimostra disgraziatamente lo stato attuale
del nostro mondo), limitazioni dalle quali Lao-tzu invita l'«uomo dotato» a liberarsi per-
ché possa effettuarsi per lui l'unione con l'intelligenza vera, quella cosmica, sovraindivi-
8d uale e disinteressata, che fa tutt'un o con la sua «natura» originaria; ciò che unicamente
gli può permettere di «aiutare il Cielo e la Terra nel mantenimento e nella trasformazione
degli esseri» costituendo per ciò stesso «un terzo potere con il Cielo e la Terra».
Anche se è vero che l'esempio da noi portato è in qualche modo estremo, è altret-
tanto vero però che, per una triste ironia, esso è costituito da uno scritto che si inserisce in
una collana il cui titolo generale è «Connaissance de l'Orient», e che il suo autore (molto
fiero, a quel che sembra, delle conclusioni a cui l'hanno condotto i suoi lunghi studi in
questo campo) è un «professore alla Sorbona»: tutte queste circostanze, insieme al tono
stesso e agli assunti dello scritto, non forniscono forse una prova quanto mai evidente
della fondatezza delle osservazioni di René Guénon sugli orientalisti «ufficiali» da noi
9
riportate all'inizio?
Più tardi (1980), questo sinologo che rifiuta di riconoscersi tale, ma si compiace in
un ruolo di «capo-scuola» che si è attribuito da solo, curando una raccolta degli stessi te-
sti estremo-orientali che si troveranno qui, ha voluto mettere in evidenza che escludeva da
essa le opere di quei Taoisti posteriori che, ricercando le «droghe d'immortalità», «al pen-
siero sostituiscono l'alchimia» (forse perché ha trovato più arduo dare un senso per lui
accettabile agli elementi di una «scienza tradizionale», del resto difficilmente penetrabile,
che non a un pensiero che scambia a torto per una «filosofia» al modo occidentale). Ma
c'è da chiedersi, conduce veramente così lontano, nella ricerca del vero significato dei
testi tradizionali estremo-orientali, sostituire al pericolo di un pregiudizio «materialistico»
(pregiudizio dal quale l'orientalista di cui parliamo è del resto lontano dall'essersi egli
stesso liberato), il pregiudizio, forse più alla moda, della «socialità» e della morale?
È nostro parere, come lo era degli antichi Taoisti, a giudicare dai testi che si legge-
ranno, che sia l'uno sia l'altro (così come qualsiasi pregiudizio) siano totalmente impotenti
ad aiutare l'uomo a penetrare nel dominio dell'intellettualità pura, che è il campo in cui
tali testi si situano.
P. N.
9
10
Avvertimenti di lettura
Il lettore troverà in questi testi alcune forme grafiche di cui è opportuno chiarire
cosa rappresentino. Il traduttore dal cinese ha adottato, per l'edizione iniziale della sua
opera (1913), due soluzioni per attirare l'attenzione sui passi dove il suo intervento si pre-
senta più evidentemente con le caratteristiche del commento o della parafrasi; esse sono
le parentesi tonde e il corsivo.
Quale differenza di valore intendesse attribuire a questi due tipi di artificio grafico,
nella sua premessa al libro egli non lo dice, ed è problematico in queste condizioni avan-
zare ipotesi. Nel 1991 l'Editore Jean-Paul Bertrand di Monaco ha pubblicato una riedi-
zione del solo Tao Te Ching nella traduzione del Wieger, e nella sua Prefazione, Jean
Varenne, direttore della collana in cui il libro compare, fa questa affermazione: «Nella
nostra edizione [che è identica a quella iniziale], le parole in corsivo sono quelle che il
traduttore ha aggiunto al testo cinese per completare le frasi francesi. E le varianti da lui
inserite nella sua propria versione sono messe tra parentesi». Non è detto da dove sia stata
dedotta questa indicazione. Per parte nostra deduciamo che talvolta le parole tra parentesi
rappresentano semplici chiarimenti utili per una miglior comprensione dei brani, mentre
abbiamo avuto spesso l'impressione che le frasi in corsivo riflettano sviluppi, anch'essi
chiarificatori, tratti da commentari.
Le parole e le espressioni tra parentesi quadre sono le nostre; hanno lo scopo di
quelle del P. Wieger tra parentesi tonda, e il lettore potrà tenerne conto o no, a suo piaci-
mento.
Per quel che riguarda la trascrizione dei suoni cinesi, impossibile se non in modo
molto lontanamente indicativo (e in fondo assolutamente ininfluente ai fini che si propone
questa traduzione), abbiamo seguito l'esempio di Mario Novaro, che nel suo Acque d'au-
tunno, del 1949 (Laterza ed., Bari), diceva, sensatamente: «Io giudico il meglio sia tra-
scrivere i nomi propri o geografici cinesi con consonanti e vocali soltanto italiane (anche
se qualche volta possono parere insufficienti; ma lo spirito della lingua nostra non ha di
questi scrupoli) dal momento che in cinese non esiste alfabeto e noi dobbiamo rendere
suoni e non lettere; poiché anche l'italiano (come fecero il portoghese, il francese e l'in-
glese, sebbene gli inglesi usino, allo scopo, anche vocali da pronunziare all'italiana), l'ita-
liano, diciamo, ha da seguire in ciò la propria fonetica e scrittura, e non quelle d'altro po-
polo, e tanto meno quelle di accordi internazionali di ordine postale ed economico. Perché
per dire Ciuàng un Italiano ha da scrivere Chuang? Mentre il lettore è poi lasciato senza
spiegazione del come va pronunziat o?» 11
Noi abbiamo quindi semplicemente trascritto all'italiana i suoni della trascrizione
francese del Wieger, per cui il lettore non avrà che da pronunciare i suoni tali e quali li
troverà scritti; per i suoni francesi che in italiano non ci sono, siamo ricorsi ad artifici
come la dieresi posta sulle lettere e (e) e u (u) (suono francese).
Per i nomi degli autori delle tre opere tradotte, Lao-tzu, Lieh-tzu e Chuang-tzu, si è
invece mantenuta nel corso della traduzione italiana la trascrizione abituale, per facilitare
la lettura di chi sia ormai assuefatto a questa loro grafia: Lao-tzu, Lieh-tzu, Chuang-tzu.