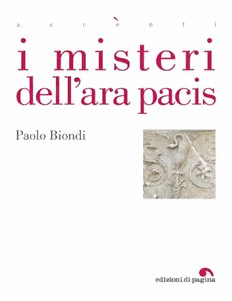Table Of ContentIndice
Copertina
Il libro • L’autore
Colophon
Frontespizio
«Prologo». Galleria di personaggi e di fantasmi
1. Il 13, anno fatale. Balbo lo spagnolo
2. L’obelisco e le ombre di Facondo Novio, il matematico
3. Lucina, prima e dopo l’Ara Pacis
4. Il giardino dell’Ara. La bottega di Saura e Batraco
5. Da Enea a Livia, da Romolo a Roma. Il luogo dei poeti
6. La foto di famiglia. I disegni di Antero
7. Dedicata a Livia dopo l’addio di Ottavia, la sorella
8. L’Ara e il suo doppio. La vigna di Lullo Antigono
9. I festoni di Villa Medici e il cardinale Ricci
10. L’oblio di due imperatori. Poi gli scavi dell’ingegnere
«Conclusione». Per custode un pittore
Immagini
Il libro
Ha più di duemila anni, una storia lunga, ma avvolta in gran parte nel mistero
di tanti segreti. Molti di essi ancora non sono stati indagati. L’Ara Pacis è il
monumento dell’apoteosi di Augusto. Ideata nel 13 e inaugurata il 30 gennaio
del 9 a.C., dedicata alla moglie Livia nel giorno del suo cinquantesimo
compleanno, è la sintesi religiosa, etica e politica del principato di Augusto.
Eppure la vita di questo monumento fu brevissima e già nel II secolo d.C. se
ne perdono le tracce, tanto che non compare in molte delle cronache di quegli
anni. Perché una vita così breve? Perché si dovette aspettare fino alla fine del
XIX secolo per ritrovarla e riscoprirla? La sua vicenda è una appassionante
avventura, con tanti aspetti sconosciuti che queste pagine cercano di indagare
e svelare.
Ecco il racconto dell’Ara, dalla sua nascita alla sua scomparsa fino al suo
ritrovamento. Siamo accompagnati in questo viaggio nei secoli e nei millenni
da personaggi, alcuni noti altri meno ma tutti realmente vissuti, che
cercheranno di svelare i tanti misteri legati al monumento simbolo di Augusto
e del suo principato.
L’autore
Paolo Biondi (1955) è nato a Rimini, sposato, un figlio. Giornalista, vive e
lavora a Roma. È stato capo della redazione romana dell'agenzia Reuters e
analista di politica italiana. Ha scritto per lo stesso editore il romanzo Livia.
Una biografia ritrovata (2015) sulla moglie di Ottaviano Augusto.
Accenti nr. 26
© 2017, Pagina soc. coop., Bari
È vietata la riproduzione.
ISBN 978-88-7470-583-2
Per informazioni sulle opere pubblicate
e in programma rivolgersi a:
Pagina soc. coop.
via dei Mille 205 - 70126 Bari
tel. e fax: 080 5586585
cell.: 320 6590859
http://www.paginasc.it
e-mail:[email protected]
Seguici su Facebook e Twitter
Paolo Biondi
I misteri dell’Ara Pacis
Prologo
Galleria di personaggi e di fantasmi
C’era un generale spagnolo presuntuoso. Voleva distogliere Augusto dal suo
destino. E il destino aveva assegnato un compito al principe di ritorno da
Gallia e Spagna: far costruire un altare e dedicarlo alla dea Pace, dando così il
via a una serie incredibilmente lunga di fatti e di vicende, di curiosità e di
misteri legati a quell’Ara. Malgrado la sua ostinazione e il potere dei suoi
soldi quel generale non riuscì a fermare la storia. Lui non sapeva che una dea,
una dea potente, aspettava che qualcuno rendesse luogo sacro più di ogni
altro la terra dove lei aveva fatto zampillare una fonte, fonte di acqua che
sgorga per proteggere e custodire la vita di ogni partoriente, nella parte
settentrionale del campo Marzio. E non poteva sapere che un matematico
egiziano aveva già calcolato, con scientifica certezza, ogni minima variazione
dell’ombra del sole per costruire un nuovo orologio. E che l’ombra di un
obelisco egizio dedicato al dio Sole, meridiana di quell’orologio, sarebbe
caduta a fecondare la terra alle porte di quell’Ara ogni anno al tramonto del
23 settembre, giorno di nascita del principe Augusto, portatore di prosperità e
di pace nel mondo. Non sapeva nemmeno, quel generale spagnolo, che una
lucertola e una ranocchia avevano già battezzato un campo, alla periferia nord
di Roma, eleggendolo a giardino dei giardini. E che uno stuolo di poeti aveva
già cantato il destino di quelle zolle di terra dedicandole alla dea Pace.
Una miriade di vicende già si intrecciavano e rincorrevano, col destino
comune di costruire un’unica storia. Mentre un pittore stava già preparando i
disegni da fissare sul marmo, quasi fossero l’immagine cristallizzata nel
tempo e consegnata all’eternità della famiglia predestinata più di tutte le altre
famiglie a governare e a fare grande Roma, la famiglia di Augusto. Non
poteva sapere, lo spagnolo, che un sacerdote era stato incaricato dagli dèi di
essere pronto a raccogliere i frammenti di quella immagine per trasmetterla a
ogni generazione e farla conoscere a tutti gli uomini nei secoli dei secoli. La
sorella di Augusto aveva poi già recitato una parte del suo ruolo in quella
sacra vicenda: aveva pianto la morte di quella stirpe divina, nella morte del
figlio. Pezzi di quella famiglia predestinata se ne andavano prima del tempo e
già scrivevano i loro nomi sul libro dei potenti ascesi al cielo. Ma sulla terra
hanno lasciato un segno, monumento indelebile di pace e prosperità.
Tante storie già si affastellavano ed erano raccontate nel libro del tempo
attorno a quell’altare, dedicato alla dea Pace. Storie disseminate in un
percorso lungo oltre venti secoli che un ingegnere avrebbe cercato di
recuperare e di rimettere insieme, scavando nelle viscere della terra. In quelle
stesse viscere nelle quali un contadino, fra i mille indizi seminati per non
farci perdere il filo della vicenda, stava più di 2.000 anni fa già coltivando
una vigna per ricordarci che mille tralci possono donare grappoli succosi se si
mantengono uniti al tronco, unico garante di linfa vitale per tutta la vite. Tanti
personaggi di una storia già scritta sul libro del destino di ciascuno e di tutti.
Una storia fatta di mille storie e di mille misteri. No, non poteva quel
generale fermare il destino di tanti che già si erano messi al posto che era
stato loro assegnato sul palcoscenico della vita. Il destino di tutti coloro che
aspettavano pazienti dietro le quinte il momento opportuno per entrare in
scena e recitare la loro parte in questo nostro racconto. Una lunga serie di
personaggi che non abbiamo faticato a cercare, ma che ci sono venuti
incontro per permetterci di riannodare alcuni fili di questa nostra piccola,
grande storia, una storia che possiamo oggi raccontare incollando mille
frammenti, ridisegnare per lunghi tratti, compresi tanti suoi misteri irrisolti e
intriganti.
È impossibile incollarli tutti i pezzi della storia come fossero, nel loro
insieme, la fotografia di un momento statico e immutabile. Meglio lasciar
raccontare ad ogni protagonista la sua avventura, il suo particolare
lasciandolo vivere e incastrarsi di volta in volta con gli altri pezzi in quadri
sempre nuovi. Salivo i gradini della scatola di pietra e luce creata da Meier e
costruita fra mille polemiche, e pensavo a questa semplice verità. Mi sono
fermato alla biglietteria dell’Ara Pacis dopo aver spinto la pesante porta di
vetro; intanto guardavo il cono d’ombra all’ingresso del monumento. È
un’opera giocata sui chiaroscuri, chiaroscuri che ora però è impossibile
riconoscere nel loro significato originario e interpretare. Per comprenderli ci
siamo lasciati guidare dal genio di Fausto Delle Chiaie, un pittore, un artista
che ogni giorno dipana il suo atelier d’arte lungo la strada che separa l’Ara
dal mausoleo d’Augusto e osserva noi curiosi dall’esterno di questa teca.
Intanto il suo Manifesto infrazionista dell’arte, pur ideato negli anni Ottanta
in tutt’altro clima culturale da quello dei nostri giorni, non perde colpi nella
sua sempre attuale capacità di descrivere la realtà, anche questa realtà. In base
a quella filosofia dell’arte e della vita, l’artista ancora oggi raccoglie
quotidianamente i frammenti della vita, frutto ciascuno del suo particolare
punto di vista su di essa, e li mette in fila su un muretto. È un muretto quanto
mai precario perché è quello della recinzione agli eterni lavori di
manutenzione del mausoleo. Precario come le sequenze occasionali create da
Delle Chiaie con le sue piccole opere: ogni giorno il suo racconto d’arte e di
storia si dipana fra l’Ara e il mausoleo in modo sempre nuovo, eppure con i
soliti vecchi pezzi. Tessere che si incastrano quotidianamente e perfettamente
nella sua azione d’arte sempre nuova. Metafora di quell’Ara di fianco alla
quale lavora. Fa delle sue opere punti disseminati quali sassolini a formare un
sentiero che ci accompagna nella vita. La storia da sola no, non riesce a
incollare tutti i cocci del passato e a riordinarli. Ciò malgrado da quei
frammenti di passato ogni giorno ci si palesa un quadro nuovo, nasce e
rinasce una nuova Ara Pacis, ci viene offerta una rappresentazione, sempre
nuova e con sempre nuovi misteri e suggestioni, proprio come l’atelier di
Delle Chiaie.
Passo la biglietteria e spingo la seconda pesante porta di vetro che conduce
all’interno, che introduce in presenza del monumento. Sono nel cono
d’ombra e guardo lontano cercando i colori, lo sfavillante caleidoscopio di
colori che l’altare della Pace promanava quando venne costruito, duemila e
passa anni fa. Perché allora marmi e bassorilievi erano colorati come quadri
sgargianti. Vengo invece abbagliato dal bianco dei suoi marmi puri di
Carrara. I colori non ci sono più e ci beiamo oggi della falsità di quel
candore. È impossibile incollare le impressioni su quello che era. Non ci resta
che accontentarci di quello che è e da lì partire, non ci resta che indagare,
cercare compagni di viaggio che ci prendano per mano e ci raccontino la
storia, ciascuno la sua parte della storia di questo monumento. Solo così
potremo raccogliere i frammenti che si sono appesi disordinati sulle pareti
della nostra immaginazione e potremo cercare di ricostruire e ricomporre noi
una nuova immagine, una nuova opera.
È un susseguirsi di emozioni, sparse nel tempo, molte ancora nel futuro,
come un mare che rincorre le sue onde all’infinito sulla battigia, quello che
sgorga da qui. Come l’emozione che provai quando lessi su un libro la data di
inaugurazione dell’Ara Pacis: 30 gennaio del 9 a.C. Ebbi un sussulto e pensai
perché quella data mi appariva così familiare. Mi ci volle poco per ricordare
che si trattava del giorno del cinquantesimo compleanno di Livia Drusilla, la
moglie di Augusto. Mia vicina di casa al nono miglio sulla Flaminia con la
sua villa di campagna, è la donna che mi ha accompagnato tante volte
prendendomi per mano e mi ha portato a visitare luoghi e storie, palazzi e
strade, affreschi e monumenti, ad ascoltare colloqui e ad indagare nei segreti
dei cuori, a immaginare personaggi e fatti della Roma augustea e del secolo a
cavallo dell’anno 0, duemila e passa anni fa. È un anno chiave della nostra
civiltà e della storia di Roma. Eppure non esiste nella storia dell’urbe,
semplicemente perché i romani non conoscevano lo 0 né l’avevano nelle loro
numerazioni. Non c’è nessun anno 0 nella storia di Roma, esiste solo nella
protervia delle nostre ricostruzioni. Eppure è un anno chiave, spartiacque
della storia e della civiltà.
Non c’era dubbio: il monumento della Pace era stato voluto dal Senato 13
anni prima di quell’inesistente zero per celebrare i successi di tre anni di
campagne di Augusto fra Germania, Francia e Spagna, e per sancire l’inizio
del secolo aureo della pace cantato da Orazio. Niente a che fare con Livia e la
sua data di nascita, dunque. Ma Augusto aveva poi voluto che quell’Ara fosse
inaugurata, dopo oltre tre anni di lavori, proprio nel giorno del cinquantesimo
compleanno della moglie, per celebrare e ricordare nei secoli dei secoli la
figura di Livia, per farne memoria e metterla su quel piedistallo che la storia
le aveva riservato. E noi l’abbiamo dimenticato e cancellato, quel piedistallo.
Non lo ricordiamo oggi perché lo dimenticarono presto anche i Cesari che
raccolsero – e inquinarono – il principato dopo Augusto. A iniziare da
Tiberio che cercò di far dimenticare madre e patrigno. E perché fu la terra,
ancora prima della memoria, a inghiottire e ricoprire quel monumento. Fu la
terra a fare scomparire l’Ara inghiottendola nelle sue viscere, con l’aiuto del
Tevere, il ceruleo Tevere che ricopriva con le sue acque limacciose il campo
Marzio ad ogni piena, ad ogni inondazione e stendeva uno strato di limo su
quei prati; così il livello della terra saliva piena dopo piena, inondazione dopo
inondazione; e così scendeva e sprofondava sempre più giù, fino a
scomparire, quell’opera magniloquente del principato augusteo.
Una seconda emozione mi fece sobbalzare quando rimirai il modellino
della sistemazione del campo Marzio voluta da Augusto, modellino costruito
da pochi anni e posato ora a fini didattici all’ingresso del museo che
racchiude il monumento ricostruito a qualche centinaio di metri da dove è
stato dissepolto. Mostra, quel modellino, il campo Marzio settentrionale così
come l’aveva pensato Augusto con i suoi monumenti principali, con il
mausoleo e la sua porta orientata proprio in linea con l’ingresso del Pantheon
a fare delle due costruzioni un’opera unica. Dialogo unico e intenso fra gli
ingressi di Pantheon e mausoleo e dialogo anche fra gli dèi che li abitano,
divinità celesti nel primo caso e divinità terrene nel secondo, divinità che si
rimirano e si uniscono in un unico sguardo a distanza fra loro. Gli dèi del
passato, a iniziare dal dio Romolo che da lì dov’è il Pantheon ascese al cielo,
tendono la mano agli dèi dell’età di Augusto, a iniziare dal principe, che nel
mausoleo hanno visto deposte le loro ceneri a riposare. C’è poi un altro
dialogo fra due monumenti reso evidente dal modellino. La ricostruzione
mostra che l’obelisco-meridiana eretto allora per raccontare le ore, i giorni, le
feste e gli anni dell’età del principato è in asse con l’altare, un’ara elevata nel
punto esatto nel quale lo gnomone della meridiana proiettava la sua ombra la
sera del 23 settembre, compleanno d’Augusto. Il 23 di ogni settembre
l’ombra di Augusto si proiettava sul cuore dell’altare della Pace, dell’altare di
Livia. Ma dove calava quel giorno il sole nell’altra direzione della retta che
univa altare e obelisco? Tornai a casa e cominciai a sfogliare le carte con la
ricostruzione della Roma di quegli anni per tracciare percorsi celesti del sole
e sue proiezioni terrene: quella retta indica che il sole va a tramontare proprio
dietro il monte Vaticano ogni 23 di settembre, esattamente dove
appressandosi lo scadere del secolo aureo venne levata la croce con Pietro ad
agonizzare e a morire a testa in giù e dove ora si trova la cupola
michelangiolesca sulla tomba di quel santo e primo papa, pontefice massimo,
come pontefice massimo di altri dèi era stato Augusto. Pochi anni dopo
l’inizio di quel secolo aureo, Augusto innalzò l’obelisco del tempo e l’altare
della Pace su quella terra; pochi anni prima della fine di quel secolo Pietro la
fecondò, quella terra, finendo a capo in giù su una croce, il tutto a poche
centinaia di metri di distanza. Suggestioni e contaminazioni.
Fu il Senato a decidere l’elevazione di un altare alla dea Pace. A
raccontarcelo è lo stesso Augusto nelle Res gestae, l’autobiografia che il
principe dettò l’anno prima di morire e nella quale inserì ogni atto della sua
vita che lui ritenne degno di nota e obliò le altre azioni, sconvenienti o
inconsistenti che fossero, perché nulla di quella storia restasse inquinato. Nel
testo, scritto per essere inciso su lastre di bronzo da mettere all’ingresso del
suo mausoleo romano a tumulazione avvenuta, si legge: «Quando tornai a
Roma dalla Spagna e dalla Gallia, sotto il consolato di Tiberio Nerone e di