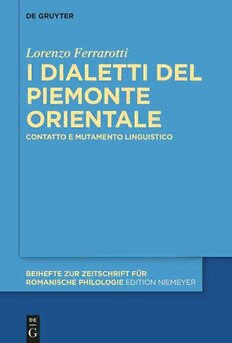Table Of ContentLorenzo Ferrarotti
I dialetti del Piemonte orientale
Beihefte zur Zeitschrift
für romanische Philologie
Herausgegeben von
Éva Buchi, Claudia Polzin-Haumann, Elton Prifti
und Wolfgang Schweickard
Band 465
Lorenzo Ferrarotti
I dialetti del
Piemonte
orientale
Contatto e mutamento linguistico
ISBN 978-3-11-076013-2
e-ISBN (PDF) 978-3-11-076018-7
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-076024-8
ISSN 0084-5396
Library of Congress Control Number: 2021945884
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Typesetting: Integra Software Services Pvt. Ltd.
Printing and binding: CPI books GmbH, Leck
www.degruyter.com
Contenuti
Introduzione IX
1 Questioni generali 1
1.1 Questioni teoriche e prospettive adottate 1
1.1.1 Il mutamento linguistico 1
1.1.2 La diffusione spaziale del mutamento linguistico 4
1.2 La situazione piemontese 7
1.2.1 Demografia del Piemonte e diffusione di tratti linguistici 7
1.2.2 Il dialetto di Torino e la koinizzazione 15
1.2.3 Aspetti di diacronia del piemontese 21
1.2.4 Le classificazioni del piemontese 22
1.2.5 Cenni di storia del Piemonte 35
1.3 Metodo descrittivo 41
1.3.1 Struttura dei capitoli e trattazione della materia 41
1.3.2 Dati 41
1.3.3 Creazione delle carte e indicazioni per la lettura 45
2 Fonetica e fonologia 49
2.1 Vocalismo 49
2.1.1 Palatalizzazione di -āre; -āriu 49
2.1.2 [u] pedemontana 59
2.1.3 Dittongazione di ē, ĭ in sillaba aperta 64
2.1.4 Sincope delle vocali protoniche 68
2.1.5 Presenza di [ə] tonica da ē, ĭ in sillaba chiusa 71
2.1.6 Modificazioni di /a/ tonica prima di nasale 77
2.1.7 Altri fatti di vocalismo 81
2.2 Consonantismo 84
2.2.1 Articolazione della nasale intervocalica postonica 84
2.2.2 Esiti di -c-/-g- intervocalica 87
2.2.3 Velarizzazione di al 92
2.2.4 Esiti di -cl- 95
2.2.5 Esiti di -ct- 102
2.2.6 Esiti di -t-/-d- 107
2.2.7 Inserimento di [g] non etimologica 114
2.2.8 Esiti di c, g + e, i 116
2.2.9 Esiti di -tj- 121
2.2.10 Esiti di -ĕr(u), -ĕr(e) 123
VI Contenuti
2.2.11 Esiti di w germanica 125
2.2.12 Altri fatti di consonantismo 127
3 Morfologia e sintassi 131
3.1 L’articolo 131
3.1.1 Articolo determinativo maschile singolare 131
3.1.2 Articolo determinativo femminile plurale 134
3.1.3 Altre osservazioni sull’articolo 137
3.2 Il nome 139
3.2.1 Plurale della classe nominale in -a (femminili) 139
3.2.2 Genere di fiore, sale, miele, fumo 143
3.2.3 Altre osservazioni 145
3.3 Morfologia e sintassi dei pronomi 147
3.3.1 Pronome personale di 3sgm 147
3.3.2 Clitico oggetto 3sgm 151
3.3.3 Posposizione dei clitici complemento dopo il participio passato 152
3.4 Morfologia verbale 157
3.4.1 Infinito della III coniugazione 157
3.4.2 1sg indicativo presente 158
3.4.3 2sg indicativo presente 160
3.4.4 3pl indicativo presente del verbo essere 163
3.4.5 1sg indicativo presente del verbo avere 164
3.4.6 2sg indicativo presente del verbo avere 168
3.4.7 Pronome dativo locativo esistenziale e occorrenza con il verbo avere
lessicale 169
3.4.8 [g] non etimologica nel paradigma di vedere 175
3.4.9 Altri fatti di morfologia verbale 176
3.5 Morfologia e sintassi della negazione 180
3.6 Altri fatti di morfologia e sintassi 190
3.6.1 Assegnazione degli ausiliari 190
4 Lessico 191
4.1 Diffusione lessicale nel Piemonte orientale 191
4.1.1 Donna 191
4.1.2 Lavorare 193
4.1.3 Muovere 195
4.1.4 Ontano 197
4.1.5 Sordo 198
4.1.6 Cieco 200
4.1.7 Legno/falegname 202
Contenuti VII
4.1.8 Accendere 203
4.1.9 Nomi di parentela: nonno/nonna, zio/zia 204
4.1.10 Giallo 208
4.1.11 Nudo 210
4.1.12 Altri fatti lessicali 210
4.2 Diffusione lessicale in tutto il Piemonte 219
4.2.1 Sedia 219
4.2.2 Campana/campanile 222
4.2.3 Undici/dodici 225
5 Conclusioni 229
5.1 Dinamiche diffusionistiche 229
5.1.1 L’«influsso lombardo» nel Piemonte orientale 229
5.1.2 Possibili lombardismi e koinizzazione in torinese 231
5.1.3 Il torinese come dialetto di koiné e la diffusione di tratti
linguistici 235
5.1.4 Tratti urbani 237
5.1.5 Tratti locali e aree conservative 238
5.1.6 Il contatto linguistico nell’area 250
5.2 Classificazioni del piemontese e ripartizioni dialettali 253
5.2.1 Classificazioni generali 253
5.2.2 Piemontese orientale e occidentale: una proposta di
classificazione 256
5.2.3 Rapporto piemontese-lombardo e classificazioni locali 259
6 Bibliografia 265
7 Carte 279
8 Appendice 393
8.1 Appendice a 2 Fonetica e fonologia 393
8.2 Appendice a 3 Morfologia e sintassi 507
8.3 Appendice a 4 Lessico 581
Introduzione
Già dagli albori degli studi linguistici, i dialetti piemontesi hanno ricevuto una
grande attenzione da parte della ricerca scientifica, che li ha esaminati con
metodi e obiettivi diversi. La maggior parte dei lavori, tuttavia, si è concentrata su
un unico punto linguistico, su una singola zona, o su un numero comunque circo-
scritto di tratti linguistici: di rado sono state prese in considerazione aree medie
e grandi o più tratti in una prospettiva generale. Questa mancanza rende ancora
oggi piuttosto difficile avere una visione di insieme sui dialetti piemontesi, non
essendo disponibile, oltretutto, un atlante regionale. Non è raro, infatti, che un
tratto linguistico sia ritenuto tipico di una zona, quando può essere in realtà
ampiamente diffuso in molte altre; inoltre, è frequente assistere all’accomuna-
mento, per mancanza di dati, di aree linguistiche piuttosto diverse, sovente con
una prospettiva condizionata dalla varietà dominante e meglio descritta, quella
di Torino, o da quella meglio conosciuta dal singolo ricercatore. Questo appiat-
timento spesso oscura la vivace e significativa variabilità linguistica dell’area
piemontese, che è caratterizzata dalla compresenza di varietà urbane innovative
e aree rustiche conservative, nonché dalla sussistenza di sub-aree linguistiche
piuttosto compatte e storicamente rilevanti.
Uno dei principali obiettivi di questo studio,1 pertanto, è colmare, almeno
in parte, questa lacuna. Si è scelto di indagare un’area scarsamente studiata nel
suo complesso, cioè il Piemonte orientale. Si cercherà innanzitutto di soddisfare
un’esigenza di tipo descrittivo, compiendo un’analisi delle caratteristiche lingui-
stiche delle varietà in oggetto con approcci diversi, descrivendo i fatti linguistici
sia in sincronia, sia in diacronia, sia dando conto della loro distribuzione geo-
grafica sull’area indagata, con l’uso di carte linguistiche. Per quanto possibile, si
prenderanno in considerazione più livelli di analisi, anche tenendo presente la
scarsa attenzione che gli studi di geografia linguistica tradizionalmente hanno
dedicato alla morfologia e alla sintassi. La scelta del Piemonte orientale, si noti,
non è dovuta solo a un interesse geolinguistico di tipo documentario, ma anche
sociolinguistico, poiché quest’area rappresenta un caso ideale per descrivere
i fenomeni di contatto tra le varietà dialettali del Nord Italia: non contenendo
grandi centri urbani, è una zona piuttosto frammentata linguisticamente che
1 Il lavoro è il frutto di una rielaborazione della mia tesi del Dottorato in Lettere, curriculum in
Dialettologia italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica (XXXI ciclo), Università di Torino,
dal titolo Contatto dialettale e mutamento linguistico: il Piemonte orientale (tutor prof. Riccardo
Regis), discussa il 4 marzo 2019 con una commissione composta dai proff. Silvia Dal Negro,
Gabriele Iannàccaro e Davide Ricca. Alcune questioni preliminari relative al lavoro sono descritte
in Ferrarotti (2021a).
https://doi.org/10.1515/9783110760187-203
X Introduzione
giace tra due grandi città, Milano e Torino, che, come è noto, hanno influenzato
in maniera significativa lo spazio linguistico circostante. Non è chiaro, tuttavia,
in quale misura e in quanto tempo ciò sia avvenuto: affrontare questo aspetto
sarà un altro obiettivo di questo studio. In particolare, si cercherà di verificare se
e come il dialetto di Torino, tradizionalmente considerato una koiné conosciuta
in tutta la regione in qualità di varietà veicolare usata per la comunicazione tra
parlanti di zone diverse, abbia potuto influenzare i dialetti locali. Lo studio di
questi argomenti sarà condotto facendo riferimento ad alcune teorie sociolingui-
stiche di contatto dialettale (dialect contact), al fine di fornire una ricostruzione
più fondata dei rapporti tra le diverse varietà.
Nel cap. 1 si darà conto dei principali riferimenti teorici adottati (§1.1), di una
rassegna dello stato dell’arte e di alcune questioni importanti per questa ricerca
(§1.2), dell’impostazione e della struttura del lavoro (§1.3). I capp. 2, 3 e 4 conten-
gono l’analisi dei dati, ai diversi livelli di analisi. Nel cap. 5 si sono tratte alcune
osservazioni conclusive. Il cap. 6 contiene la bibliografia, mentre il cap. 7 con-
tiene le carte che sono commentate nei vari capitoli; nell’Appendice, cap. 8, sono
riportati i dati utilizzati per l’elaborazione delle carte.
Ringrazio Riccardo Regis per la guida costante e i numerosi consigli; Silvia
Dal Negro, Gabriele Iannàccaro e Davide Ricca per la lettura e le preziose indi-
cazioni; Matteo Rivoira e la redazione dell’ALI per avermi consentito di usare i
materiali inediti dell’Atlante. Ho un grande debito di gratitudine verso i miei infor-
matori, senza i quali questo lavoro sarebbe stato incompleto: Giuseppe Castello,
Bruno Ferrarotti, Carla Francesio, Piera Gagnone, Gianfranco Pavesi, Emanuele
Regano, Enzo Rivalta, Alfredo Signorelli, Giuseppina Varese, Rina Varese; allo
stesso modo ringrazio Stefano Bellone, Michelangelo Bonassisa ed Elena Signo-
relli per la loro generosa disponibilità. Infine, sono grato ad Andrea di Stefano e a
Sergio Garuzzo per avermi fornito una copia delle loro grammatiche.