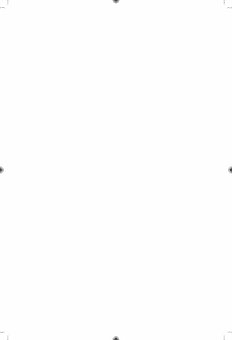Table Of ContentA L M
NDREA E OLI
HEIDEGGER:
SOGGETTIVITÀ
E DIFFERENZA
Questione dell’uomo
e impegno ontologico
MIMESIS
La Scala e l’Album
Volume pubblicato con contributo MURST ex 60% anno 2007 su Soggettività, onto-
logia, autocoscienza: radici classiche e prospettive critiche assegnato al Dipartimento
Fieri-Aglaia di Palermo e con contributo PRIN 2009 su Ontologia, ermeneutica, poli-
tica: percorsi storici e strutture teoriche. Comunità, verità e impegno ontologico (Unità
di Palermo).
© 2011 – MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
Collana La Scala e l’Album
www.mimesisedizioni. it / www.mimesisbookshop.com
Via Risorgimento, 33 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono +39 02 24861657 / 24416383
Fax: +39 02 89403935
Via Chiamparis, 94 – 33013 Gemona del Friuli (UD)
E-mail: [email protected]
INDICE
PRESENTAZIONE
di Pietro Palumbo p. 7
PREMESSA p. 19
I. SOGGETTIVITÀ E VITA:
Neokantismo, fi losofi a cristiana, fenomenologia
nei primi corsi friburghesi (1919-1921) p. 21
II. LA VITA E IL LOGOS:
Le interpretazioni fenomenologiche
di Aristotele e Platone (1921/22-1926) p. 69
III. ONTOLOGIA E STORIA:
Il confronto con Dilthey (1919-1925) p. 109
IV. ONTOLOGIA COME ORIZZONTE TRASCENDENTALE:
Gli anni ’20 e la questione Heidegger-Husserl p. 129
V. VERITÀ, FINITEZZA, TRASCENDENZA:
La «svolta» e gli anni ’30 p. 147
VI. SOGGETTIVITÀ E DIFFERENZA:
La questione dell’uomo nella storia
dell’essere (1940-49) p. 177
CONCLUSIONI p. 215
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI p. 217
7
PIETRO PALUMBO
PRESENTAZIONE
Potrebbe sembrare paradossale che uno studio approfondito e informa-
to sul pensiero heideggeriano metta esplicitamente a tema la soggettività
in relazione con la differenza ontologica, quando l’obiettivo polemico più
proprio del pensiero di Heidegger, anche all’interno della sua articolazione
interpretativa dell’intera storia della fi losofi a occidentale, si può dire vada
nella direzione di un affrancamento dall’idea di uomo come “soggetto”, e
pertanto proprio nel verso di un superamento del primato della coscienza
rispetto all’essere. Infatti, come Heidegger stesso sostiene, per aprirsi al
pensiero dell’essere consapevole della differenza ontologica, si tratta di
riuscire a superare quella prospettiva di pensiero (metafi sica) per cui l’ente
è visto semplicemente come oggetto per il soggetto, il cui rappresentare
assume il carattere di un afferrare concettualmente (Begriffen), e di un fon-
dare. Per questo ogni metafi sica, afferma Heidegger, è umanistica, ovvero
pone l’uomo, la soggettività umana, al centro di tutto, quale dominatore;
e viceversa, ogni umanismo è con ciò stesso pensiero metafi sico, ovvero
oblia l’essere, riducendolo all’ente, manipolabile oggetto per la coscienza.
Eppure proprio questo rapporto tra soggettività e differenza ontologica
risulta il luogo cruciale per una comprensione non schematica del pensiero
dell’essere heideggeriano, il quale infatti sin dai suoi inizi si mostra radi-
calmente percorso dall’obiettivo e dalla diffi coltà di un ripensamento della
vita e dell’essere dell’uomo, della sua soggettività, in una prospettiva più
autentica e concreta, ma nello stesso tempo di un ripensamento del proble-
ma dell’essere che non perda la profondità e l’estensione con cui si è carat-
terizzato grazie al pensiero classico e medievale. Dunque rimettere a tema
prepotentemente il problema dell’essere in una chiave nuova, mettendo
in discussione il primato della coscienza affermato dalla modernità, senza
però ignorare le istanze esistenziali e teoretiche della soggettività umana;
ripensare il senso dell’essere in rapporto necessario con l’essere dell’uo-
mo: questa si può dire sia la sfi da del pensiero heideggeriano, il quale per-
corre un cammino diffi cile e travagliato, non esente da cambiamenti signi-
fi cativi che lo portano fi no ad esiti inediti, complessi e drammatici, come
8 Heidegger: soggettività e differenza
quelli che non gli fanno più riconoscere i propri sforzi speculativi quali
sforzi e compimenti soggettivi (di Heidegger quale pensatore), ma come
istituiti, posti in essere dall’essere stesso! Ora, gli studi di Andrea Le Moli
vanno appunto al cuore di questi percorsi e di queste svolte, illuminando
con molta cura le questioni e i passaggi che di volta in volta Heidegger si
trova ad affrontare per mantenere ferme le due direzioni della questione, e
chiarendo con dovizia di informazione la collocazione storico fi losofi ca di
tali sentieri e dei loro sbocchi.
Sin dal primo corso di insegnamento che Heidegger tiene a Friburgo nel
1919 egli esordisce intendendo la fi losofi a come ‘scienza originaria’, cioè
come quel piano ideale di fondazione ultima che sfocia a suo parere in quel-
la che defi nisce come una ‘intuizione ermeneutica’, la quale però ‘spezzi
il primato del teoretico’, risultando costitutivamente capace di appropriarsi
(e qui già compare una prima volta il concetto di Er-eignis) di tutte quelle
tensioni e connessioni di signifi cato proprie di una soggettività concreta,
immersa nell’esperienza vitale, che dunque costituirebbe un piano di fon-
dazione più originario della sola dimensione teoretica, pensata tradizional-
mente come la più fondamentale e specifi ca dell’uomo. Il primo capitolo
del libro di Le Moli mostra con attenzione come il pensiero heideggeriano
in questa prima fase, pur mantenendosi all’interno delle infl uenze del pen-
siero di Dilthey, e del Neokantismo della fi losofi a dei valori, ne costituisca
già un superamento verso una concezione della soggettività di tipo feno-
menologico, la quale nella sua capacità di trascendenza pure non riduca né
l’oggetto né il soggetto stesso nei termini teoretico-oggettuali della sogget-
tività trascendentale di tipo kantiano. E già nei corsi immediatamente suc-
cessivi, di taglio programmaticamente fenomenologico, emerge in modo
originale una interpretazione dell’essere dell’Io nei termini di un ‘avere me
stesso’ (Michselbsthaben), ed il conseguimento di questo senso dell’essere
in termini di avere costituisce la guida delle analisi degli anni successivi,
mentre nel contempo prende rilievo la dimensione della storicità quale ca-
ratteristica più propria della vita. In questa direzione Heidegger approfon-
disce la sua originaria convinzione circa la necessità di una messa in luce
dei nessi motivazionali del teoretico con la sua base concreta e vitale. E,
superando le tendenze oggettivistiche alle quali fi nivano pur sempre per
cedere sia Dilthey che Natorp, la vita appare ad Heidegger dominata da uno
stato di inquietudine e di angosciata preoccupazione (Bekuemmerung) per
uno ‘scivolar via dall’origine’, stato che però appunto non va risolto attra-
verso una fuga in formazioni oggettive guidate dal rigore scientifi co, ma
piuttosto va affrontato attraverso un comportamento fi losofi co che eleva il
soggetto ma mantenendolo nella sua insicurezza originaria. Ed è a questo
P. Palumbo - Presentazione 9
punto il cristianesimo che offre ad Heidegger il modello paradigmatico per
un costituirsi del mondo del sé in modo autentico.
Si apre in questo modo la prospettiva che rimane come guida della ri-
cerca heideggeriana circa fi no al 1923, riguardo al modo di confi gurazione
dell’esperienza vitale quale faktische Lebenserfahrung. La fatticità della
vita consiste secondo Heidegger in una esperienza che la vita fa di sé come
insieme di tendenze contrastanti, decadenti e riapproprianti, movimenti
inautentici verso forme oggettivanti e movimenti che riportano la vita in
modo autentico a se stessa. Ora l’esperienza della vita cristiana delle ori-
gini qui costituisce una essenziale indicazione per una forma autentica del
movimento di riappropriazione della vita, per quella dimensione genuina-
mente storica che l’attesa della parousia le conferisce, generando un senso
del tempo tutto orientato sul futuro. Infatti la forma di vita cristiana presen-
ta un ordine del tempo basato su ciò che ancora non c’è, sul non-ancora, un
ordine anti-assicurante ma corrispondente alla conservazione più alta della
vita, ovvero che custodisce insieme l’ inquietudine e la sua cura.
Attraverso le rifl essioni sulla vita cristiana delle origini e sul pensiero di
Agostino Heidegger ha raggiunto fi no a qui una concezione della vita sto-
ricamente caratterizzata, e segnata da tensioni interne che devono trovare
una guida in un particolare orientamento del tempo. Ma, come dice bene
Le Moli, si tratta ora di vedere se questo livello di fondazione raggiunto sia
davvero l’ultimo nell’ordine della ricerca ‘originaria’, o “se l’esperienza
religiosa cristiana non attinga essa stessa ad un orizzonte di fondazione an-
cor più profondo. Resta da capire cioè se il tipo di connessione individuato
tra tempo, vita e movimento sia qualcosa che specifi chi originariamente
l’esperienza cristiana o non sia già piuttosto una traduzione in termini cri-
stiani di un tipo di esperienza più antico e originario”.
Acquisita dunque una concezione originale della soggettività e aven-
do impresso già una particolare curvatura al metodo fenomenologico, le
interpretazioni fenomenologiche di Aristotele e di Platone condotte negli
anni 1922-1926 costituiscono per Heidegger il terreno per misurarsi più
dappresso con la concezione moderna della soggettività in quanto il ri-
corso alla fi losofi a greca, chiarisce Le Moli, gli permette di affrontare la
connessione soggettività-vita in un modo appunto non ancora condizionato
dal modello moderno, e cioè da una identifi cazione della vita con l’insieme
dei processi interni ad un Io o ad una coscienza. Com’è noto Heidegger in
particolare crede di ritrovare in Aristotele spunti fondamentali per una pro-
blematizzazione della rifl essione sull’essere e sul suo signifi cato per l’io
nel contesto della vita fattizia. Infatti nell’analisi dell’opera di Aristotele
si può ricavare secondo Heidegger quell’atteggiamento fi losofi co che è in
10 Heidegger: soggettività e differenza
grado di mantenere il movimento fondamentale della vita verso ciò che qui
denomina ‘rovinio’, ossia che tende a tradursi in oggettualità devitalizzate,
orientandolo positivamente, ovvero in senso ‘controrovinante’. In questo
modo si confi gura una traduzione dei termini chiave della fi losofi a aristote-
lica nelle forme e nel lessico della fenomenologia della vita elaborati fi n qui
da Heidegger. In particolare la cura di Heidegger sta nel riportare al livello
della vita e dell’esperienza soggettiva i concetti espressi da Aristotele in
una prospettiva di tipo teoreticistico, per cui anche la dimensione suprema
della theoria viene interpretata come un modo in cui la vita si rapporta a se
stessa in vista della soddisfazione di certi scopi e bisogni. In questo con-
testo particolarmente signifi cativi sono i rilievi di Heidegger circa la non
appartenenza del concetto di Dio e del suo ruolo in Aristotele all’ambito
dell’esperienza religiosa, e la sua collocazione in riferimento all’indagine
fi sica. Altrettanto vale per quelli circa la non originarietà del conoscere con
la conseguente riduzione del senso primario dell’essere ad oggetto presen-
te, e la riconduzione del senso dell’essere ai termini della vita, e dunque
l’essere come movimento. Diventa così essenziale in questa fase l’interro-
gazione ontologica sull’esserci umano riguardo al suo peculiare carattere
d’essere, sempre in riferimento ai movimenti propri della vita umana da
una parte verso forme di decadimento e dall’altra verso forme di riappro-
priazione di sé. E il contromovimento di riappropriazione della vita viene,
all’interno del Natorp-Bericht, nota Le Moli, designato, in una delle prime
volte in cui Heidegger ricorre a questo termine, come Existenz, mettendo
così in chiaro che è rivolgendosi alla fatticità della vita nelle sue possibilità
più proprie che si apre l’occasione di una più autentica problematizzazione
dell’essere della vita. Grazie ad una ermeneutica decostruttiva a partire da
Aristotele Heidegger pensa pertanto di rinnovare la comprensione del sen-
so e del destino dell’ontologia e della logica occidentale, dipanandone le
interpretazioni tramandate, in vista della possibilità di una appropriazione
fi losofi ca più autentica della vita e dell’essere dell’uomo.
Acquisita quella che ritiene essere una antropologia fenomenologica
radicale Heidegger procede nel legare unitariamente il pensiero aristote-
lico con quello di Platone, pervenendo alla convinzione circa l’esistenza
di “un dispositivo generativo in grado di articolare in prospettiva unitaria
l’intera storia dell’ontologia occidentale dai Greci a Nietzsche”. La carat-
terizzazione greca della vita riposta essenzialmente nella sua natura mo-
bile e diveniente, la rifl essione sulla physis come fenomeno fondamentale
all’interno del quale e in riferimento al quale l’uomo è chiamato a prendere
posizione e ad agire, forniscono ad Heidegger i mezzi per poter interpre-
tare le modalità principali di atteggiamento dell’uomo. In questa direzione