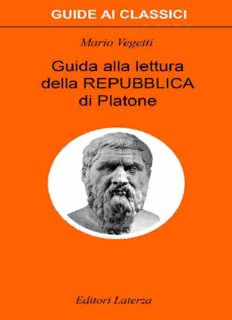Table Of Content© 1999, Gius, Laterza & Figli
Prima edizione 1999
Quarta edizione 2007
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi
l’autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza
di un modo di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque
favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.
Mario Vegetti
GUIDA ALLA LETTURA DELLA
REPUBBLICA
DI PLATONE
EDITORI LATERZA
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nel gennaio 2007
Poligrafico Dehoniano - Stabilimento di Bari
per conto della Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-420-5895-3
RINGRAZIAMENTI
Le premesse metodologiche di questo lavoro sono state discusse in
seminari tenuti nel marzo del 1998 presso l’Istituto di Studi filosofici di
Napoli, che ringrazio per la generosa disponibilità. Ringrazio inoltre tutti
gli amici e colleghi che collaborano al commento alla Repubblica in corso
di pubblicazione presso l’editore Bibliopolis, con i quali ho discusso molte
delle prospettive esegetiche presentate in questo libro.
M.V.
GUIDA ALLA LETTURA
DELLA “REPUBBLICA”
Capitolo primo
GENESI DELL’OPERA
1. Data di composizione
La tradizione ha da sempre riconosciuto nella Repubblica
probabilmente il più importante, e senza dubbio il più controverso, fra i
dialoghi di Platone. La sua stessa ampiezza, seconda soltanto alle Leggi, e la
complessità dei suoi contenuti, che non ha certamente rivali, rendono
pressoché insolubile il problema della data, o meglio del periodo, della sua
composizione. Il vecchio consenso che assegnava alla Repubblica una ‘data
di pubblicazione’ intorno al 375 è certamente insostenibile, perché nessuna
opera antica è stata ‘pubblicata’ in modo definitivo in un determinato
anno, quasi si trattasse di un libro a stampa, perché nulla sappiamo delle
modalità di circolazione e di diffusione dei dialoghi platonici, e perché più
in particolare un grande dialogo come la Repubblica è stato
certamente composto, e forse parzialmente reso noto, lungo un esteso
periodo di tempo.
È però possibile identificare con una certa sicurezza un termine
cronologico che antecede la composizione della Repubblica, o almeno della
sua parte centrale. Proponendo di assegnare alle donne funzioni politiche e
militari simili a quelle maschili, che comportano fra l’altro la nudità negli
esercizi ginnastici, Platone afferma nel V libro di temere la derisione dei
comici professionisti. È difficile non vedere in questa allusione un
riferimento alle Ecclesiazuse di Aristofane, una memorabile commedia che
fu rappresentata nel 392/1 e che forse satireggiava a sua volta idee di tipo
comunistico diffuse, nel dibattito intellettuale della fine del V secolo, dagli
ambienti sofistici e anche socratici. Secondo l’autotestimonianza della VII
lettera (che viene generalmente considerata come autentica), il primo
viaggio di Platone in Sicilia, nel 388/7, sarebbe stato ispirato anch’esso da
un’idea centrale del V libro, la necessità di risanare le città affidandone il
governo a filosofi o a potenti convertiti alla filosofia. È dunque probabile
che a quest’epoca Platone avesse già presenti le idee centrali della filosofia
politica della Repubblica, e che l’elaborazione del dialogo abbia dunque
avuto inizio verso il 390 o più probabilmente dopo il ritorno dalla Sicilia,
intorno al 387.
Molto più difficile l’identificazione del periodo in cui avrebbe avuto
termine la composizione del testo. Si tratta anzi di un problema in linea di
principio mal posto, visto che sappiamo da buone fonti antiche che Platone
non avrebbe mai cessato, fino all’ultimo giorno di vita, di rielaborare
l’inizio del dialogo (cfr. Diogene Laerzio III 37, Dionigi di Alicarnasso de
comp. verb. 25).
È certo tuttavia che Platone considerava ormai nota la Repubblica, o
almeno parti di essa, all’epoca della composizione del Timeo, un dialogo
che si finge accaduto due giorni dopo quello che avrebbe dato luogo al
racconto socratico della Repubblica, e che riassume i contenuti politici dei
libri V e VI (21 a, 17 c-19 a). Riassunti simili compaiono anche in altri
dialoghi tardi di Platone, il Crizia (110 c-d) e le Leggi (IV 739 b-d).
Ma la Repubblica potrebbe esser stata data per nota anche prima del
Timeo, se a essa può venir riferita l’espressione «mitologizzare intorno alla
giustizia» del Vedrò (276 e), che riprende il tema del mythologein sulla
nuova città ricorrente nel dialogo (376 d, 501 e). E vero che tutti questi
riferimenti concernono soltanto il nucleo più strettamente politico della
Repubblica, e cioè i libri IV-V o nell’ipotesi più ampia il gruppo I-V (con
l’appendice VIII-IX). Ma ciò può dipendere non tanto dall’esistenza di due
strati compositivi, il secondo dei quali (VI-VII, X) sarebbe nettamente più
tardo (ma il fatto che esso venga ignorato anche nelle Leggi, notoriamente
l’ultima opera di Platone, rende l’ipotesi infondata), quanto piuttosto dai
contesti in cui viene rievocata la Repubblica, e senz’altro dal fatto che le sue
proposte politiche erano le più controverse e dibattute già durante la vita
di Platone.
La Repubblica o una sua versione sarebbe dunque stata nota in
ambiente per lo meno accademico prima del Timeo, o forse anche del
Vedrò. Anche la cronologia di questi due dialoghi è naturalmente incerta,
ma non sembra irragionevole pensare che il nostro dialogo abbia
cominciato a circolare in una forma simile a quella che noi leggiamo non
dopo il 375 o al più tardi il 370. Il periodo di composizione avrebbe
dunque occupato circa dieci anni nell’ipotesi più stretta (385-375), una
ventina in quella più ampia (390-370). Non è probabilmente necessario
scendere, come ha proposto Thesleff, fino al 360.
Per quanto riguarda la posizione della Repubblica all’interno della
cronologia degli scritti platonici (senza dubbio l’aspetto più importante
della questione), si può concludere con un ragionevole grado di sicurezza
che il dialogo nel suo insieme segua la composizione del Gorgia (anche se
una versione del I libro, forse sotto il titolo di Trasimaco, può esser stata
redatta in precedenza per venire poi rifusa nel corpo dell’opera), e preceda
quella del Fedro.
In rapporto invece alla biografia di Platone, l’elaborazione del dialogo è
probabilmente posteriore al primo viaggio in Sicilia (387), coincide con il
processo di costituzione dell’Accademia (forse a partire dal 385), e precede
il secondo viaggio in Sicilia (366), anche se il libro X potrebbe esser stato
aggiunto dopo questo viaggio.
2. Data drammatica e ‘società del dialogo’
I dialoghi platonici contengono spesso indicazioni relative alla loro data
‘drammatica’, cioè al periodo in cui si sarebbe svolto, secondo la finzione
letteraria, il dialogo narrato. Non è tuttavia facile stabilire questo tipo di
datazione per la Repubblica, che, accanto a un’indicazione sufficientemente
precisa (la prima celebrazione delle Bendidie, che può forse venir fissata al
429/8), contiene altri suggerimenti anacronistici rispetto a essa. Gli studiosi
si sono divisi fra due possibili datazioni: il 411 e il 425, o 422/1. La prima,
meno plausibile per la sua distanza dalla data inaugurale delle Bendidie,
avrebbe un grande interesse interpretativo, perché coinciderebbe con la
profonda crisi della democrazia ateniese e il conseguente tentativo di
instaurare una costituzione di carattere aristocratico a opera di Teramene:
un momento, dunque, in cui il dibattito politico e costituzionale era
particolarmente acceso. La seconda datazione farebbe invece coincidere il
dibattito della Repubblica con un momento alto della storia ateniese: i
successi nella guerra del Peloponneso e la conseguente pace di Nicia. A
quella antica pace potrebbe corrispondere, al livello della effettiva
composizione della Repubblica, la pace di Antalcida (386), che pure apriva
lo spazio per una radicale riflessione sul destino della città e sulle riforme
necessarie a garantirle un futuro migliore.
Molto più importanti, e di significato non dubbio, sono le indicazioni
platoniche sull’ambiente in cui il dialogo ha luogo, e sui suoi personaggi,
parlanti o muti, che costituiscono una vera ‘società dialogica’.
Il dialogo si svolge nella ricca casa del meteco Cefalo al porto del Pireo:
un luogo geograficamente e socialmente contiguo ma esterno alla polis
ateniese, dunque un punto di osservazione critica sui suoi fallimenti, le sue
difficoltà, le sue possibilità di rifondazione politica e morale. Il momento è
ancora più significativo: il dialogo si svolge nella notte in cui viene
celebrata la festa in onore della dea tracia Bendis. Un contesto straniarne,
notturno e barbarico: la discesa di Socrate al Pireo può venire
simbolicamente interpretata come quella discesa (katabasis) in un mondo
infero, che la tradizione attribuisce ai sapienti arcaici come Pitagora e
Parmenide. La visita al Pireo rappresenterebbe dunque per Socrate un
momento iniziatico, necessario all’acquisizione di una sapienza, che non
viene però rivelata da una divinità, come appunto nel caso di
Parmenide, ma acquisita in un duro confronto dialettico con le figure che
popolano la casa di Cefalo, fra le quali primeggia, come vedremo,
quella del sofista Trasimaco (il cui nome significa ‘violento
combattente’). Solo dopo essersi messo alla prova nel mondo notturno e
ostile del conflitto politico e culturale, Socrate potrà dunque compiere la
risalita (anabasis) alla città, arricchito del sapere necessario a riorientarne il
destino; di anabasis si parla infatti nel libro IV (445 c), una volta
completato il disegno di riforma costituzionale, e nel libro X al termine del
dialogo (621 c-d). In questa luce, il viaggio di Socrate al Pireo comporta
che egli ne esca diverso, più consapevole e ricco di sapere, rispetto a quello
che vi è disceso: una sorta di ‘romanzo di formazione’ del personaggio
Socrate, dunque, in cui si può benissimo leggere anche l’itinerario del
distacco di Platone dalle iniziali posizioni socratiche, quali sono
rappresentate, probabilmente con una certa fedeltà storica, nel dibattito
sulla giustizia del I libro.
I personaggi che agiscono nel dialogo accanto a Socrate costituiscono
uno spaccato fortemente rappresentativo della società ateniese della fine
del V secolo, con i suoi giovani aristocratici, i suoi ricchi, i suoi intellettuali,
i suoi artigiani di origine straniera (meteci). Uno spaccato tanto più