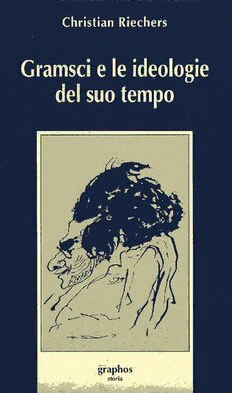Table Of ContentOT EUT TO
ZN
SSTC
eI OT ES t
MOE aO
DUTT 1)OST
storico-politologici sulla conflittualità
operaia, le cui ricerche si sono
concentrate sulla politica delle e
verso le maestranze tendenzialmente
rinchiuse nell'ambito isolato delle
loro aziende. Al centro di tali
A u e O AC
CO /ATC TTT
produzione di pace in cicli lunghi.
Riechers è impegnato nell'analisi
teorica del concetto di PBetrieb
(azienda), che in Germania ha avuto,
attraverso gli alterni regimi politici,
un impatto ideologico non
SE0 e COAO
ilaliane analisi della situazione in
Germania ed è intervenuto nel
dibattito sulla storia del PCI avviato
negli anni Sessanta dalla «Rivista
Ce SeAOT aTT
ha pubblicato saggi sul PCI, sul
SAO S OR0
UR S ri S
piuta da Amadeo Bordiga. Collabora
alla rivista «Internationale Wissen-
UUT u AAT
Geschichte der deutschen Arbeiter-
eAS aiT raa [C
CIOO e S eES t
OST o t STTC
TAS Ce COTT
CSOS n
S COU ri t iter I
e riO DO AIA ST
aa OA GAT AS aiT
l OEO S RO OC GO COLI
aOST SA ALI
u
Gramuci In una carlcatura di Fabrizio Maffi.
Christian Riechers
Gramsci e le ideologie del suo tempo
GRAPHOS
Titolo originale
Antonio Gramsci - Marxismus in ltalien
© 1970 - Europiisches Verlagsanstalt - Frankfurt am Main
© 1975 - Thélème coop. a r.1. - Napoli
© 1993 - Graphos - Via della Posta Vecchia, 5 - 16123 Genova
Traduzione di Domenico Lembo - Revisione di Cesare Boccardo
Finito di stampare nel mese di marzo 1993
dalla Editorgrafica s.r.l.
Roma - Via della Divina Provvidenza 96
Indice
Prefazione di A. Peregalli
Introduzione 11
Avvertenza 24
PRIMA PARTE 27
I. Marxismo e coscienza di classe borghese in Italia 29
II. Gramsci durante la prima guerra mondiale 54
III. Gramsci e il Partito Comunista d'Italia 76
SECONDA PARTE 115
I. Gramsci. Korsch, Lukdcs. Paralleli nella difesa del marxismo 117
I. Fine e principio del marxismo.
Hegel, Ricardo e Robespierre come fonti del marxismo 127
III Ricardo filosofo. Traduzione reciproca come
via alla filosofia della prassi implicita in Marx 135
IV. Marxismo come idealismo soggettivo 143
Vv. Gramsci e Bogdanov:
il programma politico dell'dealismo soggettivo 153
VI. La critica alla componente materialistica del marxismo 172
VII. Lenin teorico dell'«egemonia».
L'«egemonia» realizzata nell'Unione Sovietica 193
VIII. L'evoluzione del concetto di «egemonia»
nel quadro del sistema politico-sociale gramsciano 200
IX. Teoria del partito come scienza astratta dell'organizzazione.
L'influsso di Sorel e di Proudhon 217
x. La filosofia di Benedetto Croce
e il "rinnovamento" del marxismo 229
XI. Gramsci, l'Italia e il mondo 240
Bibliografia 251
Nomi citati 259
Prefazione
l libro di Christian Riechers Antonio Gramsci. Marxismus in Italien,
edito nella Repubblica Federale Tedesca nel 1970, ha avuto scarsa eco
nel nostro paese. Îl motivo è abbastanza comprensibile: contribuiva a
demolire il mito del "martire comunista" che Togliatti prima e la cultura
"progressista" nazionale dopo avevano costruito attorno alla figura di
Gramsci.
Due anni dopo l'edizione tedesca, Giacomo Marramao, in un articolo
pubblicato sulla rivista «Quaderni Piacentini» (Per una critica
dell'ideologia di Gramsci, n. 46, marzo 1972) ne mise in rilievo l'im-
portanza per una riflessione teorica che avrebbe dovuto andare al di là
di Gramsci, con la consapevolezza che, se Gramsci era ben chiuso nella
propria epoca, il gramscismo era però in Italia ancora vivo e operante.
Egli sosteneva che la ricerca di Riechers, oltre a costituire l'unica opera
d'insieme sul dirigente comunista italiano esistente nella Germania Fe-
derale, si presentava con un carattere fortemente unitario, ispirato da
una motivazione politica di fondo. L'autore infatti non aveva inteso
compiere una mera ricerca storico-culturale, secondo i criteri neo-acca-
demici della sinistra ufficiale, badando alla sapiente calibratura dei
giudizi, ma aveva posto la necessità di una resa di conti con il pensiero
di Gramsci. Il merito di Riechers consisteva nell'aver sottoposto in
blocco questo pensiero a un vaglio critico evidenziandone i limiti e le
implicite conseguenze negative, sia in riferimento alla discussione eu-
ropea che agli sviluppi successivi del movimento operaio italiano. Se-
condo tale interpretazione la posizione di Gramsci non rappresentava
alcuna rottura qualitativa rispetto all'apparato dottrinario dell'ortodossia
terzinternazionalista, proprio perché ne costituiva una variante tattica.
In particolar modo Riechers colpiva a fondo i miti tenacemente legati
all’immagine di un Gramsci spesso presentato come anti-Togliatti, pre-
cursore della critica allo stalinismo e alla "via italiana al socialismo”
che alcune correnti politiche e storiografiche avevano cominciato a
coltivare già dalla seconda metà degli anni cinquanta. Egli dimostrava
in modo persuasivo come la direzione gramsciana avesse gettato le basi
dell'ideologia togliattiana.
Riechers recuperava alcuni filoni storiografici emersi in Italia negli
anni sessanta, ma soprattutto riprendeva, seppure integrandola con altre
fonti, la critica al gramscismo elaborato dalla sinistra comunista italiana
lungo tutto l'arco della sua esistenza. Per questo motivo il suo lavoro
non ebbe il dovuto rilievo presso i critici sia d'oltralpe che in Italia.
Anche Tito Perlini, nella sua accurata rassegna dei filoni interpreta-
tivi del gramscismo uscita nel 1974 (Gramsci e il gramscismo, Milano,
Celuc), sostenne che il lavoro di Riechers era uno studio «fra i più acuti
in senso assoluto sul pensiero di Gramsci». A suo modo di vedere il
merito di Riechers («e non poteva non essere uno studioso straniero a
farlo dato lo zelante culto apologetico-conformistico che paralizza gli
intellettuali italiani di sinistra di fronte a Gramsci, il quale è diventato
un vero e proprio mito avvolto da uno stucchevole alone agiografico»)
era di aver persuasivamente, «con un discorso chiaro e coerente», che
faceva «sanamente giustizia della mitologia crocio-gramsciana, messo
in luce la profonda estraneità del para-marxismo idealistico di Gramsci
all'ispirazione e alle radice del pensiero marxiano».
Su un versante culturalmente opposto giungerà il parere di Augusto
Del Noce (Il suicidio della rivoluzione, Milano, Rusconi, 1978) se-
condo il quale le tesi del marxismo antigramsciano «hanno trovato la
più rigorosa espressione filosofica in uno dei migliori libri che sul pen-
satore sardo siano stati scritti, quello del marxista tedesco eterodosso
Christian Riechers».
] difensori del lascito gramsciano che avevano pensato di reagire alla
"provocazione” di Riechers erano stati, in verità, molto pochi. In Ger-
mania sul libro si era riversata una critica astiosa di Peter Palla - tradot-
ta sulla rivista «Utopia», n. 7-8, luglio-agosto 1972 - che tuttavia, se-
condo Tito Perlini, mancando di un'efficace argomentazione, aveva
finito per rendere «indirettamente omaggio all'interpretazione» che
voleva demolire. In Italia Franco Fergnani - nello stesso fascicolo della
rivista in cui apparve la traduzione dell'articolo di Palla - era interve-
nuto con una precisazione su Gramsci cercando di respingere la tesi
sull'idealismo di questi. Lo stesso Fergnani tornò sul libro di Riechers
due anni dopo con un articolo su «Aut Aut» - La «questione Gramsci»:
una proposta di riconsiderazione, n. 144, novembre-dicembre 1974 -
sostenendo che l'autore aveva cercato di demolire Gramsci con stru-
menti concettuali provenienti, in parte, da quel filone engelsiano e
leniniano poi ulteriormente dogmatizzato dallo stalinismo.
Non da meno fu Gian Carlo Jocteau: nel suo libro Leggere Gramsci
(Milano, Feltrinelli, 1975) affermò infatti che l'interpretazione di Rie-
chers gli sembrava ininteressante dal punto di vista dell'apertura di
«nuove prospettive alla comprensione storica della figura di Gramsci»
e, in ogni caso «non condivisibile».
La traduzione italiana del testo di Riechers, nel 1975 a Napoli per i
tipi della Thélème, invece di riaprire il dibattito lo chiudeva.
Questa riedizione dell'opera avviene mentre le formazioni politiche
italiane di sinistra stanno ridisegnando le loro strategie. Parte di esse
pensa di rintracciare nel pensiero gramsciano una chiave per superare le
secche del passato e rifondare la politica comunista. Pertanto la rilettura
dell'analisi di Riechers può costituire un contributo importante al di-
battito.
A. Peregalli