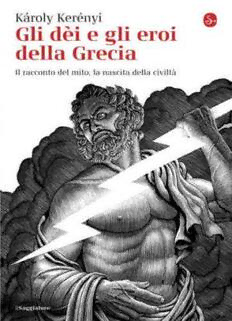Table Of ContentLDB
La Cultura
941
Károly Kerényi
Gli dèi e gli eroi della Grecia
Il racconto del mito,
la nascita della civiltà
Traduzione di Vanda Tedeschi
Sito & eStore – www.ilsaggiatore.com
Twitter – twitter.com/ilSaggiatoreEd
Facebook – www.facebook.com/ilSaggiatore
© 1951, 1958, 1997 Klett-Cotta – J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
© il Saggiatore S.r.l., Milano 2015
Prima edizione: il Saggiatore, Milano 1963
Titolo originale: Die Mythologie der Griechen
(Die Götter-und Menschenheitsgeschichten; Die Heroen-Geschichten)
ISBN 9788865764381
Gli dèi e gli eroi della Grecia
Gli dèi della Grecia
A mia moglie Dildil
Mi ricordo di questa idea che risaliva a non so quale
piacere sensuale e insieme spirituale: come il cervo
inseguito cerca l’acqua in cui precipitarsi, così bramavo
di vivere in questi corpi nudi, lucidi, in queste figure di
Narciso e Proteo, di Perseo e Atteone: desideravo
scomparire in essi ed esprimermi con le loro parole.
HUGO VON HOFMANNSTHAL
Prefazione
Questo volume deve la sua origine alla convinzione che fosse giunto il momento
di scrivere un libro di «mitologia greca», destinato agli adulti; non soltanto agli
specialisti che si occupano di studi classici, di storia delle religioni o di
etnologia; ancor meno ai bambini, per i quali nel passato si adattavano o per lo
meno si selezionavano accuratamente i racconti mitologici secondo i fini e i
criteri di una educazione tradizionale; ma semplicemente agli adulti, qualunque
sia il loro interesse, compreso quello classico, quello storico-religioso ed
etnologico, ma tenendo conto soprattutto dell’interesse puramente umano. Una
forma dell’orientamento umano consona ai nostri tempi è certamente anche quella
psicologica. Secondo quanto ha formulato con felice espressione un autorevole
rappresentante della corrente umanistica moderna «l’interesse mitologico è
proprio così insito nella psicologia, come l’interesse psicologico è insito in ogni
attività poetica».
Sono parole di Thomas Mann, pronunciate nella sua conferenza del 1936 su
Freud e l’avvenire. Valorizzando i meriti dello psicologo, il poeta gettava in
realtà uno sguardo fuori di lui, nel futuro. Con chiarezza insuperabile egli
presentava quella situazione spirituale, dalla quale l’autore attinge la
giustificazione del suo tentativo mitologico. Lo sforzo della «psicologia del
profondo», di risalire all’infanzia della psiche del singolo – riconosce l’autore
del romanzo di Giuseppe – «è nello stesso tempo anche uno sforzo fatto per
penetrare nell’infanzia dell’umanità, nel primitivo, nel mitico. Freud stesso ha
riconosciuto che tutta la scienza naturale, la medicina e la psicoterapia non erano
state per lui che un rigiro, e un ritorno – durato quanto la sua vita – all’originaria
passione della sua giovinezza per ciò che riguarda la storia dell’umanità, le
origini della religione e della morale… Nell’espressione “psicologia del
profondo” la parola “profondo” ha anche un significato temporale: i fondamenti
primordiali dell’animo umano sono pure un tempo primordiale, quella profonda
sorgente dei tempi in cui il mito ha il suo vero ambiente e su cui esso fonda le
norme e le forme elementari della vita. Poiché mito è fondazione di vita; è lo
schema atemporale, la pia formula a cui la vita si adegua, riproducendo i suoi
lineamenti dall’inconscio. Indubbiamente la conquista del modo di vedere tipico
del mito fa epoca nella vita del narratore, essa significa un singolare
potenziamento della sua disposizione artistica, una nuova serenità del conoscere e
del formare, che di solito resta riservata agli anni avanzati della vita; poiché nella
vita dell’umanità il punto di vista mitico rappresenta un grado iniziale e primitivo,
ma nella vita del singolo esso rappresenta invece un grado avanzato e maturo».
Una concezione del mito che non parte dalla «vita» – che è pur sempre uno
soltanto degli aspetti possibili – ma dall’«essere», sarebbe per lo meno altrettanto
giustificata. Ciò però che un grande scrittore ha in tal modo sperimentato su se
stesso quindici anni or sono dovrebbe avere oggi un valore più generale e non
essere legato alla età avanzata.
Così l’autore immagina quegli «adulti» ai quali comincia ad esporre la
mitologia dei Greci in forma di una narrazione collegata, come un classico del
tutto incurante dei posteri e spregiudicato come Aristofane. Egli si augura lettori
maturati alla migliore letteratura dei nostri tempi, lettori cui non riesca troppo
difficile trovare la disposizione che aveva Thomas Mann verso il carattere
arcaicamente massiccio e libero, monotono e ricco di sbalzi di quella
documentazione dell’umano non facilmente superabile quanto a spontaneità, che è
la mitologia greca nel suo insieme; lettori che la possano gustare e, anzi,
riconoscere in essa quella documentazione che deve ancora essere aggiunta ai
classici riconosciuti, per rendere tutto il quadro reale dell’antichità ellenica. Per
documentazione si intende naturalmente la documentazione storica e non
l’interpretazione psicologica della tradizione esposta. Se questa stessa tradizione
viene liberata dalla psicologia superficiale delle trattazioni finora fatte, e
presentata nel suo insieme come materia autonoma con leggi proprie, allora la
mitologia esercita la stessa azione esercitata dalla psicologia più immediata,
proprio come un’attività della psiche favorita dal superindividuale e realizzata in
immagini.
Il «superindividuale» deve essere qui inteso come una definizione minima. Sono
a un dipresso superindividuali – per definitionem – le «figure dell’essere», come