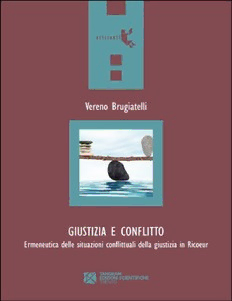Table Of ContentVereno Brugiatelli, Giustizia e conflitto
Copyright © 2013 Tangram Edizioni Scientifiche
Gruppo Editoriale Tangram Srl – Via Verdi, 9/A – 38122 Trento
www.edizioni-tangram.it – [email protected]
Collana “Orizzonti” – NIC 26
Prima edizione: dicembre 2013
ISBN 978-88-6458-105-7 (Print)
ISBN 978-88-6458-963-3 (Epub)
ISBN 978-88-6458-964-0 (mobi)
In copertina: harmony © Constantinos – Fotolia.com
Seguici su Facebook, Twitter, Linkedin
A Catia.
Ringrazio di cuore il prof. Daniele M. Cananzi
per la benevola attenzione a questo mio lavoro.
Sono grato alla Casa editrice e ai numerosi studiosi
che in diversi modi hanno contribuito alla mia ricerca.
I (L )
GIUSTI OS JUSTOS
Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.
Chi è contento che sulla terra esista la musica.
Chi scopre con piacere una etimologia.
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi.
Il ceramista che premedita un colore e una forma.
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.
Un uomo e una donna che leggono le terzine finali di un certo canto.
Chi accarezza un animale addormentato.
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.
(J. L. Borges, La cifra, a cura di D. Porzio, A. Mondadori, 1982, p. 113)
PREFAZIONE
Trattare il tema della giustizia è sempre una impresa e, come tutte le imprese,
espone chi si applica al rischio di trovarsi davanti non a una delle questioni ma
alla questione: enorme, infinita, inesauribile e misteriosa. Del resto, non riduce il
senso dell’impresa concentrare l’attenzione sul percorso esistenziale e filosofico
svolto da Paul Ricoeur; da un lato perché Ricoeur avverte la problematicità della
giustizia come questione esistenziale prima che come tema filosofico e dall’altra
parte perché vive tanto la questione tanto il tema con originalità inusuale,
segnando – come è solito – modi e contatti inediti, direi, per un tema come
questo.
Merita dunque molta attenzione il contributo di Vereno Brugiatelli che
richiama opportunamente l’attenzione sulla giustizia in Paul Ricoeur
rintracciando nel conflitto l’elemento cardine per svolgere la sua ricerca e che
affronta l’impresa portandola a compimento con risultati pregevoli.
Come Brugiatelli nota iniziando il suo percorso, «si parla di giustizia in
molteplici ambiti e settori della vita umana»1 ma Ricoeur offre innanzi tutto una
prospettiva direi rara perché riesce, cosa non facile in ottica soprattutto francese,
a rilevare l’essenzialità e la centralità del diritto, assieme mantenendo
compresenti tutti i molteplici ambiti e settori dell’esistenza appunto. Questa mi
sembra anche una caratteristica della meditazione ricoeuriana sulla giustizia.
Quando, in Le Juste, osserva che il giusto è lo «statuto specifico del giuridico»2
avvia quella differenziazione che porta a una giustizia non limitata nell’amicizia e
che non si esaurisce totalmente nel fenomeno politico. Una giustizia che può
ricomprendere entrambi e che è nell’esistenza proprio perché colta assieme come
istanza e rivendicazione pratica e come questione teoretica, scorta nella sua
qualificazione giuridica. Come scrive lo stesso Ricoeur, nella tradizione filosofica
«il diritto occupa uno spazio permanente, senza dubbio, con la forte convinzione
che esso costituisca un luogo concettuale, normativo e speculativo irriducibile, a
un tempo, al morale e al politico. Al morale, poiché il diritto rappresenta, in
rapporto all’interiorità dell’obbligo, l’esteriorità […] e, di più, presuppone la
legittimità della coercizione […]. Irriducibile al politico, nella misura in cui la
questione della legittimità non si lascia mai assorbire da quella del potere. Il
potere stesso è in cerca di legittimità»3.
Rilevante proprio perché, colmando la «mancanza stupefacente», Ricoeur
indaga il giusto non passando «direttamente dal morale al politico»4 o viceversa
né, come dicevo, astrae dal vissuto e dalla concretezza del quotidiano la
questione.
È nell’indignazione davanti all’ingiusto che «si forma e si educa il desiderio di
giustizia»5 ponendo assieme la questione che si avverte nella concretezza del
momento ma che si ambienta nella dimensione umana, un «cogito integrale»6
attorno al quale Ricoeur non ha mai smesso di lavorare.
Come sottolinea anche Brugiatelli, l’antropologia ricoeuriana si riallaccia a quel
«fondo di essere, a un tempo potente ed effettivo»7 del quale si discute in Soi-
même comme un autre e la giustizia si può cogliere nel momento di corto circuito
tra struttura antropologica che si afferma nel fondo di essere e che viene negata
con l’atto ingiusto.
Andando all’essenziale, si può dire che l’ingiustizia si consuma sempre in questo
corto circuito, ogni volta che viene negato l’essere e la sua libertà, per nominare
termini che hanno un ruolo centrale nella riflessione ricoeuriana, ogni volta che
la libertà pensa di poter negare l’essere.
Ecco come e perché Ricoeur è capace di mantenere unite questione teoretica e
istanza pratica, è capace di mantenere la giustizia contemporaneamente presente
a tutte le sfere che la rendono così molteplice ma sussistente nell’unità che la
qualifica e la attesta in quella molteplicità.
In questi termini coglie bene Brugiatelli quando, introducendo il suo lavoro,
avverte come Ricoeur discute la giustizia assumendola come questione e, come
tale, sempre aperta alla costante interrogazione schiva verso sistematizzazioni o
definizioni.
E proprio in questi termini che pare particolarmente opportuna la scelta di
affiancare giustizia e conflitto, anzi conflitti.
La giustizia, assunta da Brugiatelli come dimensione sociale, è all’insegna del
riconoscimento volta al superamento dei conflitti ma è anche quella modalità per
affrontare i conflitti di senso nascenti dall’incontro tra universale e particolare,
norma e caso.
Su queste due direzioni l’analisi di Brugiatelli riesce con chiarezza mirabile a
discutere quel chi dell’azione che costituisce – come in più occasioni ha rilevato
Jervolino8 – l’unità della riflessione ricoeuriana.
Distese nei quattro capitoli nei quali vengono svolte, queste due linee di ricerca
svelano anche da subito la loro stretta connessione. Brugiatelli, infatti, rintraccia
proprio nella questione del chi? l’elemento centrale per cogliere le tante
sfumature nelle quali trova un senso non banalizzabile il rapporto tra giustizia e
conflitti.
Nel primo capitolo Brugiatelli evidenzia la posizione ricoeuriana attraverso il
confronto con modelli teorici di giustizia come quelli di Rawls e Sen e approcci
al tema come l’aristotelico e l’habermasiano; ne risulta il riconoscimento come
momento e dimensione nel quale la giustizia si fa esperienza e non semplice
teoria. La posizione di Ricoeur viene subito segnata all’insegna di una certa
concretezza contro utopiche modalità di pensare il giusto per astrazione, finendo
così per teorizzare un modo che spesso lascia nella precomprensione il
fenomeno. La costante attenzione per il tragico dell’azione rende la posizione di
Ricoeur da subito orientata verso l’uomo capace, agente e paziente di giustizia.
E al chi dell’azione è dedicato il secondo capitolo nel quale Brugiatelli,
ripercorrendo alcuni dei passaggi più intensi di Sé come un altro, evidenzia
l’identità narrativa alla luce dell’imputazione e della responsabilità. Il giusto,
riferito all’umano, implica una iscrizione e una attestazione di responsabilità che
non cogliere porta a sviare il discorso, misconoscendo la profondità della
giustizia nell’esistenza.
Per questa via è possibile giungere, nel terzo capitolo, a discutere la “piccola
etica” ricoeuriana per quanto può dire in termini di giustizia e violenza, di
universalità e particolarità. E con opportuna attenzione Brugiatelli segue Ricoeur
tanto nella versione verticale del tripode etico (vivere con e per l’altro in
istituzioni giuste) quanto in quella circolare (dall’etica fondamentale alle etiche
regionali). La prudentia acquista così quel valore e quel significato della saggezza
pratica che non si fa contingente e relativistica ma rintraccia le proprie ragioni –
ancora una volta – nell’unità e nell’indivisibilità della persona.
Dato il percorso tracciato, nell’ultimo capitolo Brugiatelli può guardare la
giustizia dal lato dell’amore, seguendo pagine particolarmente intense dell’opera
ricoeuriana. Intense nella misura in cui esprimono quel fondamentale entro cui
si muove la saggezza pratica, intense perché dell’essere umano colto in tutta la
sua umanità, dunque nel fellible e nel capable, rende tutto il «senza assoluto» di
Thévenaz, tanto caro a Ricoeur.
Proprio quest’ultimo tratto dell’analisi consente di scoprire, in fondo, la prima
parola entro la quale si può comprendere bene il senso e il fondamento della
dimensione di giustizia secondo Ricoeur: la gratuità.
Tanto una teoria della giustizia, quanto la soggettività, tanto la socialità quanto
la normatività possono essere disfunzionali, ovvero possono essere concrete ed
effettive e contemporaneamente non abbandonate a semplici rapporti di forza,
quanto si presentino sempre nell’ambito di una gratuità di sottofondo;
l’alternativa è così – nei termini kantiani – quella tra mezzo e fine. Lo sforzo di
Ricoeur, bene rappresentato da Brugiatelli, è quello di “una giustizia che si faccia
sempre più giusta”9, secondo le parole che chiudono il libro.
E questo non è solo un auspicio, ma è una via praticata da Ricoeur uomo e
filosofo del quale Brugiatelli con piana trattazione indica i punti salienti e
centrali.
Posso così tornare alle mie considerazioni iniziali e a una loro parziale
precisazione e chiarificazione.
Quella ricoeuriana è una modalità particolarmente sofisticata di intendere la
giustizia; innanzi tutto perché non la categorizza e non la frammenta ma ne
mantiene l’unitarietà, e l’unitarietà della giustizia è colta nella sintetica struttura
ontologica misteriosa, direi con Marcel, per la quale l’essere umano è sempre in
cammino e nel suo cammino rimane quell’essere «già posto nell’essere» che
costantemente iscrive nuovo senso al proprio essere mediante l’esercizio della
libertà. Questione che merita una breve riflessione.
Ricoeur afferma che «Il punto di partenza […] non può non trovarsi nella
nozione di libertà. Ma se la libertà si pone, essa non si possiede […]. Direi che la
libertà non può attestarsi che nelle opere ove essa si oggettiva» tanto che «Io non
posso vedere la mia libertà, nemmeno posso provare che io sono libero: posso
solo pormi e credermi libero» […] «come può realizzarsi una libertà che non si
possiede per se stessa, che può quindi manifestarsi solo attraverso il lungo rigiro
del suo fare?»10.
A me sembra che si possa dire della giustizia in termini analoghi; perché la
giustizia non si può possedere ma si può solo fare esperienza di giustizia (o di
ingiustizia) e di qui allora anche per la giustizia vale la domanda: come può
realizzarsi una giustizia che non si possiede ma che si può solo esercitare, in
termini più corretti, amministrare? E ancora, cosa significa amministrare la
giustizia e cosa esercitare la libertà?