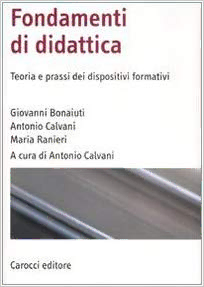Table Of ContentI lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:
Carocci editore
Corso Vittorio Emanuele II, 229
00186 Roma
tel. 06 42 818417
fax 06 42 74 79 31
Siamo su:
www.carocci.it
www.facebook.com/caroccieditore
www.twitter.com/caroccieditore
Giovanni Bonaiuti Antonio Calvani Maria Ranieri
Fondamenti di didattica
Teoria e prassi dei dispositivi formativi
Nuova edizione
A cura di Antonio Calvani
Carocci editore
Il volume è sottoposto a doppio referaggio anonimo.
3a ristampa, febbraio 2017
2a edizione, gennaio 2016
1a edizione, giugno 2007 (8 ristampe)
© copyright 2016 by Carocci editore S.p.A., Roma
Realizzazione editoriale: Fregi e Maiuscole, Torino
Finito di stampare nel febbraio 2017
da Grafiche VD srl. Città di Castello (PG)
isbn 978-88-430-7784-7
Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia,
anche per uso interno
0 didattico.
Indice
Premessa alla seconda edizione 9
Introduzione 11
1. Cornice storica e teorica 17
I. Origine e sviluppo dell’idea di didattica 18
2. Il primo Novecento 20
3. Sviluppi recenti: il contesto internazionale 21
4. Ricerca didattica in Europa e in Italia 32
In questo capitolo 40
2. La dimensione metodologico-decisionale 43
I. La progettazione educativa 43
1.1. Modelli di progettazionc didattica /1.2. Dispositivi relativi alle finalità del progetto /
1.3. Dispositivi di valutazione
2. Le conoscenze che aiutano a decidere 59
2.1. Architetture dell’istruzione / 2.2. Strategie e/o metodi / 2.3 Conoscenze evidence-
based
In questo capitolo 76
3. La dimensione attuativa e negoziale 79
1. I formati della comunicazione 80
1.1. La comunicazione faccia a faccia / 1.2. La comunicazione testuale e multimediale /
1.3. La comunicazione mediata dal computer
2. L’interazione didattica nelle sue componenti simboliche, cognitive ed
epistemologiche 92
2.1. Spazi simbolici, pratiche discorsive e processi cognitivi / 2.2. Autoefficacia, motiva
zione, autoregolazione / 2.3. La trasposizione didattica e la negoziazione dei contenuti
3. Il management: aspetti, problemi e strategie 102
3.1. Gestione dei tempi, degli spazi e delle attività / 3.2. Gestione della condotta /
3.3. Gestione delle relazioni interpersonali e sociali
In questo capitolo 112
4. Gli ambiti della didattica 113
1. Didattica scolastica 116
2. Didattica universitaria 123
7
3- Didattica nella formazione professionale e continua 125
4. Didattica extrascolastica 128
5. Didattica nei contesti dell’educazione degli adulti 129
6. Didattica tecnologica 131
7. Didattica speciale 136
8. Didattica interculturale 140
In questo capitolo 141
5. La dimensione metodologico-conoscitiva 145
I. Il circuito azione-riflessione (e le buone pratiche) 145
2. Conoscenze acquisite sul campo: la metodologia 147
2.1. Soggettività dell’osservatore / 2.2. Metodi quantitativi / 2.3. Metodi qualitativi /
2.4. Metodi misti / 2.5. Qualità della ricerca
3. Conoscenze “di secondo livello”: protocolli di analisi e criteri di valida-
zione 158
3.1. II concetto di evidenza / 3.2. Le sintesi della ricerca: vantaggi e criticità / 3.3. Le
systematic reviews
4. Risorse e strumenti digitali per la ricerca didattica 164
4.1. Risorse bibliografiche e banche dati specializzate / 4.2. Repertori e banche dati
online per l’accesso a riviste nazionali e internazionali / 4.3. Cataloghi ebe (Evidence-
Based Education) / 4.4. Social network accademici
In questo capitolo 169
Glossario 171
Questionario 195
Bibliografia 199
8
P r e m e s s a a l l a s e c o n d a e d i z i o n e
Otto anni, questo è il tempo che separa la presente edizione dalla precedente,
non sono molti in rapporto alle problematiche fondamentali con le quali la
didattica si confronta. Sono però un lasso di tempo considerevole, se si os
servano i rilevanti cambiamenti che in questo periodo sono subentrati nella
società e nella ricerca scientifica e che coinvolgono conseguentemente anche
le scienze dell’educazione e la didattica.
Sul piano della ricerca si stanno intensamente affermando nuove modalità
di comparazione di dati su larga scala che consentono ormai di fare il punto
suH’efficacia di sistemi scolastici, scuole e metodologie (Evidence-Based Edu
cation, ebe); da tutto ciò provengono nuove acquisizioni che è opportuno
siano conosciute da chi si occupa di didattica. Allo stesso tempo lo sviluppo
dei motori di ricerca e dei repository su Internet consente di accedere sempre
più a una quantità di documentazione, anche visiva - si consideri la diffu
sione crescente dei video educativi - che permette, da un lato, di selezionare
modelli riconosciuti come più affidabili, dall’altro, di esemplificarli. Paralle
lamente in questi anni il sistema scolastico italiano ha ricevuto dalle politiche
internazionali ulteriori sollecitazioni ad affrontare una revisione a favore di
una maggiore trasparenza per quanto riguarda i processi valutativi, e a rio
rientare le sue finalità in termini di competenze. E' infine sotto gli occhi di
tutti come le tecnologie abbiano assunto un nuovo volto con l’affermarsi del
web 2.0 e degli ambienti di social networking, condizionando in modo sem
pre più pervasivo la vita di ogni giorno, con particolare impatto sulle nuove
generazioni (i nativi digitali). Cambiamenti di questa natura hanno indotto
gli autori a compiere un aggiornamento della precedente edizione. È stata
l’occasione per rendere il testo più adatto anche per studenti ai primi anni dei
corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.
ANTONIO CALVANI
9
Introduzione
La realtà prende forma attraverso molteplici mediazioni; l’uomo definisce
sé stesso e il proprio mondo attraverso un gioco di stipulazioni, immerso
in una dinamica oscillante di significati più o meno stabilmente condivisi o
sottoposti a successive negoziazioni. In senso figurato pratiche sociali, riti,
cerimonie, liturgie, rituali, protocolli, feste, istituzioni giudiziarie, politiche,
militari, culturali (in particolare la scuola) possono essere considerati spazi
di mediazione simbolica, cioè luoghi in cui avviene la messa in comune di
oggetti, gesti, comportamenti, pensieri che simboleggiano il modo di vivere
proprio dei membri di una collettività (Berger, 199a).
La didattica concerne una di queste attività di mediazione, forse la più rile
vante perché è volta alla riproduzione e all’ampliamento del sapere che una
società ha acquisito e deve trasmettere alle nuove generazioni.
La didattica esplica il proprio valore simbolico all’interno di istituzioni for
mative, cioè di strutture predisposte a favorire questa trasmissione attraverso
l’interazione tra soggetti, norme, supporti materiali e strumentali. Le istitu
zioni si collocano a loro volta all’interno di più ampi contesti sociali (scuola,
extrascuola, università, inserimento professionale, disabilità, intercultura,
mondo degli adulti).
Nel linguaggio comune la didattica è solitamente identificata con il comples
so di teorie e pratiche connesse all’insegnamento nel contesto istituzionale
della scuola. Questa è tuttavia un’accezione limitativa. Nella società attuale
la didattica ha subito rilevanti riconfigurazioni. Nella sua accezione tradizio
nale (didattica scolastica), possiamo individuare una struttura con quattro
componenti costitutive: un soggetto erogatore/amministratore della cono
scenza (insegnante, esperto); un soggetto acquisitore della conoscenza (no
vizio, allievo, studente); una conoscenza oggetto di acquisizione; un’attività
di trasposizione/negoziazione che mette in rapporto le tre componenti in
dicate. Normalmente la conoscenza è posseduta e gestita in gran parte dal
soggetto erogatore (insegnante); il setting in cui le azioni si svolgono è uno
spazio chiuso (aula scolastica).
Rispetto a questa rappresentazione tuttora molto diffusa, nel corso degli ulti
mi decenni si sono verificati significativi cambiamenti nell’ampliamento dei
11
Fondamenti di didattica
campi, nell’articolazione dei ruoli, nelle modalità di gestione e trasmissione
delle conoscenze. La didattica sta ormai conquistando ambiti diversi dalla
scuola; richieste di natura didattica sono oggi avanzate da enti locali, associa
zioni culturali, aziende, editori, strutture sanitarie. Si ha una dilatazione dei
campi della didattica, in particolare nell’ottica di una formazione destinata
ad accompagnare per tutto l’arco della vita.
Le fasi essenziali dell’agire didattico, tradizionalmente compresenti nei
medesimi soggetti e attuate in spazi e tempi condivisi, possono invece tro
varsi separate, mentre i ruoli possono essere riconfìgurati e la gestione della
conoscenza assumere un carattere distribuito. Consideriamo un’attività di
didattica sul web in cui gli allievi sono adulti in formazione: l’aula non è
quella fisica, è un’entità virtuale, la conoscenza non è necessariamente posse
duta (almeno interamente) dal soggetto erogatore, ma può essere distribuita
in una molteplicità di risorse o dispositivi (archivi, siti, software, ma anche
esperti di vario livello, consultabili a distanza), una fonte di apprendimento*
può essere la conoscenza stessa proveniente dalla collaborazione tra allievi e
il ruolo del docente (amministratore), non a caso ridefinito come tutor, sarà
piuttosto quello di un facilitatore o di un orientatore di percorso.
In parallelo abbiamo assistito a una progressiva conquista di autonomia della
didattica, che si è progressivamente svincolata dalle dipendenze nei riguardi
della filosofia da un lato, della psicologia dall’altro, per assumere i connotati
di un ambito scientifico con metodologie sue proprie; accanto dunque a una
prassi didattica ha preso spazio una didattica come ambito di ricerca, il cui
scopo è di migliorare la prima, vuoi coadiuvando l’individuazione di vali
di obiettivi, vuoi suggerendo percorsi e metodologie più efficaci per il loro
conseguimento (nel linguaggio internazionale Instructional Design, Instruc
tional Science).
In generale oggi si chiede alla didattica una maggiore esplicitezza e trasparen
za sulle metodologie impiegate, sulla validazione dei risultati, oltre che una
più ampia condivisione e visibilità dei processi e dei prodotti all’interno delle
comunità dei professionisti del settore.
Questo lavoro si propone di fornire un quadro sintetico delle diverse tipolo
gie di conoscenza che allo stato attuale concorrono a caratterizzare la didatti
ca come settore di ricerca e a delimitare l’expertise in questo ambito.
La didattica viene considerata come la disciplina che si occupa secondo mo
dalità scientifiche delle azioni progettuali, attuative, valutative e negoziativo-
simboliche idonee a favorire processi di apprendimento di migliore qualità.
Diverse dimensioni contribuiscono a costituire l’expertise che questo ambito
richiede; per necessità espositiva sono state qui ricondotte a cinque, a ciascu
na delle quali corrisponde un capitolo: quella storica, quella metodologico-
decisionale, quella comunicativa e negoziale, quella degli ambiti applicativi,
quella metodologico-conoscitiva.
La struttura del volume è la seguente.
12
Introduzione
Nel capitolo I (Cornice storica e teorica) vengono tratteggiati i principali ap
porti che nel corso dei secoli hanno permesso lo strutturarsi della didattica
come ambito di ricerca dotato di un proprio statuto epistemologico e di uno
specifico apparato teorico. Si mettono in particolare a fuoco le cornici cultu
rali e i paradigmi emersi dal secondo dopoguerra a oggi.
Nel capitolo 2 (La dimensione metodologico-decisionale) ci si chiede quali mo
delli teorici e/o dispositivi procedurali la ricerca sia attualmente in grado di
fornire al decisore (formatore o insegnante) per migliorare la qualità dell’a
zione didattica. Il capitolo è diviso in due parti: la prima riguarda la cono
scenza dell’attività progettuale (fasi, obiettivi, valutazione di un progetto), la
seconda è relativa ai descrittori che presiedono alla decisione didattica (mo
delli d’istruzione, architetture e strategie didattiche) e alle risultanze dispo
nibili circa l’efficacia delle specifiche azioni e strategie didattiche in un’ottica
evidence-based.
Nel capitolo 3 (La dimensione attuativa e negoziale) ci si chiede che cosa si
conosca circa la “didattica viva”, cioè i momenti di interazione reale tra un
educatore o insegnante e i suoi allievi, declinandola nelle sue diverse conno
tazioni comunicativa, cognitiva e gestionale.
Nel capitolo 4 ( Gli ambiti della didattica) vengono introdotti i diversi ambiti
in cui la didattica, al di là di quello che tradizionalmente l’ha caratterizza
ta, la scuola, è andata acquisendo rilevanza nel corso degli ultimi decenni:
didattica universitaria, didattica nella formazione professionale e continua,
extrascolastica, lifelong learning, didattica tecnologica, didattica speciale e
interculturale.
Nel capitolo 5 (La dimensione metodologico-conoscitiva) ci si chiede in che
modo si produca il sapere didattico e si possa attribuire a esso affidabilità.
Vengono distinte le modalità di acquisizione della conoscenze: per esperien
za personale, attraverso indagini empiriche (metodi quantitativi e qualitati
vi), attraverso analisi e comparazione sistematica delle conoscenze già note
(Evidence-Based Education, metanalisi, systematic review)
Nella pagina seguente è riportata una mappa concettuale di sintesi dell’intero vo
lume.
1. Il lavoro è stato concepito collaborativamente. Giovanni Bonaiuti è autore del capitolo 4, dei
paragrafi 1 e 2 del capitolo 1 e delle schede indicate con la sigla GB. Maria Ranieri è autrice del
capitolo 3, del paragrafo 4 del capitolo 1, dei paragrafi 2.5, 3.2, 3.3 e 4 del capitolo 5 e delle schede
indicate con la sigla MR. Antonio Galvani è autore dei capitoli 1 e 2, delle parti residue del capitolo
5 e delle schede indicate con la sigla AC. Nel Glossario sono riportate le parole segnate con un
asterisco all’interno del volume.
13
Fondamenti di didattica
Si articola in
Si pone Si pone Si pone
la domanda la domanda la domanda
Come possiamo
descrivere l’interazione
docente (formatore)
e alunno?
a cui risponde a cui risponde a cui risponde
distinguendo distinguendo distinguendo