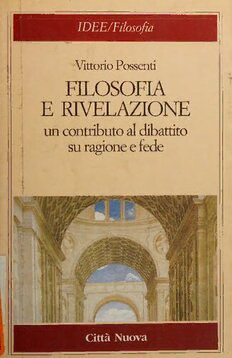Table Of ContentIDEE/Filosofia
Vittorio Possenti
FILOSOFIA
BERIVELAZIONE
un contributo al dibattito
su ragione e fede
Città Nuova
Vittorio Possenti
FILOSOFIA E RIVELAZIONE
Il clima spirituale postmoderno,
con le incertezze e il nichilismo che
lo angustiano e la domanda di senso
che lo percorre, domanda una rivi-
sitazione dei temi che riguardano da
vicino ogni uomo: filosofia e Rivela-
zione, ragione, metafisica, sapienza,
fede. Il “discorso breve” del volu-
me nasce come pensiero pro-vocato
dall’enciclica Fides et ratio. La forza
della ragione può entrare nella com-
prensione della fede senza adulte-
rarla, e l'energia della fede che nasce
dalla Rivelazione può abitare nella
ragione senza rischio, dischiuden-
dole orizzonti nuovi. È il grande
incontro fra pensiero umano e mes-
saggio biblico con le sue specifiche
difficoltà nel moderno. Approfon-
dendo la memoria delle sorgenti, la
ragione postmoderna può riprende-
re contatto con l’essere e la Rivela-
zione, e la filosofia valere come prae-
paratio evangelica se, oltrepassando
il nichilismo, saprà porsi come ragio-
ne magnanima, aperta alla comples-
sità e ai chiaroscuri dell’esistenza
umana, amica di tutto ciò che esiste.
IDEE / filosofia
FILOSOFIA E RIVELAZIONE
e
Digitized by the Internet Archive
in 20283 with funding from
Kahle/Austin Foundation
https://archive.org/details/filosofiaerivela0000poss
Vittorio Possenti
FIROSOELÀ EsRIVELAZIONE
un contributo al dibattito
su ragione e fede
Città Nuova
Il libro è pubblicato con il contributo
del Dipartimento di Filosofia 0
dell’Università degli Studi di Venezia.
In copertina: Raffaello, Scuola d’Atene (part.).
Stanza della Segnatura - Vaticano.
Grafica di Gyòrgy Szokoly
© 1999, Città Nuova Editrice
Via degli Scipioni 265 - 00192 Roma
ISBN 88-311-0123-4
Finito di stampare nel mese di maggio 1999
dalla tipografia Città Nuova della PA.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17
00165 Roma - tel. 06-5813475/82
INTRODUZIONE
Oltre alla cattolicità o universalità della Rivelazione che
proviene dalla Trascendenza e verso cui si rivolge la fede, vi è
una “cattolicità” o universalità naturale della ragione: di una
ragione aperta, flessibile, magnanima, compassionevole, amica
di tutto quanto esiste e in specie del volto dell’altro. Una ra-
gione di questa forma può aiutare la cultura postmoderna a
superare la sua insicurezza e la tentazione di accontentarsi di
poco, con il rischio di andare quasi alla deriva in un’epoca
enigmatica e incerta.
Della fede e della ragione, della loro specifica “cattoli-
cità”, ha trattato l’enciclica Fides et ratio, forse il più impor-
tante documento della Chiesa moderna sul tema espresso nel
titolo e sulla filosofia, intesa come lo specchio in cui si riflette
la cultura dei popoli. Il suo nucleo centrale si individua nella
giusta relazione da instaurare fra la verità rivelata e la verità
raggiunta dal sapere filosofico. Il testo che segue pensa con li-
bertà entro uno spazio che approssimativamente è quello scan-
dito dall’enciclica, sebbene vari suoi temi verranno lasciati nel-
lo sfondo. Nascendo come pensiero pro-vocato da essa e che
ad essa reagisce, depone ogni intento di operarne una esegesi:
non è questo il nostro intento, quanto di interrogare e di ri-
flettere sul nesso fra filosofia e Rivelazione, senza escludere in
via preliminare le intuizioni dell’enciclica in merito !.
1 Ad alcuni mesi di distanza dall’uscita dell’enciclica prende corpo l’im-
pressione, certo provvisoria e rivedibile, che la sua recezione nella cultura sia sta-
6 Introduzione
Fides et ratio intende rimettere in moto il pensiero cre-
dente (che è cosa diversa dal credente che pensa) e la questio-
ne della verità, aprendo un più alto dialogo con la tarda mo-
dernità e il postmoderno, «prima che il filo d’argento s’allenti,
la lampada d’oro s’infranga, si rompa la secchia alla fonte»
(Oo 12, 6). Fra i diversi stimoli che il testo propone per riav-
viare il pensiero credente, significativo si presenta il metodo
della reciproca collaborazione e della circolarità fra ragione e
fede, filosofia e teologia, da cui entrambe escono arricchite.
Desidereremmo entrare nello stesso cammino, evitando il la-
mento; piuttosto cercando il positivo e il vero, e operando per-
ché l’eros filosofico che vive in ogni uomo possa liberarsi in
una ricerca ad un tempo ontosofica e contemplativa. Contem-
plativa qui significa: con spirito aperto al tutto e disposto a
mantenere fermo sulle cose lo sguardo dell’intelletto. Ricerca
ontosofica vuol dire: desiderosa di raggiungere una sapienza
dell’essere, che sia il suo “sapore originario”.
I nuclei del nostro “discorso breve” si dispiegano intorno
ad alcune parole-guida: filosofia, Rivelazione, verità, fede,
ragione, metafisica, sapienza, che nella loro pluralità attestano
eterogeneità, dislivelli, diversità, non però reciproca inimicizia.
Il clima spirituale del presente sembra chiedere una rivisitazio-
ne di questi temi che riguardano da vicino ogni uomo in rap-
ta per ora modesta e talvolta preconcetta. I principali quotidiani italiani al mo-
mento dell’uscita del testo se la sono sbrigata con qualche articolo estemporaneo
e interviste ad accademici che hanno dichiarato di non averne conoscenza e di
non aspettarsi a priori nulla da esso. Quando vi è stata una considerazione meno
estemporanea come nel caso di «Micromega» (n. 5, 1998), taluni interventi ospi-
tati hanno dato l'impressione di voler colpire piuttosto che comprendere. In
qualche caso alquanto raro (penso qui ad es. all'articolo di E. Scalfari su «la Re-
pubblica» del 18 ottobre 1998), si è colto che il testo ruota intorno al tema della
veritàe d ella conoscenza, e che il pontefice ha ragione almeno su un punto: non
si può vivere senza un senso. Fra le numerose conferenze e tavole rotonde sul:
l’enciclica, si avverte finora la mancanza di convegni di approfondimento: uno
dei È rari inC mRer ito si svolse presso l’Università di Padova ova iil l 1 1° di
valido esito di interventi e di pubblico. cembre 1998 con
Introduzione 7
porto alla posta esistenziale in gioco. Sino ad un recente passa-
to il giudizio secondo cui «la realtà di un mondo senza Dio, di
fronte al quale ci troviamo, è in parte solo la reazione a un Dio
senza mondo» 2, poteva reclamare qualche fondamento. Inol-
trandoci nel postmoderno, una separazione del genere potreb-
be apparire sempre più problematica.
Il saggio si muove in prevalenza intorno alla filosofia,
poiché chi scrive è filosofo, senza però dimenticare che la fe-
de, come la ragione, è un’energia conoscitiva, non solo pietà
ed obbedienza, come invece a partire da Spinoza ha inteso la
critica del cristianesimo e della Rivelazione. Il nostro tema è la
filosofia in se stessa e nel suo rapporto con la fede che cerca la
propria autocomprensione (fides quaerens intellectum): l’ener-
gia della ragione può entrare nella comprensione della fede
senza adulterarla, mentre l’energia della fede che nasce dalla
Rivelazione può abitare nel cuore della ragione senza violenza
e rischio per quest’ultima. Anzi, può dischiuderle orizzonti
nuovi e darle qualcosa di grande. Sovviene qui un passo del li-
bro di Tobia, uno dei più deliziosi della Bibbia (cf. il cap. 6).
La fede può essere per la filosofia qualcosa di analogo a quan-
to operò nel viaggio di Tobia l'Arcangelo Raffaele: egli guidò
nel cammino, neutralizzò i mostri marini, preparò un collirio
per gli occhi, affinché fossero difesi da malattie e vedessero
meglio. Incontrando la filosofia, la Rivelazione la provoca ad
essere se stessa e a raggiungere la pienezza. Affinché questo
accada, occorre superare il principio di immanenza, uno dei
massimi retaggi del razionalismo, che in varie fasi della moder-
nità è stato il cardine attorno a cui si sono disposte le princi-
pali obiezioni nei confronti della possibilità stessa della Rivela-
zione. Il criterio di immanenza toglie alla radice qualsiasi dia-
logo fra uomo e Rivelazione: sopprimendo la seconda, tesse
l’elogio di una ragione potentissima e solitaria.
2 W. Kasper, Fede e storia, Queriniana, Brescia 1975, p. 160.
8 Introduzione
È un'esigenza notevole che il rapporto fra filosofia e Ri-
velazione, fra ragione e fede debba oggi venir nuovamente me-
ditato in rapporto ai nuovi orizzonti spirituali del postmoder-
no, alle incertezze che lo angustiano, alla domanda di senso
che lo percorre.