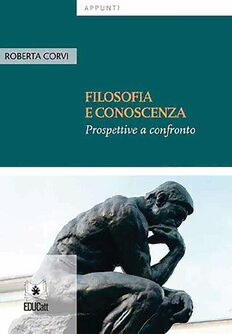Table Of ContentAPPUNTI
EOOCatt
Sommario
Introduzione. Il ruolo della filosofa nel mondo contemporaneo .................. 5
CAPffOLO PRIMO
La filosofia come problema ............................................................................ 19
1.1 La fìlosofia come comprensione della totalità ................................... 19
1.2 La fìlosofia come concetto problematico. .......................................... 22
1.3 Inevitabilità e insufficienza della fìlosofia .......................................... 27
CAPffOLO SECONDO
Le soluzioni"r iduzioniste • .............................................................................3 1
2.1 La fìlosofia come terapia. ....................................................................... 32
2.2 La fìlosofia come "regina delle scienze• .............................................. 36
2.3 Per una fìlosofia scientifica ...................................................................4 0
2.4 La fìlosofia come conversazione ......................................................... .43
CAPffOLO TERZO
Le soluzionisistematiche. ...............................................................................5 1
3.1 La fìlosofia come scienza rigorosa. ....................................................... 52
3.2 Pensiero sistematico e pensiero problematico ................................. .56
3.3 La fìlosofìa senza progresso ................................................................... 59
CAPffOLO QUARTO
La funzione critica (ma non solo) della fìlosofìa. ....................................... 65
4.1 La fìlosofia come discussione razionale .............................................. 66
4.2 La fìlosofia è una «gaia scienza»? .......................................................6 9
3
FILOSOFIA E CONOSCEN'lA
CAPITOLO QUINTO
La filosofìa è anacronistica? ...........................................................................7 5
5.1 La filosofia come grammatica del pensiero ........................................7 6
5.2 La concezione euristica della filosofìa. ................................................ 80
CAPITOLO SESTO
Il signifìcato della filosofìa oggi ..................................................................... 85
6.1 La filosofia come esigenza di verità ..................................................... 86
6.2 La filosofìa come risposta alla" meraviglia• ........................................ 90
CAPITOLO SlffrlMO
Filosofìa e storia della fìlosofìa ...................................................................... 95
APPENDICE
La filosofìa del Novecento: "scienza rigorosa• o genere letterario?. .... 1 O1
Bibliografia ..................................................................................................... 123
4
INTRODUZIONE
Il ruolo della filosofia nel mondo contemporaneo
Il pensiero del Novecento ha posto un nuovo problema accanto a
quelli di cui tradizionalmente si occupa la fìlosofìa, vale a dire la fìlosofìa
stessa, che avverte come problema la sua stessa esistenza nel momento in
cui le scienze sembrano esaurire il dominio del sapere, riducendo la fìlo
sofìa a retaggio di un tempo in cui le scienze non erano ancora sufficien
temente sviluppate.
Contestando un documento fìrmato da pensatori molto noti e in
fluenti, come Gadamer, Derrida, Ricocur, Rorty e Putnam, che defìni
vano la fìlosofìa come «un elisir di vita eternamente efficace», Feyera
bcnd in uno scritto del 1994 sostenne che in verità si tratta di «una po
zione di streghe, i cui ingredienti sono spesso mortali. Non pochi degli
attacchi portati alla vita, alla libertà e alla felicità hanno avuto un fortis
simo sostegno fìlosofìco» 1 Rincarando la dose, il teorico dell'a nar
•
chismo metodologico afferma che «paragonato alla poesia e al senso
comune, il discorso fìlosofìco è sterile, privo di sensibilità. È tetragono
nei confronti dei legami emozionali e dei mutamenti che tengono vivi
gli esseri umani»2 Prima di Socrate si educava alla virtù senza insegnan
•
ti, semplicemente vivendo una tradizione, Socrate, invece, ha soppianta
to la tradizione con i concetti, che devono essere chiari e rigorosi, ma
non hanno la flessibilità e la multilateralità delle virtù tradizionali, anzi
1 P.K. Feyerabcnd, Conl(USI ofA bund,uue, University of Chicago Press, 1999; 1r.ir. L.,
conquista dell'abbondanza. Conin3, Mibno 2002, p. 331.
2 P.K. Feycrabcnd, L.tconquisra dell'abbondanza, p. 332.
5
~ILOSOFIAE CONOSCENZA
hanno la pretesa di incasellare le virtù, rendendole oggettive e avulse dal
contesto in cui si praticano, mentre non possono essere separate dalle
circostanze in cui sorgono, dalle emozioni e dai desideri'.
A fronte di accuse cosl dirette occorre indagare se esista una efficace
strategia di difesa che restituisca alla filosofia non solo una giustificazio
ne d'ufficio, ma le restituisca una funzione riconosciuta. Molti filosofi -
di orientamento e temperamento diversi - se ne sono occupati, sottoli
neando vari aspetti del problema e abbozzando soluzioni talora simili e
talaltra divergenti. In questo volume vengono esaminate, senza alcuna
pretesa di esaustività, alcune delle principali riflessioni sulla filosofia rin
tracciabili nel pensiero del Novecento.
Nel primo capitolo sono presentati tre modi diversi di impostare il
problema, ma unanimi nel ritenere che la definizione di filosofia sia un
problema filosofico.
Georg Simmcl riconosce come peculiarità della filosofia proprio il
dubbio che "col suo nome si copra solo un irreale fantasma dubbio
n -
che deriva dal modo in cui tipicamente procede la filosofia, dalla sua
tendenza a pensare senza presupposti. Si tratta ovviamente di un obiet
tivo irraggiungibile, ma non per questo meno degno di essere persegui
to, anzi proprio perché sappiamo che è irraggiungibile, dobbiamo sfor
zarci di avvicinarci il più possibile. Procedendo in questa direzione la
filosofia "ricerca e scopre i presupposti del conoscere, anche del cono
n,.
scere filosofico stesso
Analogamente Cassirer ripropone il problema: «nella gamma sva
riatissima delle questioni filosofiche particolari, nella loro illimitata ab
bondanza e nelle loro innumeri differenziazioni, la filosofia sembra in
ultima istanza tornare sempre di nuovo alla questione principale ed ori-
'Cfr. P.K. Feycrabcnd,La,imquirra del/abbondanza, pp. 332-334.
◄ G. Simmel, Die Hauptprobkmeder Philosophie(l910}, rr.ic. / probkmifandamenrali
della jìloStJfo,. SE, Milano 2009, pp. 35-36.
6
IL RUOLO DEIJ.A FILOSOFIA NELMONDOCOt,ffF.MPORANEO
e,
ginaria: che cosa e che cosa vuole, la filosofia?»s. L'oggetto della filoso
fia non è semplice e definito come quello delle singole scienze, tuttavia,
secondo Cassirer proprio la nascita della scienza moderna prima e lo svi
luppo non solo della fisica, ma anche delle scienze della vita e delle
scienze umane poi hanno fornito nuovi argomenti di riflessione alla fi
losofia, «hanno fatto sorgere una moltitudine di compiti nuovi, cui la
filosofia non può sottrarsi se vuole restare fedele al proprio nome e alla
propria vocazione»6
•
Karl Jaspers sembra invece decisamente pessimista per quanto ri
guarda l'identità della filosofia, soggetta com'è a valutazioni disparate,
considerata da alcuni priva di valore e di contenuto, mentre da altri è
apprezzata per la sua complessità e profondità.
Mentre le scienze, ciascuna nel proprio campo, hanno raggiunto cono
scenze rigorosamente certe e universalmente riconosciute, la fìlosofia
non è In grado di offrire nulla di analogo, pur nel suo secolare travaglio.
È ìmpossibile nasconderlo: nella fìlosofia non esiste unanimità alcuna
In fatto di risultati fuori di dubbio7•
Egli conclude che la filosofia non può giustificarsi, ma «può soltan
to offrirsi alla comunicazione»•.
Altri invece hanno cercato di offrire soluzioni al problema relativo
alla definizione e alla natura della filosofia stessa, optando o per una
prospettiva riduzionista o per una concezione -sistematica". Il secondo
capitolo rimanda alle posizioni che hanno attribuito alla filosofia un
ruolo ancillare rispetto alla scienza o l'hanno ridotta a genere letterario,
s E. Cassircr, Der &griffd er Phi/Qsophk ais Probkm der Phi/osophie ( 1935). tr. it.11 <on
uno dif ilosofo, rome problema filosofao, in E. Cassircr, Simbolo, miM e cukura, L:uerza,
Roma-Bari 1987, p. 59. Si tratta della prolwionc tenuta da Cassircr all'università di Go
teborg all'inizio del suo insegnamento nell'ottobre del 1935.
6 E. Cassircr, // ,onWM dif ilosofo, <ome problema filosofao, cit., p. 65.
7 K. Jaspers, Ein.fùhrung in die Philosophk ( 1950), tr. it. Introduzione alJ4 filosofo,, Cor
tina, MUano2010, p. I.
• K. Jaspcrs,/nrroduzione "°4f ilosofo,, cit., p. 9.
7
FILOSOFIA E CONOSCENZA
ridimensionando in ogni caso la portata cognitiva della filosofia come
tale, arrivando talvolta a negarla del tutto.
Come è noto, Wittgenstein nel Tractatus afferma che «scopo della
filosofia è la chiarificazione logica dei pensieri. La filosofia non è una
dottrina, ma un'attività»'. Questa attività si svolge al servizio della
scienza, come egli stesso precisa più avanti: «la filosofia limita il campo
disputabile della scienza naturale» '0 Pur nel cambiamento di prospetti•
•
va che si realizza nelle Ricerche filasofiche., la funzione della filosofia resta
analoga, nonostante il diverso contesto: l'attività della filosofia si esten
de a tutto il linguaggio e non è più limitata al solo ambito scientifico,
ma ha unicamente una finalità terapeutica che mira alla dissoluzione dei
problemi filosofici stessi: «i problemi filosofici devono svanire compk
tamente. ( ... ] Non c'è un metodo della filosofia, maci sono metodi; per
così dire, differenti terapie» 11
•
Sulla scia del primo Wittgenstein anche gli esponenti del positivi
smo logico ritengono che la filosofia sopravviva nelle scienze come atti
vità che chiarisce il significato dei concetti utilizzati e, se ancora sussi
stono aree in cui la filosofia è autonoma, come l'etica o l'estetica, «ciò
significa che esse non dispongono di concetti fondamentali sufficiente
mente chiari e che i loro sforzi sono ancora prevalentemente diretti a
determinare il senso delle loro proposizioni»12 Infine, in epoca più re
•
cente, Rorty ha ritenuto superata la concezione tradizionale della filoso
fia Msistematica• che costituisce una forma di conoscenza, optando per
9 L. Wittgenstein, Tra<TAJUS /ogicq.phil,,wphicus (1921), 1r. il. Einaudi, Torino 1974, §
4.112, p. 27.
10 L. Wittgenstein, Tra<TAJUS/ogicq.phil,,wphicus, cii., §4.113, p. 28.
11 L. Wittgens1ein, Phil,,sophiKhe UntmiMhungen (1953), 1r. it. Ricmhefowfohe, Ei
naudi, Torino 1974, § 133, p. 71.
12 M. Schlick, Die Wende der Phil,,sophie (1930), 1r. i1. La svoua tkl/afosofot, in M.
Schlick, Tra rettlimu, e neo-poJilivism4, Il Mulino, Bologna 1974, p. 32.
8
ILR UOLO DELLA FILOSOFIA NEL MONDOCotffEMPORANEO
una filosofia edificante, che, quando è davvero efficace non è più nem
meno filosofia, ma buona letteratura, «conversazione dell'umanità»''.
Contrapposta a questa tendenza, la concezione sistematica, che è
oggetto del terzo capitolo, riafferma che la filosofia è un sistema di co
noscenze e, come tale, ha un ruolo imprescindibile anche nel panorama
contemporaneo. Anzi, per Husserl la filosofia deve aspirare a divenire
scientifica, cioè a realizzarsi come "scienza rigorosa•; alla filosofia cosl
intesa
si schiude un campo di lavoro infinito cd una scienza che senza rutti i
metodi di indiretta simbolizzazione e matematizzazione, senza
l'apparato di sillogismì e dimostrazioni, ottiene rutravìa una gran quan
tità di conoscenze rigorosissime decisive per ogni filosofia ulteriore".
Nicolai Hartmann, pur ritenendo che la filosofia come apparato or-
ganico di teorie sia tramontata, promuove il pensiero sistematico che
non si risolve nel!'e sposizione di un sistema, ma piuttosto si costituisce
come pensiero-problema che coglie la complessità del mondo e ha come
oggetto "l'enigma del mondo". Certamente i problemi che riguardano
interrogativi inesplicabili non possono essere risolti definitivamente, ma
non per questo la filosofia è inutile, poiché anche la ricerca che non
produce risposte definitive può contribuire a una migliore comprensio
ne della realtà. Anzi, secondo Hartmann la storia della filosofia insegna
che «è proprio in quei problemi i quali, malgrado tutte le elaborazioni,
non hanno potuto giungere ad una soluzione, che si verifica un conti
•s.
nuo progresso della speculazione»
"Cfi-. R. Rorty, Phi/;,sophyand rhe Mirror o/N arure (1979), tr. it. L.tfi/osofoze /;, spec
<hio de/14 narura,Bompiani, Milano 1986, p. 199.
"E. Husserl, Phj/;,sophie ais srrenge Wusensthaft (1911), tr. it. L.tfil,,sofia ,ome scienz,,
rigorosa, ETS, Pisa 1990, p. I 13.
•s Cfi-. N. Hartmann, Sysrcnarische Phj/;,sophù in eigener Darsrdlung (1931 ), tr. it. Fib,.
sofiasisremarica, Bompiani,Milano 1943,p.123.
9
FILOSOFIA E CONOSCEN"LA
Anche secondo Searle la filosofia è « teoretica, comprensiva, sistema
tica e universale nei contenuti»''; poiché abbiamo a disposizione una
grande quantità di conoscenza di cui non è ragionevole dubitare, la filo
sofia può collaborare con le scienze per costruire un'immagine il più
possibile coerente della realtà, gestendo le conoscenze che derivano da
diverse indagini disciplinari, focalizzandosi su alcuni nodi problematici
e non ancora del tutto risolti all'interno delle singole scienze, quali, per
esempio, il problema corpo mente, il rapporto tra il linguaggio e la real
tà, i fenomeni sociali, l'etica e l'oggettività delle norme.
Ammesso, dunque, che la filosofia abbia ancora un senso e - forse -
un valore, in che cosa consiste la sua utilità? Anche nel rispondere a
questo interrogativo il pensiero contemporaneo si è differenziato, met
tendo in risalto diverse funzioni della filosofia. T aie eterogeneità, lungi
dall'essere a nostro avviso sintomo di inadeguatezza, rivela che la filoso
fia risponde a esigenze diverse, che certamente non si escludono reci
procamente, ma che anzi convergono nel riconoscere non solo l'utilità,
ma addirittura l'imprescindibilità del sapere filosofico, inteso non come
appannaggio di pochi addetti ai lavori, bcnsl come esigenza comune a
tutti gli esseri umani.
Nel quarto capitolo alla tesi di Popper fa da contraltare la posizione
complementare di Robcrt Solomon. 11 sostenitore del razionalismo cri
tico ritiene che tutti gli uomini siano filosofi, poiché «anche quelli che
non sono consapevoli di avere problemi filosofici, hanno tuttavia pre
giudizi filosofici» 17 Quindi, in primo luogo, la filosofia dovrebbe essere
•
critica razionale dei pregiudizi che sono diffusi nella propria cultura e
nella società di appartenenza; inoltre, la filosofia dovrebbe essere anche
costantemente in dialogo critico con le scienze, infatti «l'indagine criti
ca delle scienze, delle loro scoperte e dei loro metodi resta una peculiari-
"). Scarle, The Future ofP hiu,,ophy (1999), tr. ir. FilolOfo, e razibnalità: qU4/efaruro?,
in R. Corvi (cur.), E,perienzae razibn,,/irà, Angeli, Milano 2005, p. 40.
17 K.R. Popper, Wìe ith di, Phiu,,ophiesehe (1977), tr. ir. Come ved,,Ltfiu,,ofoz, in K.R.
Poppcr, Allari<ma di un mondo migliore, Armando, Roma 1989, p. 182.
10
ILR UOLO DELU FILOSOFIA NEL MONOOCOmF.MPORANEO
tà della ricerca filosofica, anche dopo che le singole scienze si sono di
staccate dalla filosofia» 11
•
Anche Robert C. Solomon sostiene che la filosofia appartiene a tutti
gli uomini, poiché la filosofia
è una lotta ingaggiata con i problemi perenni della vita. Siamo rutti filo
sofi e dobbiamo democratizzare la filosofia, nonostante le sue lunghe
radici elitarie. La filosofia non è una specializzazione, una professione,
un club esclusivo con sue regole e parole d'ordine. La filosofia non è al
tro che pensare a temi quali passione, giustizia, tragedia, morte, identità
dell'io e, naturalmente, la filosofia stessa, che non è affatto il territorio
rlscrvato o il privilegio di un piccolo gruppo di professionisti che
l'hannostudiata all'universicà''·
Solomon, che è americano come Rorty, è pure lui critico nei con
fronti della filosofia analitica, tuttavia, a differenza di Rorty, pensa che
la filosofia analitica sia "un salutare correttivo• nei confronti di un ec
cessivo romanticismo, con la sua pretesa di rigore e di chiarezza frena la
tendenza a voli speculativi spesso più astrusi che profondi. Questo in
tento, indubbiamente meritorio non deve però costituire un alibi per
un tecnicismo inaccessibile, anzi
la formalizzazione (fuori delle discipline formali) dovrebbe essere vista
come una scivolata nell'oscurità piuttosto che un contributo alla chia
rezza. [. .. ) La filosofia analitica, quando non pretende di essere l'wùca
voce nella stanza, apre (piurrosto che chiudere) il mond<>'°.
In tal caso, però, alimenta «una scomoda tensione fra la necessità di
speculare e l'ansia di chiarire», ma questa è proprio la vocazione della
filosofia, impegnata a riflettere con attenzione sui problemi perenni del-
11 K.R. Popper,Co= veJq L,fi/oSQ.fia, cit.,p. 188.
" R.C. Solomon, The Joy o/ Philosophy ( 1999), tr. it. I.A gwia del/,, fi/oSQ.fia, Apogeo,
Milano 2008, p. XXIII.
,. R.C. Solomon, I.A gioia tk/lafi/oSQ.fia, pp. 276-277.
li