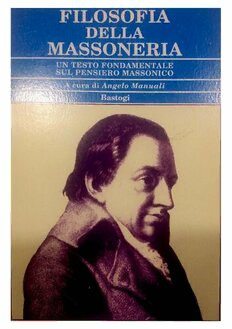Table Of ContentINTRODUZIONE
Giovanni Amedeo Fichte si affiliò con entusiasmo alla
Massoneria nel 1793, a Zurigo. Scrisse, infatti, subito do
po al Von Schon: "In questo campo ho molteplici piani,
idee e speranze, per cui mi occorrono uomini d'animo
rnolto elevato,,. Ma a Jena, dove passò nel 1794, non vi
era in quel periodo una Loggia massonica, per cui si do
vette iscrivere alla "Giinther al leone rampante" di Rudol
stadt.
r\Jel 1799, quando fu costretto a lasciare Jena (la famo
sa lotta per l'accusa di ateismo obbligò il filosofo ad an
darsene, dopo varie persecuzioni), si trasferì a Berlino, do
ve trovò un ambiente favorevole.
Ignazio Fessler, uno degli uomini più notevoli di quel
tempo e di quell'ambiente, lo introdusse e lo fece affer
mare subito nella Loggia "Royal York dell'amicizia". D'al
tra parte, Fichte era preceduto dalla fama di uomo pronto
a lottare per la libertà di pensiero e di azione.
Il 14 ottobre 1799 egli pronunciò un discorso all'as
semblea generale della Loggia "Sul vero e retto scopo del
la _Massoneria" suscitando l'entusiasmo dei presenti.
Ma l'affiliazione vera e propria avvenne 1'11 aprile
1800; 1'8 maggio divenne membro dell'Intimo Oriente e
il 23, Oberredner, cioè "oratore in capo".
Fra gli impegni della carica vi era quello di tenere ogni
quindici giorni una conferenza sulla Massoneria. Ma già
il 13 e il 27 aprile 1800 egli aveva incominciato a tenere
"lezioni", davanti a molti fratelli, non solo della "Royal
Yorlc".
L'originale di queste lezioni è purtroppo andato perdu-
7
to. Esse ci sono pervenute sostanz.ialt~1e~1ten el ~esto della
"Philosophie der Maurerei", che qut nproducian10.
Il manoscritto fu da Fichte consegnato al confratello
Gian Carlo Fischer, che lo sta1npò anonin10 nel periodo
1802-1803, in una sua rivista massonica intitolata ai 1ni
steri eleusini 1
•
Il Fischer, per sua stessa confessione, 111odificòl 'aspet
to delle lezioni: le trasformò in una serie di lettere a un
personaggio im1naginario (un "profano" chiamato Co
stante), che non sapeva nulla di Massoneria, con interpo
lazioni, do111andee riferimenti diretti all'interlocutore del
tutto fastidiosi e inutili. Si trattava di un vero e proprio
"n1isfatto" letterario, anche se attuato con le migliori in
tenzioni.
Nel ripubblicare ora queste "lezioni" abbiamo cercato
di porre rimedio a tale "misfàtto", riportando il testo, per
quaqto è stato possibile, al suo originario contenuto. Ab
biamo quindi eliminato tutte quelle parti chiaramente ag
giunte (per fare da introduzione o da raccordo tra le varie
"lettere"), come pure le domande e Ìe risposte dirette
(scritte con il tu) in un immaginario scambio epistolare
tra il Fichte e l'inesistente Costante, inserite ad arte dal Fi
scher.
Non possiamo garantire che, così facendo, abbiamo
potuto ridare piena integrità al testo del nostro filosofo,
• ma di certo è stata eliminata molta inutile zavorra. E spe
riamo così di aver fatto cosa utile per il lettore.
Angelo Manual.i
(1) ~leusinien dts XIX Jahrhundtrts odtr Resultate vtreinigten Denker iiber Philo
s?ph,eu nd_G eschichtdee r FreymaurereyB. erlin, 1802, 1803; 2 Bande, bei Hein
nch Frohlich. - La «Filosofia della Massoneria» occupa le pp. 9-43 del voi. I, e
le pp. 3-60 del voi. II.
LL
.I -
,,,I .
L'
Lo •s copo di un uomo saggr,oe virtuoso
Ciò che vuole l'uomo ~aggio e virtl,!OSO e che è il suo
scQCo e o sco o 1na e e umanità. L'unico sco o
dell'esistenza umana sulla terra non è né Cielo né i r
no n solo l'umanità, che quaggiù portiamo in noi e la
sua n1assima possibile e eiione. Diversamente da
sto nulla conosciamo: e ciò che noi chiamiamo di • o
ia olico, est1al~, nu 'a tro è che umano. Q1:1anto non è
contenuto nello sco~o del a erfezione iù rande "bi
le, uanto non si riferiscea d esso o non ha ra orto n
esso né uale arte né non uò costituire o
~,,,,,,,.,a
sco o _ • nessun uomo; e l'uomo saggio e virtuoso non può
pro_ orselo come sco o sia ne caso più genera e c e I
più articolare: ciò che sta so .r a o sotto a 'umanità
anche fuori della cerchia del suo· ensiero dei su •
◄del suo agire.
In una qualsiasi misura quello scopo viene alla luce in
tutti gli uomini, senza che essi chiaramente lo pensino e
lo ·perseguano di proposito, semplicemente per via della
loro nascita; e viene pure conseguito mediante la loro vita
nella società: sembra come se non fosse il loro scopo,
bensì uno scopo _unitoa loro. Ma l'individuo cosciente Io
pensa chiaramente, esso è il suo scopo, ed egli se lo pone
quale mèta cosciente di tutto il proprio agire.
Come viene esso perseguito nella grande società uma
na? Forse tutto opera in favor suo direttamente e senza
deviazioni, con forze associate? Non pare. La società non
15
pensa né lavora con la _chiare~zae con la consapevolezza
proprie dei singoli saggi; s~ lei pes_anol e colpe del I"?ondo
e occupata com'è di questi peccati, essa ha appena 11 tem
po di lavorare per una posterità che a sua volta avrà da la
vorare per un'altra. Essa deve sostenere la sua gran lotta
con la natura ostinata e col tempo infingardo; vuole ac
quistare vantaggio su entrambi e intanto la sua attività è
sottoposta a una condizione svantaggiosa, ma inevitabile:
essah a diviso in parti l'insiemed ell'evoluzioneu mana, se ne è
distribuitel e varie branchee attività, e a ciascunac ondizione
socialeh a assegnatoi l suo campo specialed i collaborazione.
Come in una fabbrica si risparmiano tempo e s ese se
il· singolo operaio per tutta a sua vita fa so tanto ue
a,
data •o nna mo 1 c o, ruota o recipiente, dà s -
1 10
tanto quel ato co ..o. re, sorveg ia e gu1 a so o uella d
macc 11na; e ciascun a ro e pan per tutta a sua vita es.e
gue la tal altra forma di lavoro, che da ultimo riunis~ in
un tutto un capomastro sconosciuto a tutti loro: e 1-
.m. ente proce ono e cose ne a gran e o 1c1nad ell' evolu-
_zione umana. Ciascuna classe lavora e produce alcunché
per tutte le altre, oltre a ciò che ciascuno dovrebbe fare
Rer la ro ria arte e er la sua stessa persona: e quelle
producono alla loro volta anche per u1 CIOa cuI eg 1 non
JI_ate mpo ne attitudine ben altnment1 occupato per ti pro:_
prio benessere.
Alla salute e al perfezionamento del tutto, guida o i
opera et singoli znvzsz t e mano e ~rovvz nza.
ll
osi 1 otto 1scen e ne e pro onaità de o spirito e
della scienza, per evocare alla luce ciò che alcune epoche
d~po sarà a tutti facile e utile, mentr~ il contadino e l' ope
raio lo nutrono e lo vestono; l'impiegato dello Stato fa va
le_rei l diritto, che senza di lui dovrebbe applicare la comu
nità stessa, e il guerriero difende l'inerme, che lo nutre,
contro la potenza straniera.
16
111
Le divisioni delle società particolari
Ora, ciascuns ingolo sif or,na in grado eminente soltantop er
la condizione cht ha scelto.D alla giovinezza in poi egli vie
ne per sua scelta e per circostanze accidentali esclusiva
rnente indirizzato verso una forma di vita e viene tenuta
in conto della migliore quell'educazione che prepara il ra
gazzo per la sua futura vocazione nella maniera più con
.forn1e allo scopo; rimane posto in disparte tutto ciò che
r on sta nella più stretta relazione con quella, o ciò che in
-lui non può, con1e s'usa dire, essere utilizzato. Il giovinet
to destinato a diventare un dotto impiega tutto il suo tem
po a imparare le lingue e le scienze; e proprio con prefe
renza quelle che sono necessarie per guadagnarsi il pane
in avvenire, quindi con minuziosa esclusione di quelle
che richiede la formazione del dotto in generale. Tutte le
altre forme di vita e attività gli sono estranee, com' esse so
no estrànee l'una all'altra. Il medico ha rivolto tutta la sua
attenzione alla sola medicina, il giurista alla legislazione
del suo paese, il mercante a quel determinato ramo del
suo commercio, il frabbricante alla sola produzione del
suo manufatto. Nel suo campo egli sa quanto è necessa
rio, e anzi con maggiore chiarezza e fondatezza: questo
gli è quindi particolarmente caro e lo considera come sua
proprietà acquisita; in esso vive come nella sua casa pater
na. - E tutto questo è bene, ciascuno fa in ciò il proprio
dovere e il tenore contrario non solo sopprimerebbe tutti
i vantaggi della società, ma sarebbe dannoso anche al sin-
• 17
golo, con e al tutt~- . .
1
Ma da ciò sorgez n tutti necessarzam~ntue na certa incom-
. tezza e unilateralità,c he,s e non proprio necessariamentea l-
pzu . d . ,
,.1; •
menop erò abitualm_ente_t ra5;orm_azn pe anterza. - La pe-
s1
danteria, che ord1nanamente vien confusa con la sola
classe erudita - forse perché essa vi è più visibile, forse
perché vi si dimostr~ ma~giore in~ol~e~anza, - domina in
tutte le classi sociali; e il suo pr1nc1p10 fondamentale è
dappertutto lo stesso, cioè il seguente: di tenere in conto
di comune educazione umana l'educazione appropriata al
proprio stato particolare e fare ogni sforzo per realizzarla.
Così l'erudito pedante stima solo la scienza e deprime
ogni altro valore; le sue lezioni e conversazioni in società
di gente mista procedono allo scopo di comunicare ai
suoi uditori una particella della sua dottrina e farli bramo
si della precisione di pensiero ch'egli possiede. Il mercan
te pedantesco sprezza per contro l'erudito e proclama:
«Non vi è che computo e denaro! Il denaro è la soluzione
del problema della vita ragionevole e felice». Il guerriero
sprezza l'uno e l'altro, stima solta.ntò forza fisica e agilità,
coraggio bellico e difesa dell'onore com'egli la intende, e
non gli rincrescerebbe arruolare tutti quelli che sanno bat
tere il tempo di marcia. I teologi in modo eminente (poi
ché la loro classe ha ottenuto fra tutte il maggior influsso,
o per amore del cielo o per timore dell'inferno) si affatica
no, da quando hanno esistenza, a educare in tutti gli uo
mi~i, fin giù ai ragazzi del villaggio, dei teologi ben fon
dati e dei dogmatici di polso. - «Mirate avanti tutto al re
gno di Dio, il resto è cosa meschina!» dicono i teologi:
e ~appiamo bene quello che intendono per il regno di
D10.
'
. Così domina dappertutto una grande unilateralità, ora
utile e ora dannosa: cosi ciascun individuo non è soltanto
un dotto, ma teologo o giurista o medico, - non è soltan-
• 18
to uno spirito religioso, ma cattolico o luterano, ebreo o
maomettano, - non è soltanto un uomo, ma politico,
mercante, guerriero; e così dappertutto, con la più alta
possibile educazione di classe si impedisce la più alta pos
sibile evoluzione dell'umanità, il sommo fine dell'esisten
za umana; anzi essa deve restar impedita, perché ciascuno
è gravato dall'ineliminabile dovere di educarsi quanto più
perfettamente può per la sua particolare occupazione: e
questo è quasi impossibile se non si affronta il rischio
dell'unilateralità.
......
La cultura 1nassonicae il massone
Chec osao peral 'Ordine nel Massone?Q uale azionee sercita
essos ul mondo? ·
Se l'associazione non è interamente vana e inattiva, co
lui che vi si trova deve però, senza dubbio, - stia pure egli
a quel livello della cultura che più gli talenta, - avvicinarsi
alla maturità assai più che non avrebbefa tto lo stessoi ndivi
duo,f uori dell'associazioneN. el caso dell'uomo sveglio e
pronto ciò vale anzi per ogni nuova relazione in cui egli
entra.
!
Io prendo qui maturità e pienezza di cultura universal
menteu rnana per termini equivalenti, e a buon diritto. La
cultura unilaterale è sempre immaturità: quand'anche da
una parte dovesse essere eccesso di maturità, dall'altra pe
rò sarebbe certamente, appunto a tal uopo, aspra e acerba
.
. '
1mmatunta.
Il principale segno distintivo della maturità è la forza
mitigata dalla grazia. - Tutti quei suoi potenti corrucci,
quei larghi impeti e assalti sono le prime e pur necessarie
tirate e scosse della forza che si sta sviluppando; ma essi
non si constatano più, dopo che è compiuto lo sviluppo e
si è pienamente realizzata la bella forma spirituale. O per
dirla coi termini retorici della scuola: una volta venuta la
maturità, l'ardita poesia si disposa alla chiarezza della
mente e alla rettitudine del cuore, e la bellezzae ntra in
connubio con la saggezza e la fortezza.
Questa è l'immagine dell'uomo maturo ed evoluto,
35