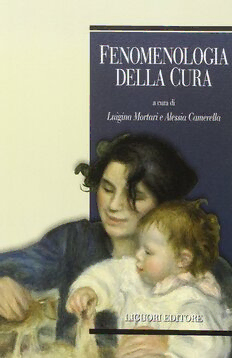Table Of ContentA
R
U
C
Fenomenologia
A
L
L
E
C
D della ura
A
I
G
O
L
a cura di
O
N
E Luigina Mortari e Alessia Camerella
M
O
N
E
F
)
i
d
a
r
u
c
a
(
a
l
l
e
r
e
m
a
C
.
A
,
i
r
a
t
r
o
M
.
L
LIGUORI EDITORE
Teorie & Oggetti della Filosofia 75
Collana diretta da Roberto Esposito
Fenomenologia della cura
a cura di
Luigina Mortari e Alessia Camerella
ISSN 1973-1507
Liguori Editore
Questa opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore
(http://www.liguori.it/areadownload/LeggeDirittoAutore.pdf).
L’utilizzo del libro elettronico costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel
Contratto di licenza consultabile sul sito dell’Editore all’indirizzo Internet
http://www.liguori.it/ebook.asp/areadownload/eBookLicenza.
Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi
forma, all’uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione
radiofonica o televisiva, alla pubblicazione e diffusione attraverso la rete Internet sono riservati. La
duplicazione digitale dell’opera, anche se parziale è vietata. Il regolamento per l’uso dei contenuti e dei
servizi presenti sul sito della Casa Editrice Liguori è disponibile all’indirizzo Internet
http://www.liguori.it/politiche_contatti/default.asp?c=contatta#Politiche
Liguori Editore
Via Posillipo 394 - I 80123 Napoli NA
http://www.liguori.it/
© 2014 by Liguori Editore, S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati
Prima edizione italiana Giugno 2014
Mortari, Luigina (a cura di) :
Fenomenologia della cura/Luigina Mortari e Alessia Camerella (a cura di)
Teorie & Oggetti delle Filosofia
Napoli : Liguori, 2014
ISBN 978 - 88 - 207 - 5262 - 0 (a stampa)
eISBN 978 - 88 - 207 - 5263 - 7 (eBook)
ISSN 1973-1507
1. Pratiche, infermieri 2. Insegnare, educare I. Titolo II. Collana III. Serie
Aggiornamenti:
————————————————————————————————————————
21 20 19 18 17 16 15 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Indice
Capitolo primo
1 Frammenti di una fenomenologia della cura
Luigina Mortari
Qualcosa per cui ne va dell’esserci 1; Mancare d’essere 2; La matrice relazionale
dell’esserci 6; Relazionalità e dipendenza 8; Il sentire che muove l’agire 10; Sentirsi
responsabili 13; La tensione donativa 18; Avere riguardo 20; Quale politica? 22;
Riferimenti bibliografici 24.
Capitolo secondo
27 Teoria e pratica della cura in educazione
Nel Noddings
Teoria della cura 27; L’aver cura nell’insegnare 37; Riferimenti bibliografici 47.
Capitolo terzo
49 La storia della ricerca
Luigina Mortari e Alessia Camerella
Introduzione 49; Disegno emergenziale-evolutivo ed elaborazione induttiva della teo-
ria 50; Raccolta e analisi dei dati 52; Coding System 68; Conteggio delle etichette in
assoluto e per regioni 69; Core categories 70; Risultati 72; Il team 74; Posture cognitive
75; Conclusioni 79; Numerazione indicativa 80; Riferimenti bibliografici 81.
Capitolo quarto
83 Nell’universo della sofferenza. L’infermiere: dall’oggettivismo
tecnicistico del curare al soggettivismo umanistico dell’aver cura
Rita Fadda
Capitolo quinto
109 Pensieri di cura: infermiere e infermieri
Alessia Camerella
Creare un contatto fisico non intrusivo 112; Accompagnare l’altro verso l’autonomia
114; Accompagnare l’altro con la parola che rassicura 115; Tranquillizzare e interpre-
tare il vissuto 115; Ascoltare 116; Rivolgere la parola e cercare il contatto attraverso
la parola 117; Interpretare il vissuto 117; Osservare 118; Informare e informarsi 119;
Cura tra totalità, personalizzazione e limite 119; Riferimenti bibliografici 21.
viii IndIce
Capitolo sesto (prima parte)
123 Educazione e cura: chinarsi sulla vita, in attesa
Ivo Lizzola
Educare competenze per la vita nella vulnerabilità 123; L’intenzionalità e le fratture
esistenziali 128; Tessiture di prossimità là dove si prova a vivere 130; Curare ed
educare: fioriture spontanee impreviste 133; Chinarsi di nuovo sulla vita, in attesa
136; Riferimenti bibliografici 139.
Capitolo sesto (seconda parte)
141 Pietà
Ivo Lizzola
Capitolo settimo
145 Il lavoro educativo e l’esigenza di averne cura.
Uno sguardo sulla contemporaneità
Cristina Palmieri
Premessa 145; Il lavoro educativo come lavoro di cura 146; L’esigenza di aver cura
del lavoro educativo: da necessità strutturale a urgenza contemporanea 157; Prospet-
tive e oggetti di cura del lavoro educativo nei territori della contemporaneità 168;
Riferimenti bibliografici 173.
Capitolo ottavo
177 Pensieri di cura: educatrici ed educatori
Alessia Camerella
Creare un contatto fisico non intrusivo 180; Informare e informarsi 181; Dare regole
182; Creare comunicazione su contenuti significativi 182; Responsabilizzare l’altro
185; Mettere in relazione soggetto e società 186; Ascoltare 187; Riferimenti biblio-
grafici 190.
Capitolo nono
191 Per una didattica dell’aver cura.
La cura per le professionalità educative nei contesti per l’infanzia
Lucia Balduzzi
Pensare, nella pratica, la pratica della cura; alla ricerca di categorie per la didattica
191; Quando le insegnanti pensano la cura – itinerari di ricerca per definizioni incerte
195; I racconti dell’aver cura. Metanalisi si pensieri e parole 197; Cura e profes-
sionalità 203; La cura di chi cura 207; Considerazioni conclusive 211; Riferimenti
bibliografici 213.
IndIce ix
Capitolo decimo
217 Pensieri di cura: insegnanti
Alessia Camerella
Dare regole 223; Creare un contesto Fisico non intrusivo 227; Ascoltare 229; Dare
tempo alla relazione di costruirsi 230; Favorire l’elaborazione e l’espressione di sen-
timenti ed emozioni 232; Far pensare 233; Creare comunicazione su contenuti si-
gnificativi 234; Creare routines 235; Riferimenti bibliografici 236.
Capitolo undicesimo
239 Pensieri di cura nell’agire materno
Alessia Camerella
Favorire l’espressione di emozioni e sentimenti 241; Aver cura del pensare 242; Ascol-
tare 243; Osservare 245; Informarsi 246; Dare regole 246; Cercare di responsabilizzare
l’altro 247; Trattare l’altro con riguardo senza essere intrusivi 248; Sostenere e sdram-
matizzare 249; Brevi considerazioni conclusive 252; Riferimenti bibliografici 255.
257 Gli Autori
Capitolo primo
Frammenti di una fenomenologia della cura
Luigina Mortari
1. Qualcosa per cui ne va dell’esserci
A costituire un fatto evidente è che la cura è qualcosa di fondamentale
nella vita dell’essere umano, poiché senza cura l’esistenza non può fiorire.
Nessuna società può garantire una qualità della vita sufficientemente buona
se le persone non si prendono cura le une delle altre.
Se, come suggerisce l’analitica heideggeriana, si prende in esame l’essere
dell’esserci per comprendere la sua qualità essenziale si scopre che la cura è
il modo fondamentale dell’esserci, «è la totalità primaria della costituzione
d’essere dell’esserci»1. Quando svolgo un’attività per procurarmi quanto ser-
ve per nutrire il corpo, quando cerco di coltivare una relazione, quando mi
immergo nella lettura per nutrire la mente, quando mi preoccupo di fornire
sostegno ad un’altra persona, quando dedico le mie energie alla costruzione
di uno spazio di comunità condiviso, sempre mi occupo, preoccupo, prendo
a cuore qualcosa, cioè ho cura.
Ma che cosa s’intende precisamente per cura? Proprio perché il termine
cura è di uso comune è necessario fare chiarezza, liberandolo da interpre-
tazioni casuali, da significati ovvi e logori. Definisco la cura un’azione, una
pratica. Nella favola della Cura riportata da Heidegger in Essere e tempo, si
trova che la cura è una persona che impasta argilla, cioè agisce, fa qual-
cosa, dà forma all’essere. Se si assume che la cura sia una pratica si può
dire di trovarsi di fronte a un fenomeno di cura solo quando troviamo una
persona che agisce: con i gesti e/o con la parola. Certo ci sono pensieri e
sentimenti che possono essere definiti di cura, poiché essenziali al mettere
in atto un’azione di cura, ma fino a quando un’intenzione, un desiderio,
un progetto non si traduce in un’azione visibile non si può ancora parlare
di cura.
1 M. Heidegger, Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, Genova: Il Melangolo, 1999, p. 379;
[Prolegomeni zur Geschichte des Zeitbegriffs, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann Verlag, 1975].
2 Fenomenologia della cura
Per definire un’attività umana non basta dire come si manifesta, è ne-
cessario specificare l’intenzione che la genera e la guida. Si può dire che la
cura è una pratica mossa dall’intenzione di procurare beneficio a se stessi
(cura di sé) e ad altri. In molti teorici e soprattutto teoriche – poiché il pen-
siero sulla cura è prevalentemente femminile – si parla della cura come di
un’attività rivolta ad altri. Così è la definizione fornita da Diemut Bubeck2,
che parla della cura come di una “other directed practice”, cioè un’attività
«fondamentalmente rivolta ad altri per portare loro beneficio»; in quanto
tale richiede un notevole investimento di tempo e di energia, ragione per cui
si può definire la cura un lavoro, anche se si tratta di un lavoro particolare
che richiede specifiche virtù e valori, e in particolare una profonda motiva-
zione a recepire le domande che provengono dalle altre persone.
Ma se in molti studi che si occupano di cura questa pratica è concet-
tualizzata come azione rivolta ad altri, non bisogna trascurare che la cura
è anche un lavoro per sé, poiché come apprendiamo dall’antica filosofia
greca, ciascun essere umano ha il compito di aver cura di sé, per conser-
vare la vita e far fiorire le sue proprie possibilità esistenziali. Ciò che più
grava sulla coscienza di una persona è l’incuria per la sua vita. Se è vero
che senza ricevere cura da altri non possiamo apprendere ad aver cura di
noi, è anche vero che solo avendo cura di noi stessi siamo in grado di aver
cura degli altri. Quando si affronta il tema della cura è, dunque, necessario
tenere intimamente uniti i due piani: quello della cura rivolta a sé e della
cura rivolta ad altri.
2. Mancare d’essere
Nella favola riportata da Heidegger si narra che la Cura dà forma all’argilla
e che, una volta che il pupazzo prende vita, Saturno decide che per tutto
il tempo della vita “lo possiederà la Cura”. Questo per dire che la pratica
di cura è consustanziale all’esser-ci. La cura è azione ontologica necessaria
perché la condizione umana è caratterizzata da mancanza e dipendenza:
manchiamo di potere sul nostro esser-ci e insieme manchiamo di una forma finita, e sia-
mo dipendenti dagli altri poiché la nostra sostanza ontologica è intimamente relazionale.
Che siamo mancanti di essere è evidente dal fatto che siamo chiamati
a divenire il nostro poter essere, sia biologico sia spirituale. Si può parlare
2 G. D. Bubeck, Justice and the Labor of Care, in E. F. Kittay e E. K. Feder (a cura di), The
Subject of Care. Feminist Perspectives on Dependency, Boston: Rowman & Littlefield Publishers,
2002, p. 160.