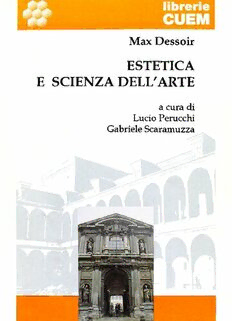Table Of ContentMaxD essoniarc quae B erlinneol1 86E7b.b et ria
suomia emiD ilthseoytt,ol ac ugiu idsail aureiònes tetica
all'univedreslilsatu àac itntaàt alNee.l l'atebneerol inese
insegnpòe rl unghain nif,i naoc hef ur idotatlso i lendzailo
nazismMoo.r in el1 947ls. u oiin terensosnii nvestirsoonloo
l'ambito aret fiisltoiscoof miac aon,c hel ap sico:ogia: dedicò
importanti raiicp errocbhleed meil l'incondseclilo',i pnoet ismo
soprattudtetlolp aa rapsicolSovgoilasu.en 'inteantstai voirtgàa
nizzatnievlal 'ambdietlolc au lturfao:nd òn el1 906 1aZ eitschrift
fUA:s theutnidak l lgemKeuinnset wissernisvcichshtaeaaf nt,
corao ggie scer egolarmenDteel.ls ot esasno noè lap ubblica
ziondee ll'opcehreaq uid iamoi nt raduzionneel lseu ep arti
principSaitl ria.l dtiua n l avorloac uir ilevannoznaè m eramen
tes toriciane :s son ons olos it raccuina d ensob ilancio delle
imponenti insdvaoglitnniee llgar andset agiodneel l'estetica
tedesctara l af indee ls ecolsoc orseo g lail bodreil n ostrmoa,
anchesi g ettaing oe rmdii f utusrvii luplp'ia.ntisoggettliav ismo,
separazimoenteo ditcraae stetiec aort isti(ceqo u indtir eas teti
cae sciendzeal l'arlt'ea)p,e rtvuerrasi op robledmeil l'acrotne
temporaneialr, i fiudtiqo u alsitaesoir izzazvieolnlee itariamen
teo mnicomprensuinvm ao,d od ip rocedemraei a strattamente
apriorismtai pcroo,n taod a ccogliee race o nfrontiar ries ultati
dia mbitdii verdsiir icerec aad erenatlel cao ncretedzezlal a
realrteàs tatnroa if rutptiiùa ttuadleils uop ensiero.
llllllllllllllllllllllllllllll llllllllll
88600150(52585747)
Esteteis ccai endzeal l'arte
MAXDESSOIR,EMILUTITZ,EDGARWIND,ERWINPANOFSKY
ESTETICA E
SCIENZA GENERALE DELL’ARTE
I “concetti fondamentali”
a cura di
Andrea Pinotti
Proprietàletterariariservata
©2007byCLUEB
CooperativaLibrariaUniversitariaEditriceBologna
Fonti:
MaxDessoir:SkeptizismusinderAesthetik,«ZeitschriftfürÄsthetikundallgemeine
Kunstwissenschaft»,2,1907;ObjektivismusinderAesthetik,«ZeitschriftfürÄsthetik
undallgemeineKunstwissenschaft»,5,1910;AllgemeineKunstwissenschaft,«Deutsche
Literaturzeitung»,44/45e46/47,1914
EmilUtitz:DasProblemeinerallgemeinenKunstwissenschaft,«ZeitschriftfürÄsthetikund
allgemeineKunstwissenschaft»,16,1922;ÜberGrundbegriffederKunstwissenschaft,
«Kant-Studien»,34,1929
EdgarWind:TheoryofArtversusAesthetics,«ThePhilosophicalReview»,34/4,1925;
ZurSystematikderkünstlerischenProbleme,«ZeitschriftfürÄsthetikundallgemeine
Kunstwissenschaft»,18,1925
ErwinPanofsky:ProblemederKunstgeschichte,«DeutscheallgemeineZeitung»,327-328,1927
traduzionidiPietroConte,NicolMocchieAndreaPinotti
Progettografico:OrianoSportelli
Dessoir,Max
Esteticaescienzageneraledell’arte.I“concettifondamentali”/MaxDessoir,EmilUtitz,Edgar
Wind,ErwinPanofsky;acuradiAndreaPinotti.–Bologna:CLUEB,2007
223p.;22cm.
(Relazioni e significati : collana di Testi e Studi fondata da Lino Rossi e diretta da Giovanni
Matteucci;Testi,7)
ISBN978-88-491-2913-7
CLUEB
CooperativaLibrariaUniversitariaEditriceBologna
40126Bologna-ViaMarsala31
Tel.051220736-Fax051237758
Finitodistamparenelmesedisettembre2007
daLegoprint-Lavis(TN)
INDICE
7 Introduzione, di Andrea Pinotti
PARTE I
ESTETICA E SCIENZA GENERALE DELL ART’E
27 Max Dessoir, Lo scetticismo in estetica (1907)
45 Max Dessoir, L’oggettivismo in estetica (1910)
59 Max Dessoir, Scienza generale dell’arte (1914)
77 Emil Utitz, Il problema di una scienza generale dell’arte (1922)
95 Edgar Wind, Teoria dell’arte versus estetica (1925)
PARTE II
I “CONCETTI FONDAMENTALI” DELLA SCIENZA DELL’ARTE
105 Edgar Wind, Sistematica dei problemi artistici (1925)
149 Erwin Panofsky, Problemi della storia dell’arte (1927)
155 Emil Utitz, Concetti fondamentali della scienza dell’arte (1929)
217 Indice dei nomi
Introduzione
di Andrea Pinotti
1. Estetica e scienza generale dell’arte: un divorzio produttivo
La premessa generale dei testi che qui presentiamo1 è costituita da un divor-
zio – quello fra l’estetica e la teoria dell’arte – che, maturatosi all’interno
della cultura estetologica tedesca nel corso della seconda metà dell’Otto-
cento, viene celebrato ufficialmente nell’anno 1906 con un duplice rito offi-
ciato da Max Dessoir: la pubblicazione del volume Estetica e scienza generale
dell’arte2 e la fondazione della rivista omonima «Zeitschrift für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft»3, attiva a tutt’oggi (paradossalmente, fu
la prima rivista specialistica di estetica, e venne intitolata a una radicale deli-
mitazione dell’estetica stessa).
Quell’“e” nella formula “estetica e scienza generale dell’arte” è inteso da
Dessoir innanzitutto e per lo più come “o”, cioè come disgiunzione piutto-
sto che come congiunzione: si tratta infatti di separare rigorosamente i ri-
spettivi ambiti di indagine e le corrispondenti competenze delle due disci-
pline, avvertendo come un’indebita ed esiziale confusione quell’equazione
che il primo Ottocento aveva consegnato alla contemporaneità: l’estetica –
così suonava la paradigmatica definizione hegeliana – è filosofia dell’arte
bella4. Ora, non solo l’estetica secondo Dessoir non va affatto identificata
con la riflessione filosofica sull’arte (a tale compito si attrezzava appunto la
scienza generale dell’arte), ma altresì l’arte non può essere tout court ricon-
dotta alla categoria del bello, esistendo manifestazioni artistiche che con
1 Per un profilo bio-bibliografico degli autori dei saggi qui presentati, e per le notizie sulle
relative fonti, si rinvia alle schede in calce a questa introduzione..
2 M. Dessoir, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart 1906 (II ed. modificata
1923); trad. it. parz. di F. Farina della II ed., Estetica e scienza dell’arte, a cura di L. Perucchi e
G. Scaramuzza, Unicopli, Milano 1986 (si veda anche la trad. ingl. Aesthetics and Theory of Art,
transl. by S.A. Emery, foreword by Th. Munro, Wayne State University Press, Detroit 1970).
3 D’ora in poi indicata come «ZÄK». Dessoir la diresse fino al 1937, per poi passare il testi-
mone a Richard Müller-Freienfels, che la resse fino al 1943. Sulla rivista si veda Ästhetik in me-
taphysikkritischen Zeiten: 100 Jahre «Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft»,
hrsg. von J. Früchtl und M. Moog-Grünewald, Meiner, Hamburg 2007.
4 Cfr. G.W.Fr. Hegel, Estetica, ed. it. a cura di N. Merker, Einaudi, Torino 1963, p. 5.
8 Andrea Pinotti
l’esperienza della bellezza nulla hanno a che fare. Contro la duplice ridu-
zione della teoria dell’arte all’estetica e dell’arte alla bellezza si muove dun-
que il pensiero di Dessoir: estetico, artistico e bello non sono termini sino-
nimici e interscambiabili. Ciò va affermato con decisione per combattere
quella diffusa imprecisione nell’uso dei più basilari termini dell’estetica, che
proprio per la loro ovvietà e apparente semplicità ci conducono ad equivoci,
fraintendimenti, errori, falsi problemi.
Non quindi tanto un “e”, quanto piuttosto un “o” (o magari esplicita-
mente un “versus”, come più tardi avrebbe preferito Edgar Wind nel saggio
Teoria dell’arte vs estetica, incluso nella presente raccolta). Possiamo tutta-
via fin d’ora anticipare che, una volta consumato quel divorzio, vi saranno
buoni motivi per ricondurre a una fruttuosa relazione reciproca i due ambi-
ti: fruttuosa, però, solo perché nel frattempo sarà stata assicurata una chia-
rificazione concettuale, terminologica, metodologica, euristica delle rispet-
tive sfere di indagine.
Il terreno per la maturazione di quella disgiunzione era già stato disso-
dato nel corso della seconda metà dell’Ottocento5. La prima occorrenza
della formula allgemeine Kunstwissenschaft sembra essere scaturita dalla
penna dell’estetologo formalista di scuola herbartiana Robert Zimmermann
nel 18626. Ma già nel 1811 Carl Fr. Bachmann aveva pubblicato Die Kunst-
wissenschaft in ihrem allgemeinen Umrisse dargestellt. E nel 1845 Hermann
Hettner, in un saggio rivolto contro l’estetica speculativa di orientamento
metafisico7, aveva fondato su basi antropologico-fisiologiche la distinzione
fra un’estetica come dottrina della fantasia e una dottrina formale dell’arte
come esplorazione delle oggettivazioni concrete di quella fantasia, con-
dizionate dai materiali e dalle tecniche: una distinzione che non sfuggì al-
l’attenzione di Hugo Spitzer, che vi avrebbe dedicato nel 1903 un volu-
minoso studio critico impegnato nell’individuare motivi di separazione e
punti di connessione fra estetica e teoria dell’arte8.
Tuttavia, il vero e proprio atto di nascita della scienza dell’arte può esse-
re rintracciato negli scritti del teorico Konrad Fiedler: Utitz (nel secondo
suo testo che qui presentiamo) lo definirà «il padre della nostra moderna
scienza formale dell’arte». Fiedler – che insieme al pittore Hans von Marées
e allo scultore Adolf von Hildebrand viene abitualmente riconosciuto come
5 Per la genesi del concetto di scienza generale dell’arte cfr. W. Henckmann, Probleme der
allgemeinen Kunstwissenschaft, in Kategorien und Methoden der deutschen Kunstgeschichte, hrsg.
von L. Dittmann, Steiner, Stuttgart 1985, pp. 273-334, qui pp. 282-291.
6 Cfr. R. Zimmermann, Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft (1862), in Id., Stu-
dien und Kritiken zur Philosophie und Ästhetik, Braumüller, Wien 1870, Bd. I, p. 227.
7 Il testo di Bachmann uscì a Jena per i tipi di Cröker. Di Hettner cfr. Gegen die spekulative
Ästhetik (1845), in Id., Schriften zur Literatur, hrsg. von J. Jahn, Aufbau, Berlin 1959, pp. 17-
49, qui p. 43.
8 H. Spitzer, Hermann Hettners kunstphilosophische Anfänge und Literaturästhetik. Unter-
suchungen zur Theorie und Geschichte der Ästhetik, Leuschner & Lubensky, Graz 1903.
Introduzione 9
uno dei principali rappresentanti del cosiddetto purovisibilismo – aveva e-
sposto incisivamente in alcuni aforismi delle considerazioni su bello, arte,
ed estetica che sintetizzano i prodromi per lo sviluppo novecentesco della
questione9. La sua posizione può riassumersi in tre vigorosi “no”: 1) no
all’identificazione dell’artistico con il bello («Il proton pseudos nel campo
dell’estetica e della teoria dell’arte consiste nell’identificazione dell’arte con
la bellezza; come se l’uomo avesse bisogno dell’arte per farsi creare un
mondo del bello; è da questo primo errore che derivano tutti gli altri equi-
voci»); 2) no all’identificazione di estetica e filosofia dell’arte («Il problema
fondamentale dell’estetica è affatto differente da quello della filosofia del-
l’arte»; «le opere d’arte non devono venir giudicate sui precetti dell’esteti-
ca»); 3) no alla tirannia del bello («Tradizionalmente bello ed arte sono av-
vinti l’un l’altro, i loro effetti vengono confusi, si ascrivono all’arte effetti
che derivano unicamente dal bello, al bello effetti che possono essere causa-
ti solamente dall’arte»).
Ma se gli aforismi fiedleriani erano stati pubblicati postumi solo nel
1914 (nel secondo volume delle Schriften zur Kunst10 curate da Hermann
Konnerth, e quindi ben dopo il 1906, anno fatale della separazione tra este-
tica e scienza dell’arte), già nel primo importante saggio teorico di Fiedler,
dedicato al problema della Valutazione delle opere d’arte figurativa e uscito
nel 1876, si sollevava esplicitamente «la questione se la supposizione secon-
do cui tutta l’arte appartiene al campo di indagine dell’estetica sia giustifica-
ta, se essa non abbia nessun altro significato essenziale né altro scopo di
quello che l’estetica potrebbe assegnarle». «A ciò – continuava Fiedler – an-
drebbe aggiunta anche l’ulteriore questione se l’estetica, dovendo la sua esi-
stenza a un’esigenza di carattere spirituale del tutto diversa da quella del-
l’arte, possa spiegare le opere d’arte solo esteticamente, ma debba lasciarle
oscure dal punto di vista dell’arte; se inoltre le regole che l’estetica potrebbe
enunciare non siano solo di natura estetica, non però di natura artistica; e
se, infine, pretendere che la produzione artistica si debba indirizzare secon-
do le regole dell’estetica non significhi pretendere che l’arte cessi di essere
se stessa e si debba accontentare di fornire all’estetica esempi illustrativi»11.
In queste domande è possibile ravvisare, in nuce, la complessa costella-
zione di problemi che trent’anni dopo avrebbe innervato la decisione des-
soiriana di disgiungere l’estetica dalla scienza dell’arte. Certo, a prima vista
l’esigenza posta da Fiedler è quella di difendere l’autonomia della teoria
dell’arte (che per lui è innanzitutto arte figurativa, e questo imprinting con-
dizionerà come si vedrà lo sviluppo successivo della questione) dalle inde-
bite ingerenze dell’estetica: occorre cioè problematizzare quell’ovvietà che
9 Cfr. K. Fiedler, Aforismi sull’arte, trad. it. di R. Rossanda, introd. di V. Segre Rutz, Tea,
Milano 1994. Le citazioni che seguono sono tratte dagli aforismi 2, 6, 9, 29.
10 Dessoir recensisce l’edizione fiedleriana nella «ZÄK», 9, 1914, p. 568.
11 K. Fiedler, Sulla valutazione delle opere d’arte figurativa (1876), in Id., Scritti sull’arte fi-
gurativa, a cura di A. Pinotti e F. Scrivano, Aesthetica, Palermo 2006, pp. 36-37.
10 Andrea Pinotti
vorrebbe il significato dell’arte come significato estetico, i suoi scopi come
scopi estetici, i suoi contenuti come contenuti estetici, in una parola occor-
re mettere in radicale discussione l’idea di un’arte eterodiretta, diretta ap-
punto da una disciplina, l’estetica, che arte non è e che scaturisce da bisogni
affatto differenti da quelli artistici. Ma a ben vedere la distinzione dei piani
non apporta vantaggi solo per l’arte e per una teoria che sappia darne conto
senza sottomettersi a principi ad essa estranei, quali appunto quelli estetici;
anche l’estetica non potrà a sua volta che beneficiare dell’eliminazione di
inopportune commistioni con l’ambito dell’arte; e infine proprio la chiarifi-
cazione dei rispettivi domini potrà consentire di ricercare positivi punti di
contatto fra di essi.
Ma è evidente che un’adeguata comprensione dell’esigenza maturata da
Fiedler di separare l’ambito estetico da quello artistico dipende preliminar-
mente dall’accezione in cui tali concetti, in sé quanto mai polivoci, vengono
qui assunti: se da un lato estetica è per Fiedler il campo in cui si esercita il
giudizio di gusto, che giudica della bellezza di un oggetto in relazione al
sentimento di piacere che esso suscita nel soggetto che contemplandolo ne
gode, dall’altro l’arte (che per Fiedler, ripetiamolo, è essenzialmente arte fi-
gurativa) è innanzitutto configurazione di forme visive, che non sono ripe-
tizioni riproduttive di enti già esistenti, ma vengono per la prima volta al
mondo grazie al gesto dell’artista, che tramite le immagini che produce
chiarifica e approfondisce la sua conoscenza del mondo visibile.
Quanto di questo quadro concettuale trapassa nei teorici della scienza
generale dell’arte? Già nel 1891, in un articolo dedicato a Richard Wagner
estetologo, Dessoir aveva avuto modo di affermare esplicitamente quanto
perentoriamente: «Noi distinguiamo nettamente fra estetica e teoria dell’ar-
te»12, senza tuttavia approfondire in quella sede il senso di tale distinzione.
L’approfondimento sarebbe venuto con il lavoro del 1906, poi riedito nel
1923 con ampie modifiche: il saggio Scienza generale dell’arte del 1914, che
qui presentiamo, si colloca dunque in una posizione intermedia, e costitui-
sce un’efficace sintesi della prospettiva kunstwissenschaftlich dessoiriana.
Molte delle posizioni fiedleriane vengono condivise, a partire dall’esigenza
di operare delle preliminari precisazioni di campo (precisazioni che – è op-
portuno sottolinearlo con forza –, se oggi ci appaiono ovvie e consolidate e
pressoché universalmente accettate, all’epoca in cui Dessoir scriveva veni-
vano formulate con tale perspicuità per la prima volta):
1) il bello non coincide con l’estetico; l’estetico è campo più ampio del
bello, nel quale possiamo individuare almeno queste coppie di «categorie»
estetiche, di concetti cioè che esprimono delle valutazioni estetiche (Des-
soir le definisce ästhetische Grundgestalten, «forme estetiche fondamentali»,
12 M. Dessoir, Richard Wagner als Ästhetiker, in «Bayreuther Blätter», 14, 1891, p. 100.
Introduzione 11
e vi dedica il capitolo IV della sua Estetica e scienza generale dell’arte13): bel-
lo/brutto; carino/sublime; comico/tragico. L’estetico si profila dunque per
Dessoir come quell’insieme oggettivo di tratti che sono disponibili ad un
apprezzamento estetico: è necessità (è così e così configurato, e non po-
trebbe essere altrimenti) intuitiva (si offre all’apprensione dei sensi), nel-
l’ambito della quale il bello non è che una possibilità (anche se Dessoir, no-
nostante la sua polemica contro la «dittatura del bello» e la «callicrazia»,
ammette che forse è quella par excellence, meno compromessa con elementi
extra-estetici).
.
2) Il bello artistico non esaurisce il bello in generale Il bello non coinci-
de con l’artistico, poiché il bello dell’arte non esclude altre modalità della
bellezza: il bello naturale, le belle maniere, i corpi belli, le belle dimostra-
zioni matematiche…
3) Non tutto l’artistico è bello. Non tutte le arti, non tutti gli stili, pos-
sono essere compresi tramite la categoria di bellezza. Anzi, alcune manife-
stazioni artistiche (ad es. il Gotico, che esplorerà Wilhelm Worringer muo-
vendo dalle premesse teoretiche della scienza generale dell’arte14), non han-
no proprio nulla a che vedere con il bello. Resta vero, per Dessoir (e per
Worringer) che alcune opere d’arte, come quelle classiche, sembrano avere
con il bello un rapporto preferenziale: l’arte classica è l’arte bella per anto-
nomasia.
4) L’estetico non esaurisce l’artistico, come vorrebbe certo panesteti-
smo. L’arte non si limita a offrire occasioni di esperienza estetica, cioè di
fruizione sensibile, di godimento di situazioni che possono ingenerare sen-
timenti di piacere o dispiacere; la funzione estetica è solo una delle funzioni
che caratterizzano l’arte: la funzione spirituale (nelle sue relazioni con la
sfera complessiva della cultura e delle visioni del mondo, con il mito, la reli-
gione, la filosofia), quella sociale (la società condiziona tanto la creazione
quanto la fruizione dell’arte, che a sua volta può efficacemente agire sui
meccanismi sociali per le sue potenzialità pedagogiche, politiche, economi-
)
che , quella etica (il puro homo aestheticus è una chimera: le istanze etiche
condizionano il fruire e il fare arte, così come reciprocamente la dimensione
dell’artisticità si riverbera sulla sfera morale). Dessoir risolve dunque la
questione dell’essenza dell’arte in quella delle sue molteplici funzioni15, cui
13 Non potendo in questa sede entrare nel merito delle differenze fra la I e la II edizione, ci
riferiremo direttamente a quest’ultima nella trad. it. cit. (i curatori accennano alle principali
difformità fra le due versioni alle pp. 17-18 della loro introduzione).
14 «Il Gotico non ha nulla a che fare con la bellezza» (W. Worringer, Problemi formali del
Gotico (1911), ed. it. a cura di G. Frank e G. Gurisatti, Cluva, Venezia 1985, p. 14).
15 Negli stessi anni Cassirer andava risolvendo il concetto di sostanza in quello di funzione:
Sostanza e funzione: ricerche sui problemi fondamentali della critica della conoscenza (1910),
trad. it. di E. Arnaud, La Nuova Italia, Firenze 1999. Più tardi J. Muka(cid:284)ovský avrebbe tenuto
conto dell’approccio funzionalistico dessoiriano nel suo La funzione, la norma e il valore esteti-
co come fatti sociali (1936), nell’omonima raccolta di saggi, ed. it. a cura di S. Corduas, Einaudi,
Torino1971, pp. 35-131 (Dessoir è citato alle pp. 38 e 75, Utitz a p. 42). Si veda anche il saggio