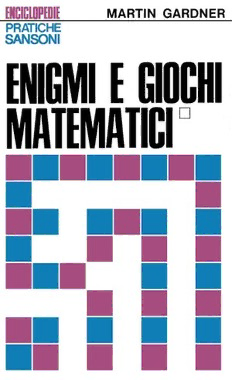Table Of ContentEnigmi e giochi
matematici
a cura di Martin Gardner
Sansoni
Titolo originale:
Mathematical puzzles and diversions
Simon and Schuster Inc.
New York
Copyright © 1959 by M. Gardner
Per il materiale pubblicato in « Scientific American »
Copyright © 1956-1958
Traduzione di Mario Carlà
I edizione nella « Biblioteca di Galileo » Aprile 1967
II edizione nella « Biblioteca di Galileo » Novembre 1967
Copyright © 1972 by G.C. Sansoni editore, nuova s.p.a., Firenze
Indice
Introduzione Pag. VII
1. GLI ESAFLEXAGONI 1
Appendice 7
2. MAGIA CON LE MATRICI 13
Appendice 18
3. NOVE PROBLEMI 20
Il ritorno dell’esploratore, 20 – Il poker a carte sco-
perte, 20 – La scacchiera mutilata, 20 – Il bivio, 21 –
Le scatole dall’etichetta sbagliata, 21 – Bronx contro
Brooklyn, 22 – Il taglio del cubo, 22 – Il viaggiatore
in anticipo, 22 – Le monete false, 23 – Risposte, 24.
4. FILETTO 32
Appendice 39
5. PARADOSSI DELLA PROBABILITÀ 40
6. IL GIOCO DELL’ICOSAEDRO E LA TORRE 47
DI HANOI
Appendice 51
7. STRANI MODELLI TOPOLOGICI 53
Appendice 60
Indice VI
8. IL GIOCO DELL’HEX 62
Appendice 66
Risposte 69
9. SAM LLOYD: IL PIÙ GRANDE ENIGMISTA
D’AMERICA 71
Appendice 78
Risposte 78
10. GIOCHI MATEMATICI CON LE CARTE 82
11. MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI 87
12. ALTRI NOVE PROBLEMI 93
Le sigarette che si toccano, 93 – I due traghetti, 93 –
Trovare la diagonale, 93 – L’abile elettricista, 93 – At-
traversamento di un reticolato, 95 – I dodici fiammi-
feri, 95 – Il buco della sfera, 95 – Le coccinelle inna-
morate, 96 – Quanti bambini?, 97.
Risposte 97
13. I POLIMINI 107
Appendice 121
14. INGANNI MATEMATICI 122
Appendice 128
15. NIM E TAC TIX 130
Appendice 139
Risposte 139
16. DESTRA O SINISTRA? 140
Appendice 146
Per chi volesse approfondire gli argomenti 150
INTRODUZIONE
Il lato divertente, che rende ricreativo il passatempo matematico,
può presentarsi sotto varie forme: un indovinello da risolvere, un
gioco competitivo, un trucco magico, un paradosso, un inganno o,
semplicemente, della matematica con ogni sorta di scherzi e curiosità
stimolanti. Sono, questi, esempi di matematica pura o applicata? È dif-
ficile dirlo. In un certo senso la matematica ricreativa è matematica
pura, non contaminata da criteri utilitaristici. In un altro senso è ma-
tematica applicata, in quanto soddisfa l’universale bisogno umano di
giocare.
Forse questo bisogno di giocare si nasconde anche nella matema-
tica pura. Non vi è molta differenza fra il piacere provato da un dilet-
tante nel risolvere un abile rompicapo ed il piacere che un matematico
prova nel dominare un problema più difficile. Entrambi guardano alla
bellezza pura, quell’ordine limpido, nettamente definito, misterioso,
estasiante che permea tutte le strutture. Non deve sorprendere, perciò,
che spesso sia difficile distinguere la matematica pura da quella ap-
plicata. il teorema delle carte a quattro colori, per esempio, è un
problema di topologia ancora insoluto, tuttavia lo si troverà discusso
in molti volumi di matematica ricreativa. Nessuno potrà negare che
i flexagoni di carta, argomento del capitolo iniziale di questo libro,
siano giochetti enormemente divertenti; tuttavia un’analisi della loro
struttura trasporta rapidamente nel campo della teoria superiore dei
gruppi. Articoli sui fiexagoni sono apparsi nelle riviste matematiche
piu’ specializzate.
I matematici creativi raramente si vergognano del loro interesse
verso argomenti ricreativi. La topologia ebbe origine dall’analisi di
un indovinello riguardante il passaggio di ponti fatta da Eulero.
Leibnitz dedicò parecchio tempo a studiare l’indovinello del salto dei
pioli che in tempi recenti ha avuto un ultimo ritorno sotto il nome
commerciale di « Provate il vostro quoziente di intelligenza ». David
Hilbert, il grande matematico tedesco, dimostrò uno dei teoremi
fondamentali nel campo degli indovinelli sulla divisione. A.M. Turing,
pioniere della teoria dei moderni calcolatori, discusse l’indovinello del
15 di Sam Lloyd (descritto nel Cap. 9) in un articolo sui problemi
solubili o insolubili. Mi è stato detto da Piet Hein (il cui gioco del-
VII
INTRODUZIONE
l’Hex è trattato nel Cap. 8) che quando egli visitò Albert Einstein,
trovò tutta una sezione della sua libreria piena di libri sui giochi
e indovinelli matematici. L’interesse di queste grandi menti nel diver-
timento matematico non è difficile da comprendere, dato che l’atti-
vità creativa del pensiero spesa per argomenti di questo tipo è dello
stesso genere di pensiero che conduce alla scoperta matematica e
scientifica. Cosa è la matematica, dopo tutto, se non la soluzione di
un indovinello? E cosa è la scienza se non uno sforzo sistematico
per ottenere sempre migliori risposte agli indovinelli posti dalla
natura?
Il valore pedagogico della matematica ricreativa è ora ampiamente
riconosciuto. Si riscontra un sempre crescente interesse per l’argo-
mento, nelle riviste pubblicate per gli insegnanti di matematica e nei
nuovi libri, specialmente quelli scritti secondo il punto di vista « mo-
derno ». L’« Introduzione alla matematica finita », per esempio, di
J. G. Kemey, J. Laurie Snell e Gerald L. Thompson, è vivificata da
molto materiale ricreativo. Questi argomenti attraggono enormemen-
te l’interesse dello studente. L’insegnante di matematica di scuola
superiore che rimprovera due studenti trovati a giocare di nascosto
una partita di filetto invece di stare attenti alla lezione farebbe meglio
a fermarsi e chiedersi: « Per questi studenti questo gioco è più inte-
ressante, dal lato matematico, di ciò che sto loro dicendo? ». In ef-
fetti, una discussione in aula sul filetto non sarebbe una cattiva
introduzione a diverse branche della matematica moderna.
In un articolo sulla « Psicologia della mania degli indovinelli »
(nella rivista « Diciannovesimo Secolo », Dicembre 1926) il grande
enigmista inglese Henry Ernest Dudeney si lamentava di due cose:
« La letteratura della matematica ricreativa, diceva, contiene una
quantità di ripetizioni e la mancanza di una bibliografia adeguata
forza gli appassionati a perdere tempo nell’ideare problemi già con-
cepiti da molto ».
Desidero ringraziare l’editore della rivista Scientific American,
G. Piel, e il suo direttore D. Flanagan, per avermi concesso il privi-
legio di poter comparire regolarmente fra la eletta compagnia dei
collaboratori alla rivista e per il permesso di raccogliere il risultato
dei miei sforzi nel presente volume. Sono grato anche alle migliaia
di lettori, di tutte le parti del mondo, che si son presi il fastidio di
richiamare la mia attenzione sugli errori (ahimè troppo frequenti) e
di darmi preziosi suggerimenti. In alcuni casi questa gradita reazione
VIII
INTRODUZIONE
è stata incorporata negli stessi articoli, ma nella maggioranza dei casi
è stata riunita in una aggiunta alla fine di ogni capitolo. Le risposte ai
problemi (quando necessarie) appaiono anche alla fine del capitolo.
Una bibliografia selezionata per ulteriori letture si trova alla fine
del volume.
Non posso trascurare di ringraziare mia moglie, non solo per il
competente e graziosamente ironico lavoro di rilettura delle bozze, ma
anche per la sua pazienza durante quei momenti insopportabili di
meditazione matematica durante i quali io non sentivo cosa mi stesse
dicendo.
Martin Gardner
IX
1
GLI ESAFLEXAGONI
I flexagoni sono poligoni di carta ottenuti piegando strisce di
carta diritte o ripiegate, che hanno l’affascinante proprietà di cam-
biare le loro superfici esterne quando vengono « flessi ». Se non fosse
stato per la banale circostanza che i foglietti dei blocchi di appunti
inglesi ed americani non hanno le stesse dimensioni, forse i flexagoni
non sarebbero ancora stati scoperti ed un buon numero di matematici
di alto rango sarebbe stato privato del piacere di analizzare le loro
curiose strutture.
Tutta la faccenda cominciò nell’autunno del 1939. Arthur H. Stone,
un laureato di provenienza inglese, residente all’Università di Prin-
ceton per una borsa di studio in matematica, aveva ritagliato un paio
di centimetri del margine dei foglietti del suo blocco di appunti per
poterlo inserire nel suo raccoglitore inglese. Per divertimento comin-
ciò a piegare in vari modi le strisce di carta ed una delle figure ri-
sultò particolarmente misteriosa. Egli aveva piegato la striscia diago-
nalmente in tre punti ed aveva unito le estremità in modo da formare
un esagono (fig. l). Quando pizzicava la superficie in modo da far
combaciare due triangoli adiacenti e spingeva lo spigolo opposto verso
il centro, l’esagono si apriva di nuovo, come un fiore in boccio e mo-
strava una faccia completamente nuova. Se, per esempio, le facce
superiore e inferiore erano state colorate differentemente, la faccia
nuova risultava bianca ed una delle facce colorate spariva!
Questa struttura, il primo flexagono ad essere scoperto, ha tre
facce. Stone ci ripensò sopra la notte ed il giorno dopo trovò la
conferma della sua convinzione (raggiunta per via puramente specu-
lativa) che si potesse ottenere per piegamento un modello esagonale
più complicato, con sei facce anziché tre sole. A questo punto Stone
trovò la struttura cosí interessante che mostrò i suoi modelli di carta
ai colleghi di corso. Immediatamente i « flexagoni » cominciarono ad
apparire a profusione sui tavoli all’ora di colazione e pranzo. Un « Co-
mitato dei flexagoni » venne organizzato per esplorare più profonda-
mente i misteri della « flexagonazione ». Gli altri membri, oltre Stone
erano Bryant Tuckerman, un laureando in matematica; Richard P.
1
ENIGMI E GIOCHI MATEMATICI
Fig. 1. Il triesaflexagono si costruisce tagliando una striscia di carta in modo
che possa essere suddivisa in 10 triangoli equilateri (A). La striscia è ripiegata
su se stessa lungo la linea ab (B). Successivamente viene ripiegata ancora
lungo la linea cd e il penultimo triangolo portato a coincidere con il primo (C).
L’ultimo triangolo viene ripiegato e incollato sulla faccia posteriore del primo
(D). La figura può ora essere « flessa » come mostrato in fig. 3. Conviene usare
della carta abbastanza spessa larga 3-4 centimetri.
Feynmann, un laureando in fisica e John W. Tukey, un giovane assi-
stente di matematica.
I modelli furono chiamati esaflexagoni: « esa » per la loro forma
esagonale e « flexagoni » per la loro attitudine a venir « flessi ». Il
primo modello di Stone è un triesaflexagono (« tri » per le tre dif-
ferenti facce che possono esser presentate); la sua elegante seconda
struttura un esaesaflexagono (per le sue sei facce).
Per costruire un esaesaflexagono cominciate con una striscia di
carta (quella dei rotoli per macchine addizionatrici va benissimo) di-
2