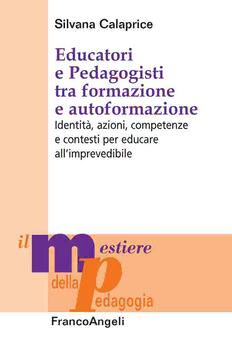Table Of ContentSilvana Calaprice
Educatori
Pedagogisti
e
tra formazione
autoformazione
e
Identità, azioni, competenze
contesti educare
e per
all'imprevedibile
es’stlere
FrancoAngeli
Isbn 9788835109310
Copyright © 2020 byFrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.
Ristampa Anno
0123456789 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
L’opera, comprese tutte le sue parti, ètutelata dalla legge sui diritti dautore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ognimodo e forma
(comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione
(ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la
rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi econ qualsiasi modalità attualmente nota
o in futuro sviluppata).
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4e 5,della legge 22
aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o
commerciale ocomunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di
specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni
Editoriali (www.clearedi.org: e-mail [email protected]).
Stampa: Global Print, via DegliAbeti 17/1, 20064 Gorgonzola (MI).
Ragioni pag. 9
Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti
.
abilitati. Scenari storico-sociali, formativi e legislativi
tra passato e... futuro »)
Introduzione >»)
1.l. Cambiamenti sociali e nuovi bisogni educativi
dagli anni ’60 in poi »)
1.2. leri. Dagli anni ’60 agli anni ’90: perché, quando e dove
educatori e pedagogisti ))
1.3. La formazione dal ’90 in poi: confusione, anomalie,
ma anche consapevolezza professionale »)
1.4. Le professioni non organizzate e l’accesso alla professione:
la Legge n. 4/2013. La spinta europea »
1.5. Le Leggi 205/17 e 145/18: il riconoscimento giuridico
di educatori e pedagogisti ») 33
1.6. Il lavoro del CONCLEP e non solo: tra un’anomalia
e l’altra sì sta raggiungendo l’obiettivo >») 40
1.7. L'articolo 33-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104:
le funzioni e il ruolo dell’educatore socio-pedagogico
nei presidi socio-sanitari e della salute >»)
La Pedagogia e la sua identità epistemologica
.
in movimento. ll sapere-agire professionale
come mediazione tra teoria e prassi
Introduzione 45
2.1. La pedagogia e la sua epistemologia in cammino.
Alla ricerca di simbiosi tra teoria e pratica » 46
n
2.1.1. La natura della pedagogia pag. 49
2.1.2. L'oggetto della pedagogia: la formazione educante 50
2.1.3. I costrutti del saper agire pedagogico:
l’aver cura e la relazione educativa 53
2.1.4. Dai costrutti alle pratiche: le competenze relazionali 56
2.2. Un diverso agire pedagogico per una nuova comunità
educante. Ripartiamo dalla politica e dal concetto
di democrazia 58
2.2.1. Partecipazione 61
2.2.2. Responsabilità, rispetto e solidarietà 63
2.2.3. Le dimensioni della libertà-autorità 64
2.3. Il modello educativo per un agire professionale competente 66
2.4. La pedagogia in cammino per... trans-formare 70
Il formare e il formarsi dei professionisti pedagogici.
.
Dalla trasmissione del sapere all’apprendimento
del progetto esistenziale di vita: /ifedeep learning 72
Introduzione 72
3.1. L’educazione permanente come spinta al cambiamento
di rotta formativa: l'apprendimento 73
3.2. Dall’apprendimento psicologico all’apprendimento pedagogico » 7]
3.3. Il sapere-agire pedagogico parte dall’esperienza educativa 81
3.4. L’intelligenza emotiva come forza motrice
dell’apprendimento significativo 83
3.5. Metodo autobiografico 86
3.6. Come formarsi e trans-formarsi? Un’avventura intellettuale 89
Il professionista pedagogico riflessivo e trans-formativo:
.
dalle competenze alla performance professionale
attraverso l’expertise. Seguiamo l’Europa 90
Introduzione 90
4.1. Capacità/conoscenze, abilità e competenze:
QEQ, ECVET e ECTS » 9]
4.2. Le competenze di ruolo dell’educatore professionale
socio-pedagogico e del pedagogista abilitato » 95
4.2.1. Le competenze trasversali pag.
4.2.2. La metacognizione per la capability of agency >»)
4.3. Dalla professione alla professionalità: il sé professionale
e le core competences pedagogiche dei professionisti
dell’educazione >»)
4.3.1. Perché il tirocinio >»
4.4. Parliamo di Volti >)
| contesti e le azioni professionali. La scuola e i servizi
.
socio-sanitari »
Introduzione >»)
5.1. I contesti e i servizi educativi »)
5.2. Le professioni pedagogiche: le aree, le azioni educative
e le condizioni di intervento »)
5.3. La scuola >)
5.3.1. Le competenze dell’educatore scolastico
socio-pedagogico >»
5.3.2. Le competenze del pedagogista scolastico »
5.3.3. Le competenze dell’educatore 0-6 anni »
5.4. Le competenze dell’educatore professionale socio-pedagogico
che lavora nei contesti socio-sanitari e della salute »)
5.5. Work in progress: ri-educhiamo a cercare il senso delle cose ))
Allegato A >»)
Bibliografia »
Ognunoè quello che fa e che sa di essere.
Heidegger
Questo volume autobiografico! mira a unificare quanto, durante le mie ri-
cerche sulle professioni educative, sono andata approfondendo e realizzando,
1. Il mio interesse per le professioni educative nasce durante il periodo della mia formazione
universitaria. Mi sono laureata agli inizi degli anni ’70 in Pedagogia con la prof.ssa Edda Ducci
di cui ho fortemente subito il fascino culturale negli anni in cui insegnava alla facoltà di Magiste-
ro dell’Università degli Studi di Bari (1968-1981). Oggi posso dire, riprendendo Cambi,
mentre culturalmente viveva due fasi distinte e collegate insieme. Quella connessa alla filosofia teoretica,
sviluppata in ambito storico-antico in particolare. Quella di “svolta” alla pedagogia, che si sviluppa dagli
anni Sessanta fino alla morte e che dà corpo a una filosofia dell'educazione in chiave metafisico-antropologi-
co-esistenziale di alto profiloe di radicale coerenza. La “svolta” si produce come ripresa critica di problemi
educativi [...], tra il 1958 e il ’62, vissuti dentro un agire cattolico impegnato e convinto, poicome ripresa
dell’esistenzialismo metafisico di Fabro (presso cui fu assistente aRoma) attraverso l'inquieto pensiero di
Kierkegaard, di cui sottolinea proprio la dimensione maieutica (Cambi, 2018, p. 118).
Ed è nella fase della svolta pedagogica che il Suo pensiero critico, riflessivo e lungimirante,
ha giocato un ruolo fondamentale nella delineazione del mio successivo profilo di ricercatrice. La
mia tesi dal titolo // rapporto educatore-educando negli istituti assistenziali — tesi anacronistica
in un tempo in cui le teorie e le pratiche pedagogiche concentravano ipropri interessi sull’unico
contesto educativo riconosciuto in quanto tale: la scuola — rappresentava il bisogno di analizza-
re e studiare le problematiche educative che dopo il 1968 emergevano dalle istituzioni sociali,
socio-sanitarie, socio-assistenziali e che le Sue lezioni interpretavano in tutta la loro complessi-
ta. Istituzioni denominate allora genericamente extrascolastiche e che per questo esplicitavano il
bisogno di un professionista dell’educazione che non fosse solo l'insegnante e di una riflessione
pedagogica innovativa. La Sua filosofia dell'educazione attraverso i temi dell’intersoggettività,
la relazione io-tu, la parola che educa, il dialogo (Kierkegaard, Buber, Sartre), comunicando il
«travaglio dell’educarsi/formarsi» (ibidem), sollecitava così già da allora la pedagogia a trovare
risposte su «come applicare iprincipi teorici della filosofia dell'educazione alle diverse e nuove
emergenti pratiche educative, su come imodelli educativi teorici potevano e dovevano conciliar-
si con inuovi bisogni educativi che si presentavano sempre più complessi e differenziati» e sul
«se e come formare nuove figureprofessionali» (Ducci, 1967; 1972; 1999). Da allora a oggi mol-
ti gli sviluppi teorico-pratici e di cambiamento epistemologico che il mondo pedagogico ha rea-
lizzato in tal senso e che mi hanno vista accompagnare scientificamente, anche attraverso molti
miei contributi, tale processo. Ma anche molte, ancora, le nuove domande cosi come è giusto che
una scienza sull’uomo faccia.
e quale, relativamente al riconoscimento giuridico di questi professionisti, sia
stata la mia attenzione politica.
Il bisogno di presentare nel 2020 un quadro d’insieme sulla loro identità sto-
rica, epistemologica e legislativa ha come obiettivo legittimare:
e ilperche e la natura scientifica di educatori professionali socio-pedagogici
e pedagogisti abilitati;
* laformazione e le competenze che avvallano la loro professionalità;
* ilcome, in che modo e dove aiutano soggetti e comunità a far fronte anche
alle imprevedibilità (Pollo, 2020) a cui periodicamente la vita ma anche le
società, nella loro evoluzione, hanno esposto e espongono i soggetti e le
comunità.
Questa crisi, infatti, afferma Pollo (2020)
[...] è un passaggio ulteriore in una società post-industriale che rispetto a quelle pre-
cedenti non ha un modello teorico e vive un disorientamento totale. Di certo stiamo
capendo che il modello per il futuro ha come pilastri la tecnologia e la globalizzazione
e abbiamo il beneficio di capire che siamo in un grande vicinato unico in cui le cose
risuonano in modo rapido. Ma gli eventi che stiamo vivendo ribaltano la nostra convin-
zione legata a una sorta di positivismo/determinismo secondo il quale certe azioni nel
presente sono in grado di determinare e “controllare” il futuro. Già Euripide sosteneva
che, al conosciuto, un dio all’improvviso apre la via allo sconosciuto, all’imprevedibile.
Imprevedibilità che appartiene alla vita e alle esperienze di ogni soggetto e
che non può essere ignorata durante tutti iprocessi educativi e formativi, perché
non tutto può essere sotto il controllo umano, anche se tutto può essere affron-
tato, gestito e metabolizzato.
Fare 1conti con il tasso di imprevedibilità della vita umana ci introduce a un altro con-
cetto smarrito: il senso del limite. Due sono i limiti naturali e inderogabili che segnano
la nostra vita: nascita e morte [...]. Stiamo riscoprendo la nostra fragilità umana, il
nostro essere vulnerabili eaccomunati, tutti, da una finitezza che dobbiamo accettare.
Pensiamo di essere forti perché rimuoviamo questa condizione, mentre è solo accettan-
dola che potremo far maturare in noi una nuova umanità e un’autentica forza (Pollo,
2020).
[...] questa crisi è antropologica: ci rivela il lato debole e vulnerabile della formidabile
potenza umana, ci rivela al tempo stesso che l'unificazione tecno-economica del globo
ha creato non solo un’interdipendenza generalizzata, ma anche una comunità di destino
senza solidarietà (Morin, 2020).
10