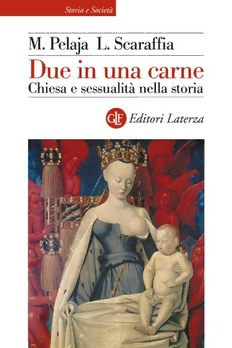Table Of ContentPelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina I
Storia e Società
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina II
© 2008, Gius.Laterza & Figli
Prima edizione 2008
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina III
Margherita Pelaja Lucetta Scaraffia
Due in una carne
Chiesa e sessualità nella storia
Editori Laterza
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina IV
Referenze iconografiche Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Fig. 1: © Contrasto
Fig. 2: Per gentile concessione della Finito di stampare nel luglio 2008
Soprintendenza BAPPSAE dell’Umbria SEDIT - Bari (Italy)
Fig. 3: © 1999. Foto Scala, Firenze per conto della
Fig. 4: © Contrasto Gius. Laterza & Figli Spa
Fig. 5: © 1990. Foto Scala, Firenze ISBN 978-88-420-8739-7
Fig. 7: © Contrasto
Fig. 8: Su concessionedel Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
©1990. Foto Scala, Firenze
Fig. 9: MSK Ghent, photo
©Lukas-Art in Flanders vzw
Fig. 10: Su concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
©2007. Foto Scala, Firenze
L’Editore è a disposizione di tutti È vietata la riproduzione, anche
gli eventuali proprietari di diritti parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
sulle immagini riprodotte, là dove compresa la fotocopia, anche
non è stato possibile rintracciarli ad uso interno o didattico.
per chiedere la debita autorizzazione. Per la legge italiana la fotocopia è lecita
solo per uso personale purché
non danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto
di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo
di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina V
Introduzione
DUE IN UN LIBRO
Due nomi, due biografie, due passioni intellettuali. Sono mol-
ti i libri che affiancano autrici e autori diversi in una stessa pro-
spettiva di ricerca, in un comune progetto conoscitivo.
In questo libro le differenze tra le autrici sono più profonde,
perché toccano la concezione stessa dell’oggetto di indagine; ma
aggiungono senso alla ricerca, perché si propongono di mostrare
la possibilità di confrontare, interrogare – mai contrapporre ideo-
logicamente e mai mediare per opportunità politica – due visioni
diverse nella sostanza. E il lavoro comune si basa su una condivi-
sa volontà di riesaminare e verificare stereotipi acclamati, come
quello che il cristianesimo prima, e la Chiesa cattolica poi, siano
caratterizzati da una sostanziale sessuofobia. Si basa anche sulla
fiducia – che qui diventa una concreta scommessa – che un lavo-
ro di ricerca storica possa essere svolto insieme da due studiose
che pure si collocano su posizioni ideologiche per alcuni aspetti
opposte.
Margherita Pelaja è laica. Storica e militante femminista negli
anni Settanta, ha progressivamente saldato interessi scientifici e
passione politica nel progetto e nell’esperienza della storia delle
donne. Insieme con altre studiose ha fondato nel 1981 «Memo-
ria», una rivista importante nel panorama dei gender studiesin Ita-
lia, e più tardi la Società italiana delle storiche. Ha orientato le sue
ricerche soprattutto sull’interazione di donne e famiglie con la
giustizia e gli apparati giudiziari tra Sette e Novecento, privile-
giando i conflitti che avevano al loro centro questioni sessuali.
Nello studio dello Stato pontificio ha così potuto analizzare le po-
litiche delle diverse istituzioni ecclesiastiche nelle loro articola-
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina VI
VI Introduzione. Due in un libro
zioni storiche, scegliendo – pur con una certa inquietudine – di
non prendere in considerazione le critiche di chi ritiene parziale
o addirittura fuorviante un’analisi che non comprenda in sé la di-
mensione spirituale e la questione della fede.
Lucetta Scaraffia condivide la lunga pratica di storia delle don-
ne e di femminismo, ma da circa vent’anni è tornata a sentirsi ap-
passionatamente cattolica, e quindi ad affiancare alla sua attività
di ricerca sulla storia delle donne e della vita religiosa un impegno
culturale che si può definire militante. Oggi, oltre a insegnare Sto-
ria contemporanea all’Università di Roma «La Sapienza», è mem-
bro del Comitato nazionale di bioetica. Il suo impegno culturale
e quello religioso si fondono quindi in molti suoi libri e articoli,
ma sempre con l’avvertenza di non piegare la realtà studiata a
obiettivi ideologici, con la certezza che solo una onesta conoscen-
za della storia può permettere di capire il presente, anche per in-
tervenirvi polemicamente.
Esaurite le presentazioni, possiamo cominciare a esprimerci al
plurale, usando un «noi» che indica la convinzione che fosse non
solo possibile, ma anche fecondo e stimolante, scrivere insieme un
libro che non c’era: la ricostruzione di lungo periodo del discorso
e della politica della Chiesa sulla sessualità. Una ulteriore ragione
è la complementarietà delle nostre direzioni di ricerca: più socia-
le quella di Margherita Pelaja, più culturale e teorica quella di Lu-
cetta Scaraffia.
Le ricerche finora disponibili sul tema che affrontiamo sono
infatti indagini dettagliate su contesti specifici e cronologicamen-
te delimitati; oppure sintesi su singoli aspetti della sessualità (la
contraccezione, la masturbazione); o ancora testi che con una cer-
ta frettolosità divulgativa sembrano partire tutti da assunti ideo-
logici preconfezionati, da ribadire soltanto nel corso dell’esposi-
zione. E, più in generale, sembrano confermare un’antica dicoto-
mia, prendendo in esame le norme da una parte, e i comporta-
menti – preferibilmente «devianti» – dall’altra, trascurando tra
l’altro quello che per Michel Foucault era l’aspetto centrale di uno
studio sulla sessualità: il discorso prodotto sul tema, che com-
prende anche gli aspetti simbolici, l’arte, l’immaginario.
Ci sembrava importante, come abbiamo detto, porre in que-
stione soprattutto il pregiudizio più diffuso e radicato: quello che
attribuisce alla Chiesa cattolica un’antica e lineare sessuofobia,
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina VII
Introduzione. Due in un libro VII
che si dipana nel corso dei secoli in un atteggiamento repressivo
costante e generalizzato. Il luogo comune è solido: per il cattoli-
cesimo il piacere è colpa, il sesso è peccato. Da praticare con par-
simonia e disagio esclusivamente nel matrimonio, e principal-
mente per procreare. Non tutto del luogo comune va sfatato; al-
cuni enunciati si ripetono nel corso del tempo nella predicazione
cattolica, fino a rendere possibile una sintesi così brutale. Ma sen-
sibilità più libere, analisi circostanziate dei testi e delle politiche
possono di volta in volta articolare, smentire, porre in relazione
con territori e finalità diverse, fino a sgretolare forse il potenziale
interpretativo di un assunto così generico.
Sul piano teologico va richiamato subito per esempio il modo
completamente nuovo con cui il cristianesimo affronta il proble-
ma del rapporto sessuale: il rapporto sessuale fra una donna e un
uomo deriva dall’Incarnazione, è metafora del rapporto fra l’ani-
ma e Dio, fra la Chiesa e Cristo, anticipo del piacere d’amore che
si vivrà in paradiso. E poiché l’Incarnazione promuove il corpo al-
lo stesso livello dello Spirito, all’atto sessuale viene dato un signi-
ficato spirituale inedito, che lo carica di un’importanza e di una
luce che lo assolvono, per sempre, dal sospetto e dal disprezzo con
cui lo guardavano, per esempio, gli stoici. Ne deriva una conse-
guenza fondamentale: se il rapporto sessuale è pervaso di signifi-
cati spirituali, esso deve essere privato dell’aspetto ludico che lo
aveva contrassegnato nel mondo pagano, e soprattutto deve venir
regolamentato con attenzione e severità. La storia della genesi e
delle contraddizioni che di volta in volta si addensano su tale re-
golamentazione è anch’essa ricostruita in questo libro. Non sem-
pre infatti l’unità indissolubile fra anima e corpo che caratterizza
la visione cristiana viene rispettata; la tentazione di giocare lo spi-
rito contro la carne segna periodi e figure della storia della Chie-
sa, pur non determinandone in modo continuativo l’impronta cul-
turale e morale.
Ci siamo mosse quindi cercando di affiancare l’indagine sulle
Scritture, sui trattati, sulle opere di formazione del clero e dei fe-
deli alla verifica di quanto di quei testi trovasse applicazione nel
governo delle anime, e in che modo. Una prospettiva questa che
ha contribuito a definire l’architettura di tutto il nostro libro,
chesi compone di capitoli insieme tematici e cronologici. Non ab-
biamo considerato però la cronologia come una gabbia rigida, ma
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina VIII
VIII Introduzione. Due in un libro
abbiamo preferito ampliare di volta in volta la trattazione dei sin-
goli temi con ampi flashback oppure con anticipazioni sul futuro,
scegliendo di privilegiare l’interpretazione anche a scapito del ri-
spetto di una periodizzazione predefinita. Si trattava insomma di
individuare ciò che in ogni epoca storica ha contraddistinto l’at-
teggiamento del cristianesimo prima e della Chiesa cattolica poi
verso i molteplici aspetti della sessualità umana e – come in ogni
ricerca storica – di dar conto di tali tratti distintivi nelle trasfor-
mazioni, nelle permanenze, nelle flessibilità.
Alle fondamenta della morale sessuale cristiana – dalle Scrit-
ture alla patristica – è dedicato il capitolo d’inizio, che copre tut-
to il primo millennio; il capitolo successivo, sui simboli e l’imma-
ginario, si sofferma sulla disinvoltura con cui – sulla scorta del
Cantico dei cantici– la cultura cristiana ha usato per secoli ardite
metafore sessuali per trattare del rapporto dell’anima con Dio,
raggiungendo vette stilistiche importanti con i mistici. Allo stesso
modo, fino al Cinquecento, l’arte rappresenta con simboli sessua-
li dogmi teologici, come quello della vera umanità di Cristo, ri-
tratto a questo fine con l’organo sessuale in erezione.
La cesura è operata dalla Riforma, che denuncia la corruzione
e il lassismo della Chiesa di Roma anche nel campo della morale
sessuale. Si aprirà da qui una lunga stagione densa di contraddi-
zioni, nella quale il cattolicesimo amplierà e perfezionerà il pro-
prio apparato normativo accentuando il rigore degli enunciati e
mettendo in atto nello stesso tempo strategie articolate di con-
trollo e tolleranza.
È il lento processo del disciplinamento, che prende le mosse
dagli ultimi secoli del Medioevo per protrarsi almeno fino al Set-
tecento. Centrato su due strumenti decisivi, il diritto e la confes-
sione auricolare, il disciplinamento si propone di definire gli am-
biti e le forme entro cui può esprimersi la sessualità, e di affinare
i dispositivi più adatti a saldare la presa sulle coscienze dei fedeli.
Ma è anche la stagione della politica. Una politica della ses-
sualità che deve esibire la capacità della Chiesa di governarei com-
portamenti dei fedeli: si articolano allora gerarchie e responsabi-
lità, affidando ai parroci e ai confessori il compito di temperare
l’universale intransigenza delle norme con le necessità quotidiane
e particolari della carne e del desiderio. Flessibilità e pragmatismo
diventano così le chiavi di volta di un sistema di controllo che
Pelaja-Scaraffia.qxp 15-07-2008 12:56 Pagina IX
Introduzione. Due in un libro IX
mentre ripete condanne assolute – della masturbazione, della so-
domia, della prostituzione – alterna repressione e clemenza, aven-
do ben cura di instillare e rafforzare nelle coscienze quel senso del
peccato e della colpa che garantisce la perpetua soggezione delle
anime.
È un sistema raffinato, capace di funzionare per secoli e di re-
sistere alle sollecitazioni più diverse fino a quando un altro pro-
cesso – che gli storici hanno chiamato modernizzazione – ne in-
crinerà le basi, facendo emergere nuove agenzie che contesteran-
no alla Chiesa il monopolio sulla morale sessuale.
Il conflitto nasce alla fine del Settecento e si inasprisce nel se-
colo successivo, quando il discorso sulla sessualità viene attribui-
to all’esclusiva competenza di medici, biologi, antropologi e poi
psicoanalisti. I nuovi scienziati negheranno alla Chiesa il diritto di
imporre norme universali e ai teologi la capacità di definire il sen-
so e il valore dell’atto sessuale, ai loro occhi ormai depotenziato
di ogni significato spirituale. Mentre molti Stati e molte leggi si
proporranno di erodere la sovranità esclusiva del diritto canoni-
co sui comportamenti sessuali.
La contesa non occupa soltanto il terreno della teoria, ma è an-
zi l’eco di sommovimenti profondi, che toccano gli assetti sociali,
economici e culturali di tutti i paesi occidentali: dalla rivoluzione
demografica ai mutamenti culturali indotti dall’Illuminismo, dal-
l’affermarsi dell’individuo come soggetto di diritti al fatto che il
sesso viene progressivamente sottratto alla dimensione religiosa
per essere studiato come fenomeno scientifico. Non è un caso che
il termine «sessualità» venga coniato solo nell’Ottocento: vi fece-
ro ricorso in un primo tempo zoologi e botanici, in seguito venne
usato per classificare il comportamento sessuale degli esseri uma-
ni secondo gli stessi metodi usati per studiare animali e piante, fi-
no ad arrivare, negli anni Sessanta del Novecento, alle ricerche di
un entomologo, il dottor Alfred Kinsey, che i mass media faranno
diventare un vero e proprio guru della sessualità.
Il controllo delle nascite ha costituito quindi l’oggetto di una
lunga contesa che ha diviso società e Chiesa a partire dall’Otto-
cento. Il suo rifiuto da parte della Chiesa è stato sancito da ben
due encicliche: Casti connubiidel 1930 e Humanae vitaedel 1968,
che ribadiscono la ferma opposizione della Chiesa alla separazio-
ne fra sessualità e riproduzione. Abbiamo scelto come termine