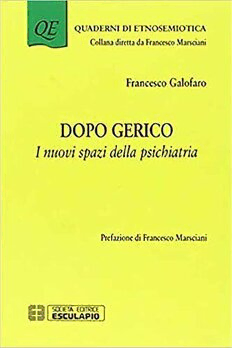Table Of Content- - -,.
QUADI-RNI DI I:. fNOSl.\110ìlCA
C.011.inJ dirc-11.1 d.1 Fr .tn<No ~1.anci.ln,
Francesco G31ofa ro
DOPO GERICO
spazi della psicl1iatria
J 111,ovi
111
Indice
Prefazione (di Francesco Marsciani). .................................. v
Introduzione ..................................................................... 1
Dopo Gerico ................................................................ 1
L'associazio11e AR.TS.AM - DDN. ................................. 4
La collaborazio11e co11 CUBE ....................................... 5
L.a ricerca. .................................................................... 6
Questio1ù scie1rtificlle .................................................. 7
Metodo ....................................................................... 8
Funzioni attanziali, ruoli tematici, attori .................... 11
L'et:11osemiotica .......................................................... 12
Ringraziamenti .......................................................... 15
Parte I. Analisi semiolinguistica ....................................... 17
Strutttlre discorsive .................................................... 18
Regimi della temporalità. ........................................... 19
Rapporti di omologazione ......................................... 20
Costruzioni impersonali ............................................. 21
Individuale/collettivo ................................................. 22
Gli spazi del racco11to ................................................ 23
Dentro e fuori. ........................................................... 24
Gli spazi it1ter1tl ......................................................... 26
Parte II. Dall'analisi semiolinguistica all'indagine
etnosemiotica .................................................................. 27
Un bilancio parziale ................................................... 27
Li11guaggio e patologia. .............................................. 27
La casa protetta come eterotopia ............................... 29
La casa protetta come dispositivo modale .................. 30
Forme della soggettività ............................................. 3 2
Il dialogo con la psicologia ........................................ 3 5
Emosentiotica. Presupposti ........................................ 3 7
IV
Parte III. Osservazioni etnosemiotiche ............................ 41
I problemi da risolvere ............................................... 39
Metodi ...................................................................... 40
Spazi .......................................................................... 42
Il problema del destinante ......................................... 43
Il potere del destinante .............................................. 46
La programmazione spaziale ...................................... 48
Spazi ester11i ............................................................... 48
Le ville al mare .......................................................... 4 9
Gli appartamenti al mare ........................................... 5 O
Il rifugio monta110 ..................................................... 50
Spazi i11ter11i ............................................................... 51
Lo spazio montano: crisi della programmazione ........ 53
Discussione conclusiva .................................................... 67
Le case come dispositivi modali ................................. 57
Dispositivi ed individuazione ..................................... 5 9
Dimenticare Foucault? ............................................... 59
La nozione di scientifiàtà .......................................... 61
Per una nozione non-antropomorfa
di i11tersoggettività ..................................................... 62
Il ricercatore ed il campo di osservazione .................. 63
Strutture patologiche? ............................................... 65
Né custodire né curare. .............................................. 67
Bibliografia ..................................................................... 71
Quaderni di Etnosemiotica è una collana scientifica. Affida
la valutazione della qualità dei lavori pubblicati alla discus
sione pubblica e alle recensioni. Non si affida ad altre for
me di giudizio preliminare (in particolare anonime), che
non siano le decisioni editoriali sotto la responsabilità
esplicita del direttore.
V
Prefazione
Il testo di Francesco Galofaro, terzo numero della colla
na dei Quaderni di etnosemiotica, affronta un tema di
forte impatto culturale e politico sul quale l'autore mette
alla prova gli strumenti della semiotica e l'osservazione
etnosemiotica nel tentativo di ottenere un incremento di
comprensione e di capacità valutativa dei fenomeni. Si
tratta, come si evince dal titolo, dei nuovi tipi di tratta
mento del disagio psichico risultanti dalla caduta delle
mura manicomiali, in virtù della legge Basaglia del '78, e
inevitabilmente inseriti, in una qualche misura e secondo
modalità variabili, all'interno delle reti costitutive della
socialità quotidiana, attraverso strutture ricettive calate
nel territorio e apparati di cura e sostegno socialmente
trasparenti e tendenzialmente condivisi.
L'analisi di Galofaro profitta di un'astuzia: non si tratta
di descrivere semplicemente quel che avviene, quel che
si può osservare recandosi nei luoghi di residenza di
quelli che sono diventati "utenti" delle strutture di cura,
bensì di mettere in comparazione tra loro luoghi diversi
nel momento della trasformazione stessa, ovvero di ten
tare di trarre suggerimenti per l'analisi dall'apprezza
mento in vivo delle trasformazioni, più o meno critiche,
di questi stessi luoghi al momento del trasferimento dal
le case abituali a quelle dedicate ai momenti di villeggia
tura (mare e montagna), scommetendo sulla rilevanza
delle tattiche di riaggiustamento del valore della spazia
lità abitativa e sull'emergenza di valorizzazioni significa
tive delle articolazioni concrete di questa stessa spaziali
tà. I trasferimenti, ci dice l'autore, non sono indolori e i
Vl
nuovi spazi in cui trascorrere alcune settimane all'anno
richiedono una nuova taratura dei valori (che sono per
più valori modali) legati all'appropriazione di porzioni
di spazio da parte di ciascuno, sia dal lato dell'utenza
che da quello degli addetti all'assistenza. Gli spazi ap
paiono immediatamente come spazi del vissuto e luoghi
per strategie di privatizzazione o, al contrario, messa in
comune, condivisione, di quell'ambiente che è destinato
a diventare mondo della nuova quotidianità.
Il procedimento, inoltre, accosta due diversi approcci
che diventano complementari per la descrizione dei fe
nomeni in questione: da un lato Galofaro lavora sulle
trascrizioni di interviste e conversazioni con gli utenti,
traendone un'importantissima indicazione, quella per la
quale l'analisi degli enunciati verbali, una volta orientata
sulle scelte di tipo grammaticale e enunciazionale, può
essere facilmente letta come una serie di gesti enunciati
vi, comportamenti veri e propri che producono posizio
namenti dei soggetti rispetto alle strutture spaziali, tem
porali e attoriali del discorso, con identificazioni, scarti
e messe in prospettiva; dall'altro lato è l'osservazione dei
comportamenti somatici, le scelte di occupazione spazia
le, di strategie di accesso o occultamento, che diventano
rivelatrici del valore attribuito al sé e all'ambiente al
contempo, in una situazione in cui il costituirsi di rela
zioni intersoggettive nuove (nuovi vicinati, nuove pros
simità, nuovi spazi pubblici, ecc) comporta un riassetto
complessivo dell'immagine di cui si carica la nuova por
zione di mondo in cui ci si trova calati. E, ulteriore ele
mento di interesse, l'osservazione etnosemiotica permet
te di cogliere appieno il gioco di reciproca determina-
Vll
zione , all'interno di una stessa dinanùca di valorizzazio
ne, tra gli intenti, i percorsi, le azioni , le strategie degli
attori, da un lato, e le strutture oggettivate degli spazi,
dei tempi, dei ritnù, degli ostacoli, dei varchi, dall'altro.
In questo modo si trae il suggerimento di valore assai
generale, che consiste nel porre la dimensione del valore
come la dimensione autentica per comprendere i proces
si di soggettivazione e di oggettivazione, processi che
possono in questo modo apparire come correlativi nel
valore, appunto, poli di relazioni di costituzione rispet
tiva.
Che da tutto questo si possano poi trarre indicazioni per
nùgliorare le politiche di gestione del disagio, che la ri
cerca sulle articolazioni del senso per e con i soggetti
utenti delle strutture sanitarie locali, tutto ciò, per quan
to esplicitamente posto come scopo ultimo del lavoro,
emerge in fondo quasi necessariamente, a riprova del
fatto che, più che una risposta a problemi precostituiti,
la modifica del reale trae il massimo del suo senso dalla
comprensione dei fenomeni per come si danno a leggere
e per come si aprono ad un'analisi approfondita "a vo
cazione scientifica".
Francesco Marsciani
1
Introduzione
Ho conosciuto Gerico,
ho avuto anch'io la nùa Palestina,
le mura del maniconùo
erano le mura di Gerico
e una pozza di acqua infettata
ci ha battezzati tutti.
(Alda Merini, La Terra Santa)
Dopo Gerico
La fine dei manicomi in Italia è paragonabile alla ca
duta delle mura di Gerico: un vallo secolare eretto a
istituire la differenza tra normalità e follia, ciò che è
'
interno alla società e ciò che ne è al di fuori. E un pro-
cesso molto lungo, non privo di ripensamenti e, per
molti versi, tutt'ora incompiuto. La legge Basaglia è
entrata in vigore nel 1978, ma la chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari è in corso mentre scrivo queste
righe. Quarant'anni: più di una generazione ha dovuto
estinguersi prima che potesse prodursi un cambiamento
culturale nel modo di relazionarsi con quell'inafferrabile
altro che è la paura del folle. Un mutamento che, scri
viamo, è ben lontano dal compiersi.
Come sostituire le grandi istituzioni manicomiali? È
una domanda sempre attuale. Le soluzioni adottate sono
molte: centri 24 ore per trattamenti volontari brevi.
Centri diagnosi e cura, che in qualche caso sonùgliano a
piccoli manicomi: puliti, ordinati, non-violenti, eppur
2
sempre manicomi. Case-appartamento gestite da coope
rative, in cui gli utenti lavorano e convivono.
Il problema in tutti questi casi è evitare di replicare la
logica dell'istituzione manicomiale, una logica che pos
siamo riassumere molto semplicemente con Foucault
(2008). Si tratta di spazi eterotopici, in cui convivono
funzioni diverse, per molti versi opposte e persino con
traddittorie: quella della custodia - reale o metaforica, e
'
quella della cura. E questo ad esempio il problema che
riguarda le REMS (residenze per l'esecuzione della
misura di sicurezza sanitaria} che sostituiscono l'ospeda
le psichiatrico giudiziario rischiando tuttavia di replicar
ne, in sedicesimo, le funzioni; ma è anche un problema
legato all'impiego dei farmaci, il cui uso può comportare
l'istituzione di un "manicomio chimico".
Un esempio di cui mi sono occupato (Galofaro 2009)
riguarda la condanna allo psichiatra Euro Pozzi, avvenu
ta nel 2007. Lo psichiatra aveva ridotto la quantità di
farmaci ad un paziente, in vista del suo recupero. Pur
troppo, contestualmente, il paziente ha ucciso un opera
tore sanitario. La sentenza stabiliva il dovere dello psi
chiatra di esercitare il controllo sociale della persona in
cura tramite la corretta somministrazione degli psico
farmaci. In tal modo, denunciava l'ASL 1 il tribunale
,
sembra credere che "una sempre più efficace opera di
controllo, magari non più affidata a robuste mura ma
piuttosto a sostanze chimiche, possa prevenire ogni
grave accadimento".
1 "L' Ausl assolve lo psichiatra" in Repubblica, 29 novembre
2007, p. 7.
3
Possiamo riassumere con un classico quadrato setnio
tico (Greimas- Courtés 1979) la contraddizione tra
punto di vista psichiatrico e giuridico:
Fig. 1 - LA diffe ren$ tra custodire e curare. Quadrato semiotico.
Come mostra il quadrato, nel discorso psichiatrico -
per lo meno nelle sue versioni più civilizzate - la custo
dia e la cura sono funzioni contrarie: se si vuol davvero
curare un paziente, questo comporta il fatto di non
custodirlo (e viceversa).
La figura 1 si riferisce a ciò che, con Foucault (2003:
25), possiamo chiamare una pratica discorsiva della
psichiatria. Ora, quando si passa a progettare un servizio
psichiatrico, ci si può chiedere come i suoi valori, la sua
assiologia fondamentale, si convertano in azioni, ruoli,
spazi e tempi. In altri termini ci si può chiedere: nei casi
rappresentati dai REMS, dai centri 24 ore, dai centri di
4
diagnosi e cura, dalle case protette, il servizio erogato è
coerente con l'insieme dei valori che costituiscono le
pratiche discorsive della psichiatria?
Vi è poi una seconda domanda, altrettanto importan
te, e riguarda la recovery di quanti sono in cura presso il
servizio psichiatrico - cfr. Marin, Bon (2012). Una
nozione non sovrapponibile a quella di guarigione poi
ché non è individuale. Essa discende da una lotta contro
l'esclusione, la coercizione, la restrizione; in tal caso gli
spazi del servizio psichiatrico devono guardare al lato
meridionale del quadrato rappresentato in figura 1. Il
lavoro per il reinserimento sociale dell'utente deve mira
re alla de-istituzionalizzazione, all'emancipazione, al
recupero e alla fruizione piena dei suoi diritti di cittadi
no; in altre parole: né custodire né curare.
L'associazione ARTSAM - DDN
Qualsiasi servizio psichiatrico è un processo dinamico,
che si avvicina o allontana dai valori che lo hanno ispirato
a seconda del tempo e delle circostanze. Pertanto, la
ricerca presentata in questo saggio mira a rispondere alle
due domande che abbiamo posto attraverso l'osservazione
e l'analisi di un caso reale, visto nei suoi pregi e nei suoi
difetti. Essa è frutto della cooperazione tra CUBE (Centro
Universitario Bolognese di Etnosemiotica), il Dipartimen
to di Salute Mentale di Pordenone, e l'associazione
ARTSAM - DDN. Quest'ultima comprende familiari e
amici di persone sofferenti di disagio psichico. Da cinque
anni l'associazione gestisce alcw1e case protette che ospi
tano da tre a cinque persone con alle spalle un percorso
di cura a volte molto lungo. Si tratta di una attività ormai