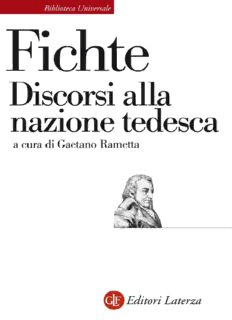Table Of ContentLDB
eBook Laterza
Johann Gottlieb Fichte
Discorsi alla nazione tedesca
© 2003, Gius. Laterza & Figli
Edizione digitale: dicembre 2014
www.laterza.it
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Realizzato da Graphiservice s.r.l. - Bari (Italy)
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 9788858118283
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata
Sommario
Introduzione di Gaetano Rametta
Note
Prefazione
Note
Primo discorso. Considerazioni preliminari e sguardo d’insieme
Note
Secondo discorso. Sull’essenza della nuova educazione in generale
Terzo discorso. Continua la descrizione della nuova educazione
Note
Quarto discorso. La diversità capitale tra i tedeschi e gli altri popoli di
provenienza germanica
Note
Quinto discorso. Conseguenze della diversità indicata
Note
Sesto discorso. Presentazione nella storia dei tratti fondamentali dei tedeschi
Note
Settimo discorso. Comprensione ancora più profonda del carattere originario e
tedesco di un popolo
Ottavo discorso. Che cos’è un popolo nel più alto significato della parola, e
che cos’è amor di patria?
Nono discorso. A quale punto dato nella realtà sia da collegare la nuova
educazione nazionale dei tedeschi
Decimo discorso. Per la determinazione più precisa dell’educazione nazionale
tedesca
Undicesimo discorso. A chi spetterà l’attuazione di questo programma
educativo?
Dodicesimo discorso. Sui mezzi per conservare noi stessi fino al
raggiungimento del nostro scopo principale
Sommario del tredicesimo discorso. Continuazione delle considerazioni
precedenti
Quattordicesimo discorso. Conclusioni generali
Introduzione di Gaetano Rametta
a Lia,
che sa il perché
Fichte tenne i Discorsi alla nazione tedesca nell’anfiteatro dell’Accademia delle
scienze di Berlino, ogni domenica a partire dal 13 dicembre 1807, e così sino
al 20 marzo 18081. Il pubblico era costituito da “una numerosa assemblea di
signori e signore” della società colta berlinese, mentre per via epistolare il
filosofo manteneva i rapporti con personalità del governo prussiano, allora in
“esilio” a Memel, nell’estremo nord della Prussia orientale. Le condizioni in
cui si svolgevano gli incontri ci vengono riferite dalle memorie di alcuni
partecipanti, che sottolineano lo straordinario coraggio di cui Fichte aveva
dato prova nel sostenere in conferenze pubbliche la necessità di una
rigenerazione spirituale della Germania, come condizione per la liberazione e
il riscatto dalla dominazione straniera2. Le truppe di occupazione francesi
sfilavano sotto le finestre della sala in cui le conferenze si svolgevano, e i suoni
delle fanfare militari si sovrapponevano alle parole dell’oratore; non soltanto in
sala erano presenti informatori francesi, ma persino il censore prussiano
assisteva personalmente alle riunioni. Era ancora vivo il ricordo della
fucilazione cui era stato sottoposto il libraio Palm, per aver pubblicato un
opuscolo di propaganda anti-francese. Il rischio era dunque effettivo, anche se
del contingente francese facevano parte, con posizioni di responsabilità, alcuni
ex allievi del filosofo3.
Ma che cosa aveva portato la situazione a questo punto? È lo stesso Fichte,
nel Primo discorso, a presentarci la sua diagnosi. Riallacciandosi
esplicitamente alle lezioni sui Tratti fondamentali dell’epoca presente che aveva
tenuto a Berlino alcuni anni prima (1804/05), egli sottolinea che i Discorsi
vanno intesi come la continuazione di quelle. Come noto, nei Tratti
fondamentali Fichte aveva contrassegnato l’epoca presente come quella della
“compiuta peccaminosità”, intendendo con ciò indicare la prevalenza di un
atteggiamento intellettualistico, volto al perseguimento dell’utilità e del
vantaggio immediati nella vita terrena4. Tale atteggiamento era il frutto della
critica illuministica alle religioni positive e della conseguente assolutizzazione
della conoscenza scientifica, nel senso matematico-quantitativo delle moderne
scienze della natura. Si era diffuso dalla Francia alla Germania, ma l’“egoismo”
immanentistico di cui esso era promotore si era innestato qui su una situazione
politica già di per sé frammentata e ricca di spinte centrifughe. All’interno di
questo quadro, si colloca l’atteggiamento dei diversi Stati tedeschi, e più in
generale dei ceti territoriali e dei singoli cittadini, di fronte alle guerre
rivoluzionarie prima, e a quelle di Napoleone poi.
Fichte cerca di adottare un linguaggio che, sulla scorta di Leo Strauss,
potremmo definire “reticente”. In parte per prevenire gli interventi della
censura, in parte perché costretto esplicitamente da quest’ultima a modificare
termini ed espressioni, egli impiega in molti casi parole quanto più possibile
generiche, che non sempre rendono agevole – per un lettore del nostro tempo
– identificare i bersagli concreti della sua polemica con la stessa facilità con cui
venivano identificati dagli uditori e dai censori dell’epoca. Così avviene per
l’uso dell’avverbio irgendwo, “da qualche parte”, nel Primo discorso, quando si
tratta di collocare nello spazio il luogo in cui l’“egoismo” è andato
completamente distrutto5; così avviene per l’impiego del termine “estero”, con
cui di solito (ma non sempre) si intende, in concreto, la Francia.
La distruzione dell’egoismo indica dunque la distruzione dell’impero tedesco
e, ancora più concretamente, la disfatta subita dalle truppe prussiane nella
battaglia di Jena e di Auerstädt. Essa è vista da Fichte come l’esito conseguente
del comportamento incerto e oscillante della Prussia, che aveva abbandonato al
loro destino i diversi Stati tedeschi con cui formava un’unica compagine, per
salvaguardare la propria sicurezza e ottenere magari qualche vantaggio
territoriale (come l’acquisizione dell’Hannover a seguito del Trattato di
Schönbrunn del 15 dicembre 1805, successivo alla disfatta austriaca nella
battaglia di Austerlitz del 2 dicembre dello stesso anno). L’inadeguatezza della
politica prussiana si sarebbe manifestata di lì a qualche mese, quando
Napoleone avrebbe fatto pagare a caro prezzo l’alleanza coi vincitori,
imponendo alla Prussia di chiudere al commercio inglese i propri porti
(Trattato di Parigi, 15 febbraio 1806), e al tempo stesso costringendo
l’imperatore asburgico Francesco II a dichiarare decaduto il Sacro romano
impero germanico (26 agosto 1806). Tale decisione era stata preceduta dalla
fondazione della Confederazione del Reno (12 giugno 1806), che raccoglieva
in un’unica compagine politica i territori tedeschi alleati dei francesi. Così, la
Prussia venne a trovarsi isolata di fronte all’“alleato” francese, e quando
sembrò che perfino l’Hannover sarebbe stato restituito all’Inghilterra, la
decisione di mobilitare l’esercito e muovere guerra alla Francia giunse come
un atto ormai tardivo e senza efficacia: la battaglia di Jena e di Auerstädt (14
ottobre 1806) fornì la testimonianza che la dissoluzione dell’impero – cui la
Prussia stessa aveva contribuito col suo atteggiamento, basato solo sul calcolo
meschino di qualche vantaggio temporaneo e sul mantenimento della propria
sicurezza – si era trasferita all’interno della Prussia6.
Per Fichte, l’idea di restare in una Berlino che era in procinto di essere
occupata dal vincitore (Napoleone vi entrerà il 27 ottobre) diventa
insopportabile. Alla notizia della sconfitta prussiana, egli perciò fugge dalla
città, e raggiunge la corte a Königsberg. Nella città di Kant, oltre a pubblicare
il saggio su Machiavelli che attirerà l’attenzione del giovane Clausewitz, Fichte
tiene un corso di dottrina della scienza nella locale università. Come vedremo,
le riflessioni condotte in queste lezioni costituiscono lo sfondo indispensabile
per intendere adeguatamente le considerazioni di carattere teoretico contenute
in particolare nel Settimo discorso. A ogni modo, anche la capitale dell’antica
Prussia orientale costituisce un riparo solo temporaneo: l’apertura delle ostilità
contro la Russia dello zar Alessandro, culminate nella vittoria napoleonica
della battaglia di Friedland (13 giugno 1807), spinge Fichte nuovamente alla
fuga e al rientro a Berlino (agosto 1807), dopo che l’umiliazione della Prussia
si era estesa, dal terreno militare, a quello politico-diplomatico (pace di Tilsit,
luglio 1807). Nella capitale prussiana, ancora priva del governo che a seguito
dell’occupazione di Königsberg da parte dei francesi si era ritirato a Memel,
Fichte trova il clima politico e spirituale per reagire al quale decide di
pronunciare le sue Reden an die deutsche Nation.
Ma allora, se tale è la situazione concreta all’interno della quale intendono
intervenire i Discorsi, è evidente che la continuità con le lezioni sui Tratti
fondamentali dell’epoca presente andrà intesa in modo tutt’altro che lineare. Ciò
che con la disfatta della Prussia è andato distrutto, infatti, non è un semplice
assetto politico, bensì è il principio stesso del periodo che costituiva l’età
“presente” all’epoca dei Grundzüge. La battaglia di Jena e le sue conseguenze
producono una rottura epocale, e i Discorsi intendono porsi all’altezza di questa
rottura7. A partire dalla sottomissione nei confronti di una “violenza esteriore”
quale quella esercitata dai francesi, l’unica possibilità per una via d’uscita è
costituita dalla “formazione di un nuovo mondo”. La transizione tra la vecchia
e la nuova epoca, tra l’età dell’egoismo dominante – contraddistinta da un
Illuminismo che ha emancipato la ragione dall’obbedienza ad autorità
estranee, ma che d’altra parte l’ha ridotta a “intelletto sensibile” e calcolante –
e l’età nuova, in cui la ragione dovrà estendere la chiarezza guadagnata
attraverso il lavoro dell’intelletto alla dimensione propriamente spirituale del
soprasensibile, può essere “agita” dal pensiero, e non meramente subita, solo a
partire dalla presa di coscienza che la crisi che investe la Germania è una crisi
irreversibile sotto il profilo temporale, e il cui significato va ben al di là dei
confini tedeschi, investendo l’Europa nel suo complesso8.
I Discorsi sono l’espressione di questa presa di coscienza, e proprio perciò
rappresentano un unicum nella produzione filosofica di Fichte. In questi anni,
l’attività del filosofo si era andata svolgendo secondo due linee coerenti dal
punto di vista della concezione di fondo, ma distinte sotto il profilo
dell’articolazione sistematica. Da una parte, abbiamo una sequenza
impressionante di esposizioni di dottrina della scienza (la prima della fase
berlinese, nel 1801/02; un breve corso nel 1803; addirittura tre cicli nel 1804;
le lezioni di Erlangen nel 1805; il corso di Königsberg nel 1807); dall’altra, una
serie di conferenze a carattere “popolare”, che comprendono le lezioni
sull’“essenza del dotto”, sui caratteri fondamentali dell’epoca presente, e
sull’avviamento alla vita beata (tutti e tre questi “corsi” verranno pubblicati a
Berlino nel 1806). Dove si collocano le Reden? Esse non costituiscono,
palesemente, una esposizione di dottrina della scienza; la loro finalità non è di
tipo speculativo, ma immediatamente pratico, operativo. D’altra parte, esse
non sono neppure “filosofia popolare”, anche se di quest’ultima possiedono la
caratteristica di rivolgersi a un pubblico di non specialisti, e quindi di adottare
un linguaggio per quanto possibile non tecnico e d’immediata
comprensibilità9.
La filosofia popolare espone le concezioni che contraddistinguono la dottrina
della scienza, ma non le dimostra in senso rigoroso; mostra come vanno intesi
i rapporti tra l’Assoluto e il mondo dei fenomeni, qual è la funzione della
coscienza all’interno di questi nessi; spiega quali siano le destinazioni
dell’uomo, del dotto; quali siano le articolazioni di fondo della storia, la
direzione di marcia delle diverse epoche: ma non dimostra tutto ciò in senso
propriamente “genetico”, non riconduce il tutto alle proprie condizioni di
possibilità trascendentali, non mostra le stratificazioni ontologiche, il carattere
“universale e necessario” dei diversi livelli di essere e di presa di coscienza che
lo costituiscono. Nonostante i suoi limiti epistemologici, la filosofia popolare
resta comunque “filosofia”. Anche se immediatamente volta a intervenire