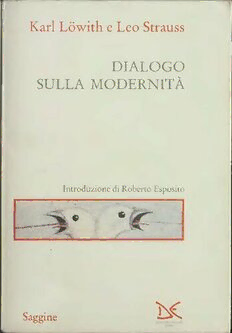Table Of ContentKarl Lowith e Leo Strauss
DIALOGO
SULLA MODERNITÀ
Introduzione di Roberto Esposito
Saggine
Nel suggestivo episto!ario intrecciato,
nel periodo del nazismo e della guerra, tra
due dei massimi interpreti del pensiero fi
losofico echeggiano accordi e dissonanze
sui gr,mdi problemi della filosofia. Acco
munati dall'origine ebraica - che li con
danna all'esilio dalla Germania negli anni
piG bui di questo secolo - Karl Lowith e
Leo Strauss ne vivono in maniera diversa
il rapporto antinomico con le categorie
storicistiche del nostro tempo. Se per
Strauss esse sono il risultato di una tragica
rottura con l'intera tradizione classica, sia
greca sia ebraico-cristiana, per Lowith
scaturiscono proprio dalla secolarizzazio
ne della filosofia cristiana della storia.
Ma forse il punto di maggiore divarica-
7ione interpretativa si concentra sulla nozio
ne che ambedue gli interlocutori oppongo
no all'ipertrofia della coscienza storica mo
derna, vale a dire quella di natura: da Strauss
intesa soprattutto nel suo aspetto, razio
nale e normativo, di natura delruomo; da
Lowith, al contrario, come ciò che eterna
mente ci trascende e ci domina. Di qui anche
una differente modalità di accostarsi a1 pro
blemi della politica. Alla richiesta straussiana
di un nuovo mito capace di accordare i cuori
dissonanti della polis, risponde la netta cur
vatura «impolitica» del discorso di Lowith:
se il nichilismo è il destino infrangibile del
nostro tempo, non rest,1 che prendere eroi
camente atto del crepuscolo di tutte le fedi.
Finemente ricostruiti dall'introduzione
di Roberto Esposito, i due itinerari imellet
tmli di Strauss e Lowith ritrovano, in que
ste lettere, la tram,1 profonda che li lega ,1llc
questioni essemiali della nostra epoca.
Saggine/ 5
Questo libro fa parte del «Fondaco di Micromega», nel quale vengono
pubbficati, di volta in volta presso editori diversi, materiali apparsi in una
prima edizione italiana nella rivista. Sono già usciti: Paolo Flores d'Arcais,
Il disincanto tradito, Bollati Boringhieri; Fernando Savater, Filosofia contro
accademia, Il Melangolo; Witold Gombrowicz, Corso di filosofia in sei ore
e un quarto, Theoria.
I testi di K. Lowith e L. Strauss sono stati pubblicati nel n. 5, 1991. Si
ringrazia «Micromega» per avere concesso l'autorizzazione a riprodurli
nella traduzione italiana di Alessandro Ferrucci.
L'introduzione di Roberto Esposito, scritta appositamente per questo
volume, riprende, ampliandola, la presentazione comparsa sulla rivista.
Karl Lowith e Leo Strauss
DIALOGO SULLA MODERNITÀ
Introduzione di Roberto Esposito
Traduzione di Alessandro Ferrucci
DONZELLI EDITORE
© 1991 «Micromega»
© 1994 Donzelli editore, Roma
ISBN 88-7989-082-4
____ DIALOGO SULLA MODERNITÀ ____
Indice
p. VII Introduzione. Sull'orlo del precipizio
di Roberto Esposito
3 Parte I. 1935
21 Parte II. 1946
V
____ DIALOGO SULLA MODERNITÀ ____
Introduzione
Sull'orlo del precipizio
di Roberto Esposito
1. Lettere dall'altrove.
Nulla manca a questo epistolario tra Karl Lowith e Leo
Strauss per farne uno dei più sintomatici documenti del secolo
che è ancora il nostro. Basta uno sguardo alle date che ne circo
scrivono in due blocchi distinti (1935 e 1946) l'arco temporale
per rendersene conto. Ma direi che tutto, in queste lettere - luo
ghi, nomi, circostanze - sembri rinviare al punto in cui l'intera
civiltà moderna rischia di precipitare in un collo d'imbuto che
solo alla fine della seconda guerra mondiale ha cominciato len
tamente (ma non irreversibilmente) a rovesciarsi. I luoghi in
nanzitutto: negli anni trenta, Roma per Lowith - vissuta con la
pienezza di cui l'autobiografia postuma dà pienamente conto -
Cambridge per Strauss. E, nel decennio successivo, ancora l'In
ghilterra per Strauss e gli Stati Uniti, raggiunti dopo l'intermez
zo giapponese, per Lowith. Luoghi tutti sui quali quegli anni e
quegli eventi depongono il segno rovente e indelebile non già
della semplice emigrazione, ma della persecuzione e dell'esilio,
come Lowith non mancherà di puntualizzare (Lowith 1986, pp.
123-4): non senza osservare, con la sobria amarezza dell'espe
rienza diretta, che «anche chi riesce a trovare una nuova patria e
acquista la cittadinanza di un altro Paese, trascorrerà gran parte
VII
Roberto Esposito
della sua vita a colmare questa frattura>, (ibid., p. 179).
E poi i nomi: quelli di Giovanni Gentile e di Benedetto Cro
ce, «uno dei pochi spiriti rimasti liberi e in possesso di un sapere
e di una cultura che fanno vergognare tutti i più giovani» (ibid.,
p. 118). Ma anche dei grandi Werner Jaeger e Ernst Kanto
rowicz, del teologo già protestante Erik Peterson, convinto al
cattolicesimo dal diffondersi in Germania della peste bruna e di
quelli - come Barth e Bultmann - capaci di rivolgere contro essa
la propria «protesta». Di Gogarten, scivolato con più di un piede
nel vortice, e ancora di Emil Brunner e di Paul Tillich. Per non
parlare degli uomini «decisivi» che restano sullo sfondo del dia
logo, ma che lo orientano come le stelle polari di un'epoca di cui
sono stati insieme i testimoni meno avventizi e gli interpreti più
lucidi: da un lato Weber e Husserl, ultimi eroi di una stagione
adesso esaurita, fissati nella ferma distanza e nel dignitoso riser
bo rispetto al montare della tempesta; dall'altro Heidegger e Sch
mitt, entrambi, sia pure diversamente, da questa lambiti e per
una certa fase travolti, come accade talvolta a chi vive il proprio
tempo con una partecipazione che ne rende opachi i contorni e
ne oscura la direzione. Sono i nomi - i maestri riconosciuti, ama
ti, odiati - che riportano la mente ad altri luoghi, questa volta te
deschi, ai quali la memoria degli esuli non può non tornare con
rimpianto e con rabbia: due soprattutto, Friburgo e Marburgo,
tra loro collegati dal filo, non solo biografico, di una vicenda fi
losofica tutt'altro che esaurita, e alla quale sia Lowith sia Strauss
torneranno con la consapevolezza mai smarrita che ad essa resta,
nel bene e nel male, la responsabilità di interpretare l'enigma di
questa tarda modernità che ancora ci insegue. Non a caso a que
gli autori rimandano alcuni dei saggi più penetranti che si alter
nano in singolare contrappunto da parte dei due interlocutori:
penso al grande lavoro lowithiano del 1932 su W eber e Marx
(Lowith 1932), cui risponde, a quasi venti anni di distanza, The
socia! sci.ence of Max Weber di Strauss (1951). Penso ai tanti, dif
ferentemente calibrati, interventi heideggeriani di Lowith (1953)
e alla lezione su Heidegger tenuta intorno al 1950 da Strauss a
VIII
__________ Introduzione __________
Chicago (1950a). Penso, soprattutto, a quella doppia recensione
incrociata che nei primi anni trenta strappa il famoso ( e famige
rato) saggio di Schmitt sul concetto di «politico» alla riflessione
di maniera per consegnarlo, in tutto il suo ambiguo fascino, alla
grande tradizione giuspubblicistica e politologica europea
(Strauss 1932; Lowith 1935).
Lo pseudonimo (Hugo Fiala, erroneamente attribuito a
Lukacs) con il quale Lowith dovette pubblicare il suo articolo
schmittiano ci richiama, infine, alle circostanze esterne - ma di
certo penetrate nella mente e nella scrittura dei due autori - che
non soltanto segnano dolorosamente quella stagione infelice,
ma rimandano nell'insieme alla parola, maledetta per i più e san
ta per i pochi da essa marchiati, che ne costituisce la cifra più in
quietante: ebreo. Tutto in queste lettere dall' «altrove» sembra
riportare ad essa. Dalle difficoltà editoriali - in particolare per
l'Hobbes di Strauss (1936) e il Burckhardt di Lowith (1936) - a
quelle professionali, economiche, logistiche. Dai piccoli oppor
tunismi alle grandi viltà che punteggiano - e degradano - la vita
non della sola Germania e che finiscono per spezzare il filo te
nace della nostalgia, se non della memoria, di coloro che ne su
biscono il peso schiacciante. La situazione di sospensione senti
mentale tra il desiderio di ritorno e il rancore per una terra che
rinnega Goethe e Hegel nel suo triste sogno di potenza. Da ulti
mo, la convinzione irrimediabile che «la Germania non è il cuo
re dell'Europa o della Cristianità, ma il punto focale della sua
dissoluzione» (Lowith 1986, p. 177): ecco la catena di eventi
materiali e traumi spirituali che finisce per scavare un abisso in
valicabile tra ebrei e tedeschi cancellando appunto quell' «e» che
ancora per Franz Rosenzweig costituisce il baricentro dell' esi
stenza e «addirittura una necessità di fede» (ibid., p. 173).
In questa condizione di scissione generalmente condivisa nel-
1' emigrazione ebraica - prima ancora che l'antisemitismo nazista
rendesse palese il suo volto «finale» - si dipanano poi le storie
personali, ognuna diversa dall'altra a seconda delle differenti mo
dalità di rapporto con l'antica stella e della profondità di radica-
IX