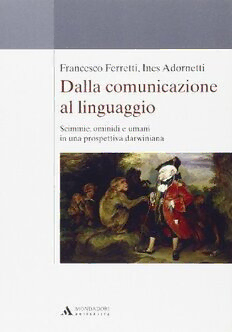Table Of ContentFrancesco Ferretti, Ines Adornetti
Dalla comunicazione
al linguaggio
Scimmie, ominidi e umani
in una prospettiva darwiniana
Francesco Ferretti, Ines Adornetti
Dalla comunicazione
al linguaggio
Scimmie, ominidi e umani
in una prospettiva darwiniana
Il Sistema Qualità di Mondadori Education S.p.A. è
certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di:
progettazione, realizzazione di testi scolastici e uni
versitari, strumenti didattici multimediali e dizionari.
© 2012 Mondadori Education S.p.A., Milano
Tutti i diritti riservati
Prima edizione Mondadori Università marzo 2012
www.mondadorieducation.it
Edizioni
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016
Stampato in Italia -Printed in Italy
Stampa .
Mondadori Printing N.S.M. - Cles (TN)
Riguardo ai diritti di riproduzione, l'editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze
derivanti dall'utilizzo di testi e immagini per le quali non è stato possibile reperire la fonte
Progetto di copertina di Alfredo La Posta
Indice
1 Introduzione
5 1.Scimmie
9 1. Non pensa dunque non parla: la tradizione cartesiana
13 2. La complessità del linguaggio
22 3. Dall'altra parte della barricata
32 4. Mettere da parte la grammatica
50 5. Neoculturalismo
63 Conclusione
65 2. Ominidi
67 1. Parentele filogenetiche: scimmie, antropomorfe e antenato comune
70 2. Origine del bipedismo
71 3. Alla ricerca dei primi ominidi
74 4. La comparsa del genere Homo.
88 5. Alle origini del pensiero simbolico: la rivoluzione del Paleolitico
Superiore
93 6. La rivoluzione che non c'è stata: comportamenti simbolici
nel Middle Stone Age
98 7. Alle origini del linguaggio
121 Conclusione
123 3. Umani
125 1. Il modello standard della comunicazione
127 2. Un modello alternativo della comunicazione umana:
la teoria della pertinenza
141 3. La teoria della mente e l'origine del linguaggio
154 4. Per una comunicazione propriamente umana
165 5. Navigazione e discorso
177 6. Discorso e conversazione
180 Conclusioni
183 Bibliografia
213 Indice dei nomi
Introduzione
«È anche una cosa notevolissima che, benché vi siano molti animali che
dimostrano maggiore ingegnosità di noi in alcune delle loro azioni, si
vede tuttavia che gli stessi non ne dimostrano affatto in molte altre; di
modo che ciò che essi fanno meglio di noi non prova che essi abbiano
dell'ingegno, perché se così fosse, ne avrebbero più di ognuno di noi e
farebbero meglio di noi in ogni altra cosa; ma prova piuttosto che non ne
hanno affatto e che è la natura che. agisce in essi secondo la disposizione
dei loro organi: come un orologio, che non è composto che di ruote e
di molle, può contare le ore e misurare il tempo più giustamente di noi,
con tutta la nostra accortezza» (Cartesio, 1637, trad, it., pp. 100-101).
In questa citazione tratta dal Discorso sul metodo, Cartesio (1637)
delinea in· poche parole una visione largamente condivisa della natura
degli animali e, per contrasto, di quella degli esseri umani. Nessuno si
stupisce del fatto che un ghepardo corra più veloce di noi; o che un'aquila
veda meglio di noi: poiché la struttura anatomica di questi animali è stata
progettata dall'evoluzione per far fronte a specifici problemi ambientali, è
del tutto naturale che, per gli scopi per cui sono stati progettati, essi met
tano in atto forme di eccellenza comportamentale. Per quanto raggiunga~
no prestaiioni incomparabili alle nostre, tuttavia, gli animali non umani
pagano il costo della specializzazione: un ragno è abilissimo a costruire
complicate ragnatele, al di là di questo, però, non è in grado di fare altro.
Messa in questi termini, la forza degli animali si rivela ben presto anche
la loro debolezza: essi agiscono come gli orologi che, per quanto molto
più precisi di noi, sono del tutto inadatti a risolvere problemi non previsti
da chi li ha progettati. Gli animali non umani, in effetti, sono soltanto
macchine: dispositivi fisici le cui abilità dipendono dalla «disposizione
d'organi», ovvero da come sono assemblate le parti che li compongono.
La concezione cartesiana degli animali è fortemente radicata nel sen
so comune e contribuisce in modo sostanziale alle costruzione (rassi
curante) del modo in cui gli esseri umani vedono· se stessi. È in forza
2 DALLA COMUNICAZIONE AL LINGUAGGIO
di una concezione di questo tipo che gli umani guardano agli animali
con la serenità e l'orgoglio di chi è certo di possedere una proprietà (il
pensiero, la capacità attraverso cui l'essere umano può far fronte a mol
teplici problemi di natura diversa) in grado di tracciare una netta linea di
demarcazione tra noi e loro. Il pregiudizio antropocentrico che governa
la visione che gli umani hanno di se stessi si sposa alla perfezione con
la concezione cartesiana: la tesi della differenza qualitativa giustifica la
posizione degli umani nella natura in un modo che ci appaga e ci rassicu
ra. Diversamente dagli animali, gli esseri umani non sono macchine: ciò
che distingue i comportamenti meccanici degli animali dall'agire libero
e indeterminato degli umani, in effetti, dipende dal fatto che la capaci
tà di pensiero permette agli esseri umani di agire in modo flessibile e
creativo. A partire dagli anni cinquanta del Novecento, Noam Chomsky,
richiamandosi in modo esplicito a Cartesio, ha insistito molto su questo
punto: la differenza qualitativa tra gli umani e gli animali trova fonda
mento nella capacità di usare il linguaggio in modo creativo.
A esaminarlo nella sua pars destruens, il nostro intento in questo
libro è la critica al pregiudizio antropocentrico. Per il ruolo giocato dal
linguaggio nella definizione della natura umana, una critica del genere
si sostanzia nella messa al bando dei modelli interpretativi che conside
rano il linguaggio lo spartiacque insuperabile tra umani e altri animali.
I capitoli che seguono, in effetti, sono mossi dai una fiera opposizione al
cartesianesimo militante che ispira gran parte delle ricerche contempo
ranee sulla natura del linguaggio. Lo sono in primo luogo per la scelta
di una diversa opzione di fondo: il riferimento alla tradizione darwi
niana. Sostenendo che gli umani sono animali tra altri.animali, Darwin
(contro Cartesio) interpreta la differenza tra gli umani e gli altri animali
in termini di grado e non di qualità. Nella prospettiva darwiniana tutte
le proprietà e le capacità umane devono essere considerate in riferimen
to a proprietà e capacità comuni anche ad altri animali: il linguaggio
ovviamente non fa eccezione a questo principio generale.
A considerarlo nella sua pars costruens, questo libro (fieramente an
ticartesiano) assume a proprio fondamento una tesi cara a Cartesio e ai
neocartesiani: l'idea che la creatività e la flessibilità del linguaggio rap
presentino il tratto distintivo delle capacità verbali umane. Condividere
con i cartesiani un'idea di questo tipo, tuttavia, non significa accettare
le conseguenze teoriche che questi autori traggono sul linguaggio e la
natura umana: la nostra spiegazione. delle competenze verbali in rife-
INTRODUZIONE 3
rimento all'uso creativo del linguaggio conduce infatti a esiti del tutto
speculari rispetto a quelli del modello dualista, fondato sulla «differen
za qualitativa», offerto da Chomsky e dagli autori che si rifanno al suo
modello interpretativo.
Prima di chiudere con i preamboli, c'è ancora una precisazione da
fare. Il nostro interesse in questo scritto non è da ascrivere alla comuni
cazione animale in quanto tale, né al linguaggio umano in quanto tale:
l'oggetto di indagine delle pagine che seguono è piuttosto il tema del
«punto di con,tatto» (o, per meglio dire, del «punto di passaggio») tra la
comunicazione animale e il.linguaggio umano. I:a nalisi di tale oggetto
d'indagine verrà portata avanti in due modi: attraverso lo studio della
filogenesi del linguaggio nel percorso evolutivo del genere Homo (si
tratta di un percorso in buona parte speculativo ma che le indagini della
paleoantropologia e dell'archeologia cognitiva cominciano a puntellare
di importanti evidenze empiriche); analizzando le capacità comunicati
ve di una particolare classe di animali: le scimmie «culturalizzate», le
grandi scimmie (scimpanzé, oranghi, bonobo, gorilla) allevate· in am
bienti umani e sottoposte a un tipo di comunicazione «artificiale» inter
specifica~ Capire se (e quanto) questi animali riescano ad apprendere il
linguaggio umano è questione che affronteremo nelle prossime pagine;
al di là dell'analisi dei risultati raggiunti su tale questione, tuttavia, il
punto epistemologicamente rilevante degli esperimenti con le scimmie
culturalizzate è che questi animali (esattamente per il loro carattere di
organismi «ibridi», che molti contestano) si prestano bene ad esempli
ficare quella situazione di contatto e di passaggio tra la comunicazione
animale e il linguaggio umano che, come abbiamo detto, rappresenta il
fuoco di attenzione principale in questo libro.
r; analisi dell'avvento del linguaggio a partire dalle capacità comuni
cative delle scimmie e degli ominidi apre la strada a un modello interpre
tativo in grado di tenere insieme tanto gli elementi di continuità, quanto i
caratteri di specificità del linguaggio umano (senza i quali sarebbe impos
sibile distinguere le capacità linguistiche della nostra specie dai sistemi di
comunicazione animale). In un modello di questo tipo, la specificità del
le capacità verbali umane viene interpretata in riferimento alla creatività
e alla flessibilità del pensiero: in un libro fieramente anticartesiano non
è irragionevole riconoscere che Cartesio e Chomsky, dopotutto, almeno
su un punto (anche se pe.r i motivi sbagliati, come vedremo), erano nel
giusto. Non ci resta che cominciare; dopo i ringraziamenti, però.
4 DALLA-COMUNICAZIONE AL LINGUAGGIO
In questi anni di lavoro comune abbiamo discusso le tesi presenta
te in questo libro con amici e· colleghi: ringraziamo di cuore Veroniça
Adornetti, Erica Cosentino, Mario De ·caro, Marta ·Di Dedda, Mauro
Dorato, Alessandra Falzone, Stefano Federici, Daniele Gambarara,
Giovanni Iorio Giahnoli, Elisabetta Gola, Franco Lo Piparo, Andrea
Marini, Massimo Marraffa, Marzia Mazzer, Maria Francesca Palermo,
Alfredo Patetnoster, Antonino Pennisi, Pietro Perconti, Roberto Pujia,
Paolo Quintili, Pasqualina Riccio; Maria Grazia Rossi, Maria Stella
Signoriello, Pietro Storari,· Silvano·Tagliagambe, Paolo Virno, Tiziana
Zalla. Per le proficue discussionie la grande disponibilìtà dimostrate nei
nostri confronti un ringraziamento particolare va a Michael Corballis.
Questo libro è il prodotto di pen.sieri e discussioni comuni e, come
tale, deve essere considerato il frutto di un ·lavoro congiunto~ Ai fini
pratici, Francesco Ferretti ha scritto il primo capitolo e i paragrafi 1, 3,
4, 4.1, 5, 5:1, 5.2, 5.2.3, 6 del terzo; In:esAdornetti è autrice del secondo
capitolo e dei paragrafi 2, 4.2, 4.2.1, 5.2.1, 5.2.2 del terzo; Introduzione
e conclusiorie sono state scritte a quattro mani.