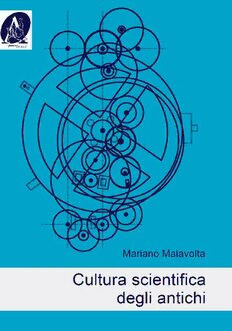Table Of ContentMariano Malavolta
Cultura scientifica
degli antichi
A
RACNE
Copyright © MMV
ARACNEeditrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 a/b
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN88–548–0080–5
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: maggio 2005
Sommario
Premessa, 7 — 1. Storia, historia, icrrapta. Le connessioni fra indagine sto-
rica e "metodo" scientifico, 11—2. Nozioni di cronologia, 23 — 3. La pa-
rabola del mondo antico: póleis greche, stati ellenistici ed ecumene roma-
na, 39 - 4. La nascita del pensiero scientifico: esordi della cosmologia e
della matematica nel periodo arcaico (dai poemi omerici agli inizi del V
secolo a.C), 53 — 5. Il periodo classico e l'egemonia culturale di Atene
(480-323 a.C), 73 - 6. Uexploit della scienza greca nell'età ellenistica
(323—31 a.C), 89 — 7. Scienza greca e mondo romano. Decadenza di A-
lessandria e sua rinascita in età romana imperiale, 107 — 8. Il declino della
scienza antica nelle compilazioni degli enciclopedisti latini, 117-9. Tec-
nologia e società antica, 121 - Nota bibliografica, 143 - Repertorio pro-
sopografico, 147 - Figure, 171
Premessa
Il mito della knowledge economy ha portato in primo piano, anche nel
mondo della formazione accademica, la fondamentale esigenza della
“condivisione di un modello di gestione della conoscenza”: questo con-
cetto — così espresso con una formula che sembra quasi volutamente
congegnata in modo da precluderne la comprensione — viene inteso da-
gli economisti nel senso che “la competitività di un’azienda è data soprat-
tutto dalla competenza di ciascuno [un cultore del bello stile avrebbe
magari preferito scrivere, forse fraintentendo, “da una inattesa sinergia
delle competenze dei singoli”] e quanto più questa è dispersa e condivisa,
tanto maggiore è il valore aggiunto che ne deriva”. Ma vediamo di meglio
chiarire, con l’aiuto dell’autrice dello scritto or ora citato1, gli scopi di
questa nuova metodologia formativa: “In questo contesto, la componen-
te immateriale del patrimonio aziendale, rappresentata dal capitale intel-
lettuale nelle sue espressioni formali ed informali, comunque legati alla
conoscenza, tende a divenire per tutte le aziende il fattore strategico pri-
mario per la produzione diretta di valore, o indiretta, attraverso il patri-
monio tangibile. Oggi la differenza non la fanno più le strutture, la catena
di distribuzione, la materialità della presenza dell’azienda [o anche
nell’azienda?], ma la gestione del processo per arrivare alla produzione”.
La conseguenza di tutto ciò, in termini di strategia formativa, è
fi
ef cacemente sintetizzata nell’apertura dell’articolo: “Una laurea in inge-
gneria, non importa quale specializzazione, può aprire anzi spalancare le
porte del futuro, garantire un lavoro assicurato e una carriera prometten-
fi
te. Succedeva così no a poco tempo fa. Ma oggi sembra non essere più
così. Le nuove frontiere della tecnologia e del marketing richiedono anche
una preparazione umanistico–economica: addio ingegnere tutto numeri,
tavole e centimetro”.
1 FLAVIA ANGELINI,Ingegneria, nuove frontiere della professione, in “Periscopio” 2001, a.3, nrr.
44-45, p. 1.
7
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Cercheremo ancora, nel seguito di queste pagine, di immaginare
cosa avrebbe potuto pensare il buon Aristotele della knowledge economy: ci
pare di poter anticipare, senza tema di smentita da parte sua, che dall’alto
delle sfere celesti del meritato iperuranio egli sogguardi con una certa
fi
suf cienza, mista a fastidio, questo procedere meschino della new economy
(null’altro che mezzucci per far soldi, a conti fatti) e la relativa elabora-
zione di una knowledge economy che nel nuovo ordinamento degli studi si
propone di “insidiare” il moderno sistema “tolemaico” del sapere scien-
fi
ti co, gerarchicamente costruito con notevole sforzo teoretico nel secolo
fi fi
scorso; quei con ni del cosmo in nito, che l’umanità aveva da sempre
immaginato con fantasia creativa e quindi indagato con sempre più sotti-
le intelligenza, egli non potrebbe che commiserarli, vedendoli ormai co-
artati nel microcosmo ergastolare dell’azienda (ma Aristotele la chiame-
fi
rebbe, con maggior vigore icastico, “bottega”) e de nitivamente sotto-
fi
messi alle leggi volgari del pro tto. Senza dunque insistere in quest’ottica
di aristocratico disprezzo ci limiteremo, per il momento, a notare che la
materia che ci proponiamo di esplorare in queste nostre conversazioni è
fi
suf cientemente dispersa e condivisa e distante rispetto ai contenuti degli
fi
altri insegnamenti impartiti nel Corso di Informatica, e tale da giusti care
ampiamente il nostro modesto tentativo di rivolgere lo sguardo all’indie-
tro, e non allo ieri né all’altro ieri, ma oltre l’abisso dei millenni, sullo sce-
nario di una umanità che ha lasciato di sé soltanto reliquie consunte dal
tempo.
Il mondo antico o, più precisamente con riguardo alla materia del
corso che svolgeremo, il mondo grecoromano e dunque l’antichità classi-
ca, rappresenta un primo tentativo di affermazione di progettualità glo-
fi
bale nella vita degli umani, che no alle soglie della storia si era trascinata
senza apprezzabili progressi per centinaia di migliaia di anni. Questo
fi
primo affermarsi della “civiltà” incominciò a trovare la sua de nitiva e-
spressione nel pensiero elaborato dai Greci in un momento felice di
prodigioso exploit dell’intellettualità degli uomini, che costituì il seme
ancor vivo ed operante nella nostra cultura occidentale, come mostrano
fi
l’origine greca di tutto il lessico scienti co e la sua perdurante vitalità ed
attualità: si è notato che soltanto in Grecia la coscienza teoretica poté
sorgere in forma indipendente, così come è vero che solo nella lingua
8
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
greca2 i concetti scientifici poterono svilupparsi dalla lingua in modo or-
ganico ed in piena autoctonia. Tutti gli altri idiomi, a partire dal latino, si
nutrirono obbligatoriamente per questo bisogno del greco prendendolo
in prestito, trascrivendolo o traducendolo e in ogni caso dipendendone.
Altrettanto vero è che il miracolo greco, che almeno in origine a-
veva interessato una parte tutto sommato assai ridotta dell’ecumene,
fi
dif cilmente sarebbe sopravvissuto alla grande crisi della civiltà classica
se quei fermenti originari non fossero stati assimilati stabilmente e
fi
all’in nito replicati nel canone “classicistico” dalla egemone cultura ro-
mana e italica, ciò che ne rese possibile la sopravvivenza dopo la buia
notte dell’evo medio.
fi
Anche l’evento epocale della ne del mondo antico e il ripiombare
dell’umanità in condizioni pericolosamente simili a quelle della preistoria
fl
devono farci ri ettere — se ad essi si guarda come ad un primo sostan-
ziale fallimento del tentativo di civilizzazione dell’ecumene — nel mo-
mento in cui il “nostro” mondo e la nostra umanità, quella del terzo mil-
lennio appena iniziato, imboccano speditamente la strada obbligata della
globalizzazione: un’esperienza già vissuta dagli antichi a partire dall’età di
fi
Augusto, arte ce di quel cosmo ordinato secondo i dettami della pax Ro-
mana che fu l’ecumene antica, e che nel periodo compreso fra il suo re-
gno e quello degli Antonini ebbe modo di celebrare i suoi fastigi, per es-
sere poi inghiottito tutto intero da tumultuosi movimenti migratorii di
genti ‘barbare’, che lasciarono dietro di sé un mucchio di rovine (pur im-
ponenti), e null’altro che lo scheletro delle gigantesche “infrastrutture”
della grandezza di Roma; da allora la parte più preziosa dell’eredità resi-
dua dell’antico splendore dormì a lungo, per parecchi secoli, annidata nei
fogli di cartapecora che i monaci benedettini e gli eruditi arabi andavano
fi
ricoprendo di una minuta scrittura che af dava al fragile presidio della
pergamena l’inestimabile valore del codice genetico della civiltà divenuto
in seguito il seme della rinascenza.
A queste problematiche noi ci rivolgiamo — come già i nostri pro-
genitori greci — utilizzando quella categoria della ‘storia’ che fu senza
dubbio fra le più geniali loro creazioni, ed è piuttosto di questa categoria
della “storia” (intesa come matrice caratterizzante ed originaria della no-
stra civiltà) che parleremo nel corso delle nostre conversazioni, cercando
2 BRUNO SNELL,La formazione dei concetti scientifici nella lingua greca, in “La cultura greca e le
origini del pensiero contemporaneo”. Torino [Einaudi] 1968, pp. 313-334.
9
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
di superare una plurisecolare barriera eretta fra scienze esatte e scienze
umane e di rintracciare la comune radice di quell’insopprimibile istinto
che spinse l’uomo greco a indagare la memoria del passato non meno
che gli arcani della natura: delineare un pur elementare disegno dello svi-
fi
luppo delle conoscenze scienti che dell’uomo antico (e dei suoi metodi
di indagine) sarà preliminare indispensabile all’ulteriore tentativo di chia-
rire nel concreto l’incidenza dell’uso di alcune tecniche (drenaggio e cap-
tazione delle acque, tecnica edilizia, agrimensura) sulla vita degli umani. È
ovvio, del resto, che una storia della scienza propriamente detta (ossia un
puntuale e sia pur conciso approccio epistemologico ai singoli saperi
fi
scienti ci) sia da considerare materia assai più complessa, che non potrà
mai non soltanto essere trattata, ma nemmeno accennata con qualche
fi
pro tto in un corso di cultura generale.
10
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
1
Storia, historia, iJstoriav :
le connessioni fra indagine storica e “metodo” scientifico
Cominciamo dunque a chiarire il concetto di storia osservando che
questo vocabolo anche nella nostra lingua italiana si presenta in contesti
fi
diversi, anche di linguaggio corrente, con più di un signi cato: di una
qualsiasi banale vicenda da raccontare si può dire che è “una lunga sto-
ria”, con allusione alla concatenazione di fatti correlati fra loro in maniera
complessa, e allo stesso modo una relazione di qualsiasi tipo (non neces-
fi
sariamente amorosa) può essere de nita “una storia”, mentre l’espres-
sione “fare storie” può alludere a reticenze, spiegazioni o motivazioni
complicate, per lo più pretestuosamente addotte. La storia insomma è
una cosa da spiegare e da capire, con un prima, un dopo, azioni e reazio-
ni dei protagonisti e, magari, rivelazioni illuminanti di retroscena ignoti
agli stessi protagonisti.
C’è poi la storia che si studia sui libri, che è quella che qui ci inte-
ressa, e che è stata anch’essa accomunata — nel giudizio di personaggi
fi
anche importanti, ancorché non specialisti — al signi cato corrente, illu-
strato sopra, di “insieme di frottole” o “chiacchiere”: così nello spicciati-
vo giudizio di Henry Ford, il re americano dell’automobile “la storia è —
più o meno — un fuorviante sproloquio3 (bunk). Essa è tradizione. Noi
non abbiamo bisogno di tradizione: noi vogliamo vivere nel presente, e la
sola storia che valga qualcosa è la storia che noi costruiamo giorno per
giorno”4. D’altra parte, qualche anno dopo aver detto quest’idiozia, lo
stesso Ford si riscattò tributando un suo personale omaggio alla storia,
ossia promuovendo la fondazione di un museo dell’automobile, nel quale
3 Questa traduzione di bunk — forse un po’ lambiccata — cerca di rendere il valore pre-
gnante dello slang: la vuota chiacchiera della storia, insomma, non è solo inutile, ma anche disone-
sta e imbastita con l’intento di imbrogliare chi ascolta.
4 History is more or less bunk. It’s tradition. We don’t want tradition. We want to live in the present
and the only history that is worth a tinker’s damn is the history we make today.
11
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
il visitatore potesse seguire le linee evolutive della produzione dei veicoli
a quattro ruote, documentata dai modelli realizzati nei pochi decenni
precedenti. Non meno interessante l’etimologia della voce gergale bunk
(abbreviazione di bunkum), che nello slang americano indica appunto una
fandonia, e trae la sua origine dal discorso che tal Felix Walker, delegato
della contea di Buncombe (North Carolina) volle fare a tutti i costi il 25
febbraio del 1820 nella House of Rapresentatives a Washington (nel corso di
una lunga ed estenuante sessione), sol perché il testo ne fosse pubblicato
dai giornali e mostrasse agli elettori della sua contea che egli era membro
attivo del Congresso: “I shall not be speaking to the House — egli avrebbe
dichiarato — but to Buncombe” e da quel momento la voce bunkum, ossia il
nome della suddetta contea, così storpiato dall’uso, divenne sinonimo di
ogni “nonsensical language ”, e si diffuse al punto di produrre una forma
abbreviata bunk, di uso comune.
Assai più complessa e di ben altro spessore si presenta, ovviamen-
te, l’indagine che possiamo imbastire sul vocabolo “storia”, che così si
denomina dal derivato di una parola latina (historia) imprestata alla lingua
volgare (‘istória’, poi ‘storia’), nella quale l’accento cade sulla o perché la i
dell’iato ia è una vocale breve, e dunque la legge della prosodia latina fa
ritrarre l’accento sulla terzultima sillaba. A sua volta il latino historia è tra-
scrizione o, meglio, traslitterazione (nelle lettere dell’alfabeto latino) di
una parola greca, isJ toriav , nella quale si deve notare lo spirito aspro sullo
iota iniziale, che indica l’aspirata, e che si conserva nella h iniziale del lati-
no historia.
fi
Intanto è signi cativo (si devono notare questi particolari apparen-
temente ovvii, visto che la storia è fatta di queste cose, e con questo me-
todo) che i Romani o Latini che dir si voglia, per dare un nome alla storia
siano stati costretti a scegliere una parola greca, ossia straniera: è evidente
che la cultura romana, allorché nel terzo secolo a.C. i Romani comincia-
rono a parlare di storia, non aveva ancora elaborato un vocabolo adatto a
fi
de nire nella lingua latina un’attività teoretica così complessa.
Tornando al greco isJ toriav , che significa correntemente indagine,
ricerca, è da ricordare che l’origine di questo vocabolo è assai antica, e si
riconnette al vocabolo i{stwr (= colui che sa, che conosce le leggi), che è
presente già nel nucleo originario dei poemi omerici, nel libro 18°
dell’Iliade; i glottologi lo fanno derivare dal tema (cid:1)vid di oida e orao [“ve-
do”]: dunque è histor “colui che sa” e che sa “per aver visto” o, come ve-
12
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.