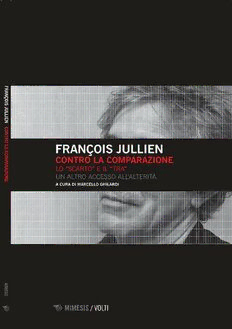Table Of ContentN. 89
Collana diretta da Giuseppe Bianco, Damiano Cantone, Pierre
Dalla Vigna e Luca Taddio
François Jullien
CONTRO
LA COMPARAZIONE
Lo “scarto” e il “tra”
Un altro accesso all’alterità
A cura di Marcello Ghilardi
Traduzione di Marcello Ghilardi.
Titolo originale: L’écart et l’entre, de François Jullien.
Copyright © Editions Galilée 2012
Il presente volume nasce all’interno delle attività del laboratorio politico della
Fondazione Francesco Fabbri che si impegna a promuoverne la diffusione.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento anche a Paolo Fabbri per il suo
supporto.
© 2014 – MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
Collana Volti n. 89
eISBN: 9788857559360
www.mimesisedizioni.it
Via Risorgimento, 33 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono e fax: +39 02 89403935
E-mail: [email protected]
INDICE
PREFAZIONE
NEL CANTIERE DI JULLIEN
di Roberto Masiero
FRANÇOIS JULLIEN
CONTRO LA COMPARAZIONE
I. UNA DECOSTRUZIONE DA FUORI
II. A COSA PORTANO LE DIFFERENZE?
III. FAR LAVORARE LO SCARTO
IV. LO SCARTO APRE UN “TRA”
V. IL “TRA” COME STRUMENTO
VI. IN CAMMINO VERSO L’ALTERITÀ
POSTFAZIONE
FILOSOFARE COME “PENSARE ALTRIMENTI”
di Marcello Ghilardi
R M
OBERTO ASIERO
PREFAZIONE
NEL CANTIERE DI JULLIEN
Ho letto molto di ciò che ha scritto Jullien rimanendone sempre catturato e
alle volte persino stordito per chiarezza, lucidità di analisi, ma soprattutto per
il «paesaggio sconfinato» che le sue argomentazioni offrono. La ritrascrizione
di questa lezione inaugurale per la Chaire sur l’altérité, mi ha regalato una
sensazione direi preziosa: ho bussato e Jullien mi ha accolto nel suo
laboratorio dal quale si può accedere ad un immane cantiere nel quale tutti
sono invitati a mettersi al lavoro. Al centro del cantiere una torre di Babele
per costruire la quale gli uomini parlano molte lingue senza pensare che
questo possa essere una dannazione o una colpa da espiare. È proprio tra le
molte lingue che può animarsi l’umanità.
Gli strumenti negli scaffali del laboratorio di Jullien sono frutto di un
grande lavoro di precisione, esito di una rigorosa riflessione sul metodo e di
indagini preventive sugli orizzonti della sua geografia: da un lato lo scaffale
ad occidente (o dell’Occidente), dall’altra lo scaffale dell’universo cinese (che
non può essere definito come ad oriente o come l’Oriente). Jullien è tra questi
due mondi e non ha alcuna intenzione di compararli, di schierarsi o di
perdersi nel tramonto dell’Occidente o in una qualche presunta volontà di
potenza dell’universo Cina, ma prova a giocare una partita difficilissima e,
forse, per l’uno e per l’altro cruciale: vuole farli uscire dalla «indifferenza
reciproca e porli faccia a faccia, in modo tale che ciascuno possa al tempo
stesso inquadrare l’altro e farsi inquadrare da esso». In questo tra accadono
relazioni impreviste, possibilità non ancora pensate e, in fondo, una idea di
libertà e quindi di umanità talmente nuova da apparire ancestrale, potrei dire,
nella sua stessa vitalità, pre-originaria.
Ecco allora due parole (cioè due strumenti) fondamentali nella loro
immediatezza e nella loro efficacia posti da Jullien in questo scritto: lo scarto
e il tra.
La prima, lo scarto, viene contrapposta a differenza. Forse è il caso di
ricordare che differenza è parola chiave per tutte le filosofie della
decostruzione che seguono l’invito heideggeriano alla Destruktion dei
concetti della metafisica. Nella decostruzione la lettura dei testi della
tradizione metafisica occidentale ha come scopo l’annientamento del concetto
stesso di sistema, di quel sistema che tutto unifica, che tutto ‘identifica’, che
riduce il tutto a identità. L’intenzione per la decostruzione è liberare l’alterità,
e aprirsi alla differenza.
Secondo Jullien, che vuole cercare di comprendere la pluralità delle
culture, la semplice indagine sulle differenze non risolve il concetto stesso di
cultura. La differenza è in fondo un concetto a sua volta identitario in quanto
presuppone che a monte ci sia una cultura primaria, ma non si dà una qualche
identità culturale previa una qualche umanità originaria (per questo prima ho
provato ad usare il termine pre-originario). Lo scarto invece non opera
classificando, ma mette in tensione, non prefigura un ordinamento, ma mette
in atto il disturbo e «fa apparire le culture e i pensieri come altrettante
fecondità». Lo scarto è produttivo mentre la differenza non produce nulla.
Questa è destinata alla tautologia, rinvia ad una verità come presupposto,
mentre lo scarto propone una verità come «rendimento», possibilità, apertura.
Scrive Jullien: «Si potranno (si dovranno) considerare le culture e i pensieri
non più dal punto di vista della verità, nemmeno in filosofa, bensì secondo la
loro capacità di presa o di effetto, a partire da ciò che definirei senza timori
(…) il loro ‘rendimento’. Le culture sono come dei filoni, o dei solchi, a
seconda che ci si presenti il pensiero come qualcosa che penetra nella terra o
come qualcosa che fa germogliare. Il pensiero greco non è più ‘vero’ di quello
cinese, o viceversa. Ma se approfondiamo lo scarto tra essi, sono entrambi in
grado di fornirci, oggi, altrettante possibilità di ‘presa’, o reti (di coerenza) per
pensare un comune dell’esperienza che sia comunicabile; forniscono delle
‘prese’ che si rinforzano e si distaccano grazie al loro confronto». Dalla
questione della verità non si sfugge, e ovviamente, ciò vale anche per Jullien,
ma quello che nello scarto accade è che la verità non può essere pensata come
normativa, come logica della corrispondenza, come ‘rivelazione’, come
conformità ad una regola, come coerenza o come utilità, o come
essenzialmente vincolata agli universali, ma va pensata nelle dinamiche della
fattualità. Le tre grandi linee di riflessione sulla verità sinteticamente
rappresentate da Heidegger, Tarski e Jaspers, la prima attorno al concetto di
alétheia, del non essere nascosto come tale, la seconda come teoria della
indefinibilità per la quale la verità all’interno di un determinato sistema non
può essere definita all’interno del sistema stesso, la terza che propone di
considerare la possibilità di una sintesi imparziale di tutte le definizioni finora
date della verità, non sfuggono comunque dalla definizione di Tommaso
d’Aquino, veritas est adaequatio rei et intellectus, definizione con la quale si
misura anche Jullien con uno scarto particolare. Per Jullien l’intelligenza,
quindi la possibilità di intelligere, «in quanto facoltà dell’umano, non è una
facoltà fissa, un ‘intelletto’ bloccato nelle sue categorie (fossero anche quelle
kantiane), ma una capacità che resta aperta, in processo, in cantiere; è una
capacità che si de-categorizza e si ri-categorizza, dispiegandosi quanto più
passa attraverso delle intelligibilità che hanno compiuto uno scarto». Cosa
accade? Che la verità non sta né dalla parte della res, né da quella
dell’intellectus, si potrebbe dire che sta nel mezzo, nel tra. Forse è ciò che i
Greci, come una sorta, per loro, di residuo logico-esistenziale, intendevano
con la parola metis, prudenza.
Essendo nel tra non si dà il dilemma se la verità sia assoluta o possa essere
relativa. Non sta nemmeno dalla parte del pensiero contrapposto alla
percezione sensibile. Anche la distinzione, o la simmetria, tra intelletto e
sensibilità perde valore categoriale e assume una sorta di fluidità. Il
presupposto aristotelico: «tutti gli enti sono o sensibili o intelligibili» può
essere allora scritto così: «tutti gli enti sono e sensibili e intelligibili». Questa
fluidità è il comune dell’umano: non la differenza ma lo scarto e nello scarto
il tra.
Il tra, la seconda parola chiave di questa conferenza, rinvia sempre ad altro
da sé, non possiede alcuna essenza, non ha nulla di proprio, non concede
identificazione, non è mai fermo. Il tra (scrive Jullien) «non ‘è’, non può
esistere di per sé». L’Occidente ha rifiutato il tra per interrogare l’‘essere’, per
dedicarsi all’ontologia e si è quindi ritrovato in un sapere dell’«al di là» e del
meta e quindi è stato destinato alla metafisica, alla ricerca di una vera vita che
sta nell’oltre della vita stessa. E così «il pensiero del vivere, tutto ad un tratto,
si è trovato abbandonato».
Per lo scarto e non nella differenza! Attraversare il tra e non cercare il
riposo in ciò che è precostituito! Questo il dettato. Si dirà chiaro e in fondo
semplice, ma tutto ciò è veramente complesso: aprirsi alla metabolizzazione
continua messa in gioco percorrendo in lungo e in largo, dai presocratici ai
decostruttivisti del tardo Novecento, sia i molteplici tra che emergono dal
pensiero Occidentale, sia le pieghe tra una metafisica e l’altra, sempre
inseguendo l’ontologia e il tra, per così dire esistenziale, fattuale, organico
(forse organico è termine sbagliato e sarebbe più corretto scrivere omoiotico,
omeopatico) dell’universo cinese, con l’enorme fatica di stare sempre nel tra,
nella impossibilità intelligente dell’intelligere continuamente al di là delle
parti. Scrive Jullien: «Credo insomma che non sia tanto da pensare l’essere
ma il tra». Aggiungerei – seguendo le tracce di Jullien e cercando a mia volta
lo scarto – che la questione non è pensare l’essere, ma invece pensare il tra e,
allora, scriverei pensare nel tra visto che il tra non è un pensare, ma – così
credo – un pensare che fa e un fare che pensa, non è l’essere ma un modo
d’essere.
Entrato nel laboratorio e appena intravisto il cantiere, non posso che
mettermi al lavoro sapendo delle profonde sintonie che sento per il luogo
mentale in cui ora mi trovo: quello di Jullien.
Mi metto al lavoro su due questioni che emergono alla fine della lezione di
Jullien: la logica e quindi l’epistemologia, l’etica e quindi la politica,
provando a mia volta a «far lavorare lo scarto», e mettendomi in posizione
nel tra (ovviamente non nel tra tra Occidente e Cina, visto che sono
totalmente incompetente di quest’ultima, ma più semplicemente tra me e
Jullien).
Ciò che viene messo in gioco nello scarto come nel tra è il concetto di
identità che sta alla base della stessa metafisica occidentale. L’identico è in
relazione stretta con l’uno e il tutto, mette in gioco il concetto di sostanza
visto che come affermava Aristotele le cose sono identiche solo se è identica
la definizione della loro sostanza. L’identico rende possibile l’articolazione di
una ontologia filosofica o, per dirlo con il linguaggio della filosofia, il
concetto di identità corrisponde all’interpretazione dell’essere predicativo
come inerenza e dell’essenza come essenza necessaria. Il predicato verbale,
l’è dell’essere, si costituisce là dove il simile conosce il simile, là dove
l’intelligere si rispecchia in se stesso, nell’identico, appunto.
Vorrei aggiungere una ulteriore argomentazione sulla questione
dell’identità, proprio per far lavorare lo scarto. L’identità ha come motore la
mimesi e quindi la sostituzione di qualcosa con qualcosa d’altro. Cosa accade
quando il ritratto si sostituisce alla persona? L’albero disegnato si sostituisce a
quello reale? L’aratro si sostituisce alle mani che scavano? Cosa cattura il
rappresentante sul (o del) rappresentato? Quale è il suo potere? Che cosa
estrapola? Quale linfa? Quale verità? Quale sostanza? Quale essenza? E la
cosa rappresentata sarà sempre la stessa anche dopo essere stata
rappresentata?
L’identità è, da questo punto di vista, ciò che resiste all’alterità e alle
pratiche sostitutive. È in essa che riposa, nella cultura occidentale, una idea di
verità come assolutezza e come universalità, è in essa che viene elaborato il
concetto di autenticità. È nella relazione mimetica che progressivamente si fa
spazio l’autonomia dell’astrazione che animerà sia il logos greco che il
pensiero scientifico moderno.
Ovviamente nel pensiero occidentale emergono anche tentativi di uscire
dall’assolutizzazione dell’identico. Ricordo il caso di Plotino (e lo ricordo
perché figura cara a Jullien) che poteva affermare che se è vero che l’uomo –
e quindi l’arte – imita la natura, è altrettanto – e provocatoriamente – vero che
la natura non usa leve. Il mondo non può risolversi nella «meccanica». Per
altro il tema identità e differenza o dell’io e dell’altro è centrale nella filosofia