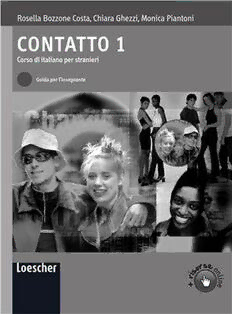Table Of Content2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina I
R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni
Contatto 1
Corso di italiano per stranieri
Guida per l'insegnante
LOESCHER EDITORE
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina II
©Loescher - 2006
http://www.loescher.it
I diritti di traduzione,di memorizzazione elettronica,di riproduzione
e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.
Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) nei limiti del 15% di ciascun volume
possono essere effettuate negli esercizi che aderiscono all’accordo tra SIAE - AIE - SNS
e CNA - Confartigianato - CASA - Confcommercio del 18 dicembre 2000, dietro pagamento
del compenso previsto in tale accordo.
Per riproduzioni ad uso non personale l’editore potrà concedere a pagamento
l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine
del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a:
Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
e-mail:[email protected].
L’editore,per quanto di propria spettanza,considera rare le opere fuori del proprio
catalogo editoriale. La riproduzione a mezzo fotocopia degli esemplari di tali opere
esistenti nelle biblioteche è consentita,non essendo concorrenziale all’opera.
Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore,
una successiva edizione,le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.
Nel contratto di cessione è esclusa,per biblioteche,istituti di istruzione,
musei ed archivi,la facoltà di cui all’art. 71-ter legge diritto d'autore.
Maggiori informazioni sul nostro sito:http://www.loescher.it/fotocopie
Ristampe
6 5 4 3 2 1 N
2011 2010 2009 2008 2007 2006
Loescher Editore S.r.l. opera con sistema qualità
certificato CERMET n°1679-A
secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000
Coordinamento editoriale:Laura Cavaleri
Redazione:Chiara Versino
Progetto grafico:Bussi & Gastaldi - Torino
Impaginazione:Softdesign - Torino
Stampa:Sograte – Città di Castello (PG)
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina III
Indice
Introduzione p. IV-X
...............................................................................................................................................................................................................
UNITÀ 1 Ciao! Bella festa, vero? p. 1
..................................................................................................................................
UNITÀ 2 Camera con vista p. 15
......................................................................................................................................................
UNITÀ 3 Cosa fai oggi? p. 29
................................................................................................................................................................
UNITÀ 4 Tu cosa prendi? p. 41
...........................................................................................................................................................
UNITÀ 5 Scusa, dov’è la fermata dell’autobus? p. 55
....................................................................................
UNITÀ 6 E tu, dove sei andato in vacanza? p. 65
..................................................................................................
UNITÀ 7 Le serve altro? p. 79
.............................................................................................................................................................
UNITÀ 8 Mi fai vedere qualche foto della tua famiglia? p. 93
........................................................
UNITÀ 9 Verrà proprio un bell’appartamento! p. 105
......................................................................................
UNITÀ 10 Come stai? p. 115
..........................................................................................................................................................................
Trascrizioni p. 129
..................................................................................................................................................................................................................
Soluzioni Dossier cultura p. 150
.......................................................................................................................................................................
III
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina IV
Introduzione
Metodologia testualicon l’obiettivo di fornire un campione di
lingua funzionale ai suoi bisogni comunicativi.
L’impostazione didattica del corso, imperniata
Nell’organizzazione dei contenuti si è privilegiata
sull’approccio comunicativo, privilegia lo svi-
una struttura “multisillabo”, che trova una
luppo della competenza pragmatico/comunicati-
realizzazione anche visiva nella scansione dell’uni-
va, cioè la capacità di parlare (e scrivere) appro-
tà, perseguendo un’equilibrata interazione tra i sil-
priatamente a seconda della situazione e dello
labi grammaticale, nozional-funzionale, lessicale e
scopo che si vuole raggiungere: ogni unità è co-
fonetico, e quelli relativi allo sviluppo delle abilità
struita tematicamente su un evento comunicativo
comunicative (comprensione orale, comprensione
caratterizzato sia dal punto di vista delle regole
scritta, produzione e interazione orale, produzio-
sociali che governano la comunicazione sia da
ne scritta) e della competenza culturale.
quello culturale.
Parallelamente, gli obiettivi di apprendimento si
realizzano, tenendo in considerazione il contribu-
to degli approcci umanistico-affettivi, che ve-
Struttura delle unità
dono lo studente al centro del processo di acqui-
sizione/apprendimento e che sono basati sul “fa- Ciascuna unità è costruita attorno a diverse situa-
re” con la lingua più che sul “lavorare” su di essa. zioni comunicative relative a diverse tematiche
Di conseguenza, grande attenzione è stata posta ed è strutturata in quattro macro-fasi: la prima
agli aspetti motivazionali, all’affettività, alla rela- prevede delle attività di motivazione per entrare
zione tra studenti all’interno del gruppo classe nel tema proposto, la seconda offre dei percorsi
(ad es. attraverso attività in coppia, gruppo e in di comprensione orale e scritta, la terza foca-
squadra), all’eliminazione dei fattori ansiogeni lizza gli aspetti funzionali, lessicali e gram-
che possono inibire l’apprendimento linguistico e maticali che interessano i contesti d’uso della
alla presentazione di testi significativi per lo stu- lingua, mentre la quarta propone attività di pro-
dente a livello di contenuti. duzione liberain cui gli studenti saranno porta-
Il corso è caratterizzato da una particolare ric- ti a reimpiegare in modo creativo quanto appreso.
chezza dell’input, con lo scopo di favorire an- Gli atti comunicativi pertinenti all’aerea tematica
che l’apprendimento passivo attraverso attività in dell’unità e significativi per questi livelli di com-
cui lo studente è concentrato sul contenuto lin- petenza (per esempio chiedere informazioni
guistico e non sulla forma. Questo, soprattutto stradali) vengono focalizzati nelle diverse sezio-
con studenti di lingue affini all’italiano, favorisce ni, laddove si presentano con maggiore evidenza.
la rielaborazione autonoma della lingua e una Queste attività, centrate sulle funzioni lingui-
maggiore rapidità di apprendimento. In particola- stiche, sono contrassegnate dall’icona . Le
re nelle registrazioni di brani audio è stata fatta attività non devono necessariamente essere svol-
una scelta in direzione della varietà sociolin- te nell’ordine in cui si presentano nel libro: pur
guisticacon speakers di diversa provenienza re- mantenendo fermo il punto di partenza delle pri-
gionale; per quanto riguarda invece la tipologia me due fasi, l’insegnante potrà decidere, seguen-
dei testi scritti ci si è proposti di presentare allo do le indicazioni fornite in guida o in base alle
studente un’ampia gamma di generi e tipologie proprie esigenze didattiche, come distribuire le
IV
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina V
Introduzione
attività di analisi, esercitazione e rinforzo degli ar- giungono parole appartenenti a sfere semantiche
gomenti lessicali, grammaticali e fonetici, nonché collegate o specifiche funzioni introdotte even-
quelle di reimpiego creativo. tualmente da nuovi testi, orali o scritti.
Ciascuna stringa di esercizi è caratterizzata da un Il lessico viene quindi presentato nel contesto di
numero, declinato con una lettera dell’alfabeto ad un testo specifico e rinforzato da esercizi nei qua-
indicare lo specifico esercizio (es. 1A). Alla fine li sono evidenziati, laddove si presentano, i mec-
della sezione o delle stringhe di esercizi sono canismi di formazione di parola (es. felice ➞ in-
spesso indicati dei rimandi alle attività della se- felice) e le collocazioni (es. un barattolo di mar-
zione eserciziin cui vengono rinforzati o appro- mellata).
fonditi medesimi argomenti ( E ). GRAMMATICA: Viene introdotta in modo in-
Particolari difficoltà o segnalazioni sono indicate duttivo con dei percorsi che stimolano la ricerca
agli studenti con l’icona attenzione! ( !! ). attiva della regola e la riflessione sull’uso delle
strutture da parte dello studente. Gli argomenti
Le sezioni che ricorrono in ogni unità sono le se- vengono esplorati attraverso un percorso che
guenti: consente di evidenziare le strutture emerse dai
testi, di analizzarle e di reimpiegarle dapprima in
PER COMINCIARE:Costituisce la fase di moti- esercizi di tipo “meccanico”, per favorire la fissa-
vazione e attivazione: il tema dell’unità viene in- zione, e successivamente in attività di produzione
trodotto attraverso fotografie e immagini collega- guidata o libera.
te a brevi attività da svolgere oralmente con lo Le strutture morfo-sintattiche previste dal sillabo
scopo di avvicinare gli studenti agli argomenti e sono presentate gradualmente, secondo un mo-
alle situazioni comunicative che verranno propo- dello “a spirale”, anche attraverso percorsi diluiti
ste, sollecitando le conoscenze pregresse sull’ar- su più unità, tenendo conto, per quanto possibile,
gomento e fornendo alcuni elementi lessicali. delle indicazioni sulle sequenze di acquisizione.
PER CAPIRE:Vengono presentati almeno un te- PRONUNCIA E ORTOGRAFIA: Viene propo-
sto orale e un testo scritto con l’obiettivo di forni- sto un breve percorso per focalizzare ed esercita-
re un input ricco e vicino alle situazioni reali e di re la pronuncia e l’ortografia. Le attività di rinfor-
potenziare le abilità ricettive. I brani degli ascolti zo della pronuncia sono particolarmente impor-
sono contrassegnati dall’icona e dal relativo tanti nelle fasi iniziali dell’apprendimento di una
numero di traccia e vanno fatti riascoltare più vol- lingua, e dovrebbero essere quindi svolte in modo
te. Anche per le letturesono proposte diverse ti- sistematico per evitare che gli errori di pronuncia
pologie di esercizi in relazione al genere di testo e si consolidino in abitudini difficili da correggere ai
allo scopo della lettura. livelli più avanzati. Gli argomenti trattati riguar-
In questa sezione non vengono in genere propo- dano i suoni vocalici e consonantici dell’italiano,
ste osservazioni sulle strutture linguistiche poi- le intonazioni (interrogativa, dichiarativa, escla-
ché il focus è sulla comprensione. Gli elementi mativa), i suoni geminati e alcune difficoltà orto-
morfo-sintattici e lessicali vengono affrontati più grafiche dell’italiano. I suoni consonantici vengo-
specificamente nelle sezioni successive. no presentati in sequenze di esercizi basate sul-
CONFRONTO TRA CULTURE: Gli aspetti cul- l’opposizione fonologica e dedicate prevalente-
turali che caratterizzano i temi e i documenti pro- mente all’identificazione e alla discriminazione
posti vengono in questa sezione esplicitamente dei suoni.
focalizzati, per consentire allo studente di riflette- PRODUZIONE LIBERA:Vengono proposte del-
re sulle specificità della cultura italiana anche at- le attività scritte e orali che prevedono il reimpie-
traverso un confronto con il proprio Paese. go creativo di quanto appreso nell’unità, a livello
LESSICO: Vengono ripresi gli elementi lessicali lessicale, funzionale e grammaticale, ma che han-
emersi nella fase di comprensione, ai quali si ag- no come focus la comunicazione dei contenuti (è
V
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina VI
Contatto 1 – Guida per l’insegnante
privilegiata quindi la fluenza rispetto alla corret- ta sulle strategie di apprendimento, cioè le
tezza). Queste attività non devono essere neces- operazioni mentali e le azioni concrete che l’ap-
sariamente svolte tutte a chiusura dell’unità di la- prendente mette in atto (o dovrebbe mettere in
voro, ma è necessario verificare che le strutture atto) per facilitare e rendere più efficace l’esecu-
linguistiche richieste siano già state affrontate. zione di un compito, imparando a gestire con
Nella guida viene quindi specificato il momento maggiore consapevolezza il proprio percorso di
più indicato per integrare ciascuna delle produ- apprendimento.
zioni libere orali e scritte nel percorso dell’unità. Le schede focalizzano le principali strategie rela-
SINTESI: Vengono ricapitolate le funzioni lin- tive allo sviluppo delle quattro macro abilità
guistiche e gli argomenti grammaticali focalizza- (ascoltare, leggere, parlare, scrivere) e all’ap-
ti nell’unità con esempi generalmente tratti dai prendimento del lessico.
testi. L’importanza del lavoro sulle strategie è talvolta
La sintesi funzionale può essere utile per sintetiz- ostacolata dalla difficoltà di proporre e stimolare
zare e richiamare alla memoria le strutture appre- riflessioni che richiedono una discreta competen-
se, soprattutto nella fase di preparazione di attivi- za linguistica. Nel caso di classi monolingui rite-
tà di produzione come i Role-play. niamo che questa riflessione possa essere condot-
Per gli argomenti che vengono presentati in più ta anche con il supporto della lingua materna,
unità, viene evidenziato un rimando all’unità in mentre nella classi plurilingui sarà fondamentale
cui è inserita la tavola di sintesi. l’opera di facilitazione/semplificazione dell’inse-
DOSSIER CULTURA: Gli aspetti culturali, che gnante. In ciascuna scheda vengono proposte del-
le riflessioni di carattere generale (che possono
sono già focalizzati con varie attività all’interno
quindi essere liberamente trasferite dall’inse-
delle unità e più specificatamente nei box Con-
gnante a diversi materiali) esemplificate attraver-
fronto tra culture, vengono ripresi e approfondi-
so specifiche attività presenti nelle diverse unità.
ti in quattro specifici Dossier su alcuni degli ar-
Espliciti rinvii alla sezione sulle strategie vengono
gomenti emersi nelle unità che precedono i dos-
segnalati all’interno di ciascuna guida all’unità.
sier stessi: Il tempo libero (alla fine dell’unità 3,
SOLUZIONI:Nel volume si trovano le chiavire-
p. 54); Un po’ di geografia (alla fine dell’unità 5,
lative alla sezione esercizi. Le chiavi delle attività
p. 92); Che cos’è il Made in Italy (alla fine del-
contenute nelle unità sono invece in questa gui-
l’unità 7, p. 130); La popolazione (alla fine del-
da, così come le trascrizioni dei brani audio sia
l’unità 9, p. 168).
delle unità che della sezione esercizi.
SEZIONE ESERCIZI: Si trova alla fine delle 10
unità, è composta di pagine a un colore numerate
da 1 a 92 ed include attività che integrano i mate-
riali presentati nel corso dell’unità. Gli esercizi, da
20 a 25 per unità, sono di varia natura (compren-
sione orale, comprensione scritta, lessico, fun-
zioni, grammatica e pronuncia/ortografia) e ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO
possono essere svolti autonomamente dagli stu- DELLE ATTIVITÀ
denti oppure in classe per approfondire o rinfor-
Comprensione orale
zare alcune strutture o abilità.
Gli esercizi contrassegnati dall’icona espansione L’ascolto “autentico” è un’attività in cui è richie-
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ introducono argomenti correlati ma non fo- sta allo studente la comprensione dei contenuti,
calizzati nei percorsi dell’unità, e dovrebbero pre- delle informazioni e non della forma in cui vengo-
feribilmente essere svolti in classe. no veicolati.
STRATEGIE: Al termine della sezione esercizi È bene spiegare anche ricorrendo alla L1 o a una
sono presenti alcune schede di riflessione esplici- lingua veicolare che l’attività di ascolto è molto
VI
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina VII
Introduzione
importante perché si impara primaa capire e poi te prevista nel manuale – in cui introdurre la si-
a parlare. tuazione in cui si svolgerà la conversazione, chi
È quindi essenziale che l’insegnante rassicuri fin sono gli interlocutori, e invitare gli studenti a fare
dall’inizio gli studenti dicendo che: l’ascolto è previsioni, almeno mentalmente se non sono in
un’attività difficileperché le parole volano e per- grado di esplicitarle verbalmente, su che cosa gli
ché, a differenza della lettura, non si può imporre interlocutori si diranno.
all’attività un ritmo personale; non si deve capire Invitate gli studenti a rilassarsi e proponete un
tutto; non è importante quanto si capisce ma ascolto senza correggere, seguito da un confronto
è fondamentale allenarsi. a coppie(o in plenum se troppo difficile) su cosa
ricordano. Ad ogni nuovo ascolto potete dare, se
Prima di iniziare l’attività di ascolto è importante sono previste più attività sullo stesso brano, un
discutere con gli studenti sulle modalità di com- nuovo compito da svolgere che motivi il riascolto.
prensione (vedi nella sezione Strategie, p. 93). Potete prevedere una fase di verifica finale
Scrivete sulla lavagna, CAPIRE – NON CAPIRE plenaria, che di solito viene richiesta dagli stu-
e chiedete alla classe se è vero che quando si denti, avendo tuttavia chiaro che la verifica non
ascolta si capisce tutto o non si capisce niente; serve ad accrescere la capacità di comprensione,
cercate di convincerli che si tratta di una dicoto- ma a togliere gli studenti da eventuali situazioni
mia falsa e che quando si ascolta si capisce sem- di incertezza.
pre almeno un po’ (ad es. una parola, un’intona-
zione) e che comunque si possono fare ipotesi.
Ascolto analitico
Spiegate che la comprensione è una questione di
È un’attività in cui l’attenzione dello studente è
gradi, facendo alla lavagna il grafico:
focalizzata sulla forma, su alcune strutture della
lingua che deve cercare di capire allo scopo di
100% completare un frammento di testo. Queste strut-
tutto
ture saranno poi oggetto di analisi e riflessione; si
tratta dunque di un’attività di esplorazione indut-
CAPIRE
tiva della grammatica. L’ascolto analitico viene in
genere proposto su brevi frammenti (di massimo
40”) di un brano sul quale è già stato fatto del la-
| | | | | | voro autentico.
niente 1 2 3 4 …
Chiedete agli studenti di ascoltare più volte (mi-
nimo 4/5 volte di seguito) il frammento allo sco-
“Tra capire tutto e capire niente posso capire un po di riempire i buchi con gli elementi mancanti,
po’ di più ad ogni ascolto, ad esempio posso pormi spiegando che devono cercare di usare nell’eser-
come obiettivo del primo ascolto di capire l’1% e cizio di completamento sia l’orecchio che la logi-
aumentare la percentuale negli ascolti successi- ca. Potete prevedere, dopo una serie di ascolti,
vi”. Ecco perché è fondamentale fare più ascolti un confronto delle versioni in coppia, chiedendo
dello stesso testo, negoziando con la classe il nu- di provare a completare insieme gli eventuali
mero di riascolti da fare (2,3,4) affinché gli stu- “buchi” rimasti usando le loro conoscenze gene-
denti si ritengano soddisfatti. rali. Quindi fate riascoltare ancora una volta per
Spiegate che gli ascolti che faranno sono tutti verificare l’adeguatezza delle loro ipotesi. Nella
“difficili” perché sono quelli che permettono di fase di verifica finale, fornite, in modo interattivo
fare progressi reali. (non dando cioè subito voi le risposte ma chie-
Per favorire la comprensione è necessario pro- dendo alla classe), la versione corretta del brano
porre sempre una fase di attivazione (“Prima che vi servirà da spunto per fare della riflessione
dell’ascolto”)–anche quando non è esplicitamen- grammaticale.
VII
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina VIII
Contatto 1 – Guida per l’insegnante
Comprensione scritta vità l’insegnante può fornire del feedbak e chie-
dere agli studenti se sono presenti nel testo paro-
Le attività di lettura si basano in genere, come
le o espressioni che non sono chiare.
per l’ascolto, su un approccio di tipo ricorsivo: lo
studente viene invitato a leggere più volte un te-
sto, ogni volta con obiettivi specifici, con una pro-
gressione che va dal globale all’analitico.
Produzione orale
Questa impostazione didattica ha l’obiettivo di
abituare lo studente ad applicare strategie di Fin dai primi momenti viene offerta la possibilità
lettura che già utilizza nella propria lingua ma- allo studente di esprimersi oralmente, per prati-
dre, per stimolare la consapevolezza che non esi- care la propria interlingua e per riconoscerne i li-
ste un unico modo di leggere un testo, ma modi miti e soprattutto per sperimentare le prime for-
diversi per scopi diversi. me di comunicazione. È importante sapere che
È particolarmente importante, a questo livello, la- nell’apprendimento delle lingue è possibile che si
vorare su strategie socio-affettive per convincere verifichi una fase di silenzio in cui lo studente,
che non è necessario capire parola per paro- impegnato con la decodifica dei suoni e dei signi-
la un testo, anzi che è sconsigliabile, così come è ficati nella nuova lingua, non è in grado di produr-
da scoraggiare, nei limiti del possibile, l’uso del re; questa fase, di durata variabile, va quindi ri-
dizionario. spettata privilegiando le attività di comprensione,
Nella sezione Strategie, pp. 94-95 sono evidenziate di pronuncia e un’interazione dipendente dal con-
diverse tecniche che andrebbero adottate in fun- testo, basata anche sulla gestualità.
zione del tipo di compito: la lettura esplorativa/ Per tale ragione sono stati previsti alcuni esercizi
selettiva (scanning) con cui lo studente scorre ripetitivi allo scopo di memorizzare routines
velocemente il testo avanti e indietro alla ricerca conversazionali praticando la lingua in maniera
di un’informazione specifica (ad esempio percen- non ansiogena, poiché viene richiesta una ripeti-
tuali); quella orientativa (skimming) che ser- zione senza rielaborazione personale.
ve a seguire velocemente lo sviluppo sequenziale Tenete presente che anche nelle attività più libe-
del testo per cogliere il contenuto generale; quel- re la produzione linguistica dello studente sarà
la globale che prevede una lettura lineare del te- limitata e con molti errori; non dovete tuttavia
sto soffermandosi sui nuclei portanti del contenu- censurarla ma al contrario incoraggiarla. È infat-
to. Durante le prime attività è quindi importante ti fondamentale, nelle attività di produzione libe-
che lo studente, in base alla consegna, scelga la ra, non evidenziare gli errori commessi da-
modalità di lettura più adeguata. Per aiutare gli gli studenti o correggerli ma favorire nello
studenti ad applicare strategie adeguate a studente l’idea che il focus dell’attività è sulla ca-
testi/scopi specifici potete fornire un tempo li- pacità di farsi capire, piuttosto che sulla forma
mite, da stabilire di volta in volta, in relazione a della lingua.
ciascun tipo di lettura che chiedete di svolgere. Le tecniche didattiche per lo sviluppo della pro-
Per quanto riguarda le modalità di presentazione duzione orale favoriscono le attività in
delle attività di lettura si consigliano tre momenti: coppia/gruppo con i pari e vi permettono quindi
prima della lettura in cui in plenum o a cop- di rimanere fuori dall’interazione e di organizzare
pie/gruppi si motivano gli studenti alla lettura e si come un “regista”la scena. Per la buona riuscita
forniscono parole chiave per la comprensione del delle attività di produzione libera è fondamentale
testo, durante la letturain cui è previsto un la- curare nei dettagli i diversi momenti del percorso:
voro individuale attraverso più letture fatte a bas- 1) la consegna in cui spiegate l’attività e fornite
sa voce, ciascuna con un obiettivo specifico; do- informazioni sul luogo della comunicazione, sul
po la lettura: in cui si confrontano i propri risul- ruolo dello studente (reale o immaginario) e
tati con quelli dei compagni. Al termine dell’atti- del/dei compagno/i, e sullo scopo dell’attività; 2)
VIII
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
2663_Contatto_00_romane 28-03-2006 12:12 Pagina IX
Introduzione
l’organizzazione in cui fornite un tempo limite e rimentare anche questa modalità di comunicazio-
organizzate lo spazio in funzione della situazione ne, abituandosi a scoprire e ad utilizzare le speci-
comunicativa (ad esempio se l’attività è un Role ficità della lingua scritta e di alcuni generi testuali
playin cui gli studenti devono interpretare il ruo- (cartoline, lettere, e-mail).
lo di un impiegato di un agenzia turistica e di un Nella fase di produzione libera, è essenziale far
cliente è importante che siano collocati uno di capire agli studenti che l’obiettivo della scrit-
fronte all’altro possibilmente con un tavolo tra di tura è la comunicazione, più che la correttezza
loro); 3) l’interazione durante la quale gli stu- formale del messaggio. Ciascuno deve pian piano
denti comunicano tra di loro e voi restate invece acquisire la consapevolezza di potersi esprimere
in secondo piano, pur avendo un ruolo attivo, nel per iscritto, anche se in modo semplice e talvolta
fornire consulenza linguistica su richiesta, e nel- approssimativo. A conclusione dell’attività di
l’ascoltare gli studenti per recuperare informazio- scrittura, tuttavia, è estremamente importante
ni importanti sullo sviluppo della loro interlingua, dare spazio a un momento di riflessione sulla pro-
annotando errori che potrete, se lo ritenete op- duzione scritta, particolarmente con gli appren-
portuno, riprendere in un momento successivo; denti adulti che in genere richiedono esplicita-
4) la conclusione in cui, al termine del tempo as- mente un feedbacksulla natura dei loro errori. La
correzione degli erroriserve infatti a stimolare
segnato, interrompete l’attività e vi complimenta-
negli apprendenti la capacità di riflettere sulla
te con gli studenti per la quantità (non per la qua-
lingua e sul proprio apprendimento, nonché a
lità) di lingua prodotta, confrontandovi sul rag-
evitare di consolidare alcune abitudini linguisti-
giungimento dell’obiettivo dell’attività.
che errate.
Role-play
Quando e come correggere?
Si tratta di attività molto delicate in cui gli stu-
Perché la correzione non sia un’esperienza fru-
denti devono mettersi in gioco, rischiando di per-
strante e poco produttiva, è opportuno chiedersi
dere la faccia, per cui l’insegnante deve prestare
che cosa sia più importante correggere e che im-
particolare attenzione nella formazione delle cop-
portanza dare all’errore – a seconda degli obiettivi
pie e nell’assegnazione dei ruoli. Per la buona riu-
didattici e del tipo di studente –, tenendo presen-
scita dell’attività, è opportuno: introdurre agli
te che alcuni errori sono non solo inevitabili, ma
studenti in maniera precisa la situazione comu-
anche spie di un apprendimento in corso. Ecco al-
nicativa e specificare che dovranno interpretare
cune “linee guida” che potranno aiutarvi a indivi-
un ruolo diverso dal proprio; fornire a ciascuno
duare criteri e modalità per la correzione: 1) te-
la schedacon la descrizione del proprio ruolo; la-
nete distinta la correzione dalla valutazione e ab-
sciare del tempo per raccogliere le idee e
biate un atteggiamento di comprensione che
prepararsi a recitare la propria parte; organizza-
non stigmatizzi l’errore; 2) rispettate quanto più
re lo spazio e dare un tempo minimo in cui
possibile l’intenzione comunicativa, sforzando-
devono parlare.
vi di non “interpretare”o modificare quanto han-
no cercato di esprimere; 3) fate attenzione alla
specificità dello studente sia in relazione al ti-
po di errori (ad es. errori dovuti all’interferenza
Produzione scritta: la correzione
della lingua materna che possono fossilizzarsi)
degli errori
che alla sua personalità (uno studente introverso
Nelle prime fasi dell’apprendimento, la scrittura sarà maggiormente penalizzato e demotivato da
ha un ruolo più marginale rispetto alle abilità ri- una correzione sistematica degli errori ); 4) adot-
cettive e alla produzione orale, ma è importante tate modalità di correzione che mettano lo stu-
che gli studenti siano portati sin dall’inizio a spe- dente in condizioni di intervenire attivamente
IX
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione