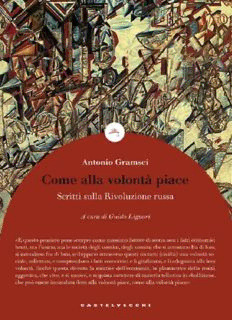Table Of ContentLadri di Biblioteche
Questo ebook è stato condiviso per celebrare il
Centenario della Rivoluzione russa
1917-2017
Le Boe
Prima edizione digitale 2017
© 2017 Lit Edizioni Srl
Tutti i diritti riservati
Castelvecchi è un marchio di Lit Edizioni Srl
Sede operativa: Via Isonzo 34, 00198 Roma
Tel. 06.8412007 – fax 06.85358676
[email protected]
www.castelvecchieditore.com
Antonio Gramsci
COME ALLA VOLONTÀ PIACE
Scritti sulla Rivoluzione russa
A cura di Guido Liguori
Introduzione
Gramsci e le due rivoluzioni russe del 1917
1.
Quando arrivarono in Italia gli echi della prima Rivoluzione russa del 1917,
quella che ebbe luogo tra il 23 e il 27 febbraio, secondo il calendario allora
vigente in quel Paese (tra l’8 e il 12 marzo, per il calendario in vigore in
Occidente), Antonio Gramsci aveva 26 anni, viveva a Torino e lavorava dal
dicembre 1915 per la stampa socialista di quella città, ovvero per l’edizione
torinese dell’«Avanti!» e per il settimanale dei socialisti torinesi «Il Grido del
Popolo». La terribile “guerra di trincea” in cui era impelagata l’Europa
dall’estate del 1914 e l’Italia dal maggio dell’anno successivo aveva già
provocato centinaia di migliaia di morti e costretto a difficili condizioni di vita le
popolazioni civili di molte nazioni belligeranti. Proprio nel corso del 1917 il
rifiuto della guerra avrebbe scosso con forza diversi Paesi, provocando
diserzioni, sommosse, rivolte1. Dal 22 al 27 agosto di quell’anno proprio a
Torino sarebbe scoppiata una grande “rivolta del pane”, un vasto moto popolare
spontaneo, il maggiore che si ebbe in Europa (eccezion fatta per gli avvenimenti
di Russia), in seguito al quale una nuova ondata repressiva si sarebbe abbattuta
sui socialisti torinesi. La guerra prima, con numerosi dirigenti e militanti
chiamati sotto le armi, e gli arresti seguiti alla “rivolta del pane” poi, favorirono
l’emergere di Gramsci come dirigente politico e come giornalista, facendolo tra
l’altro assurgere al ruolo di direttore del settimanale del partito.
Già nei mesi e negli anni precedenti, tuttavia, egli si era distinto per lo
sguardo acuto e spesso anticonvenzionale con cui seguiva e commentava
quotidianamente gli avvenimenti sociali, politici e culturali torinesi, italiani e
anche internazionali. Nella sua attività di giornalista militante Gramsci metteva
al lavoro un armamentario teorico e culturale anomalo per il socialismo del
tempo. Sarà proprio tale bagaglio che gli permetterà di sintonizzarsi
immediatamente coi fatti di Russia del 1917, di comprenderne – sia pure non
senza ingenuità e successive correzioni – la grande portata. Conviene dunque
fare un passo indietro per capire come il giovane Gramsci fosse giunto a questo
appuntamento con la storia, che sarà decisivo anche per i suoi destini di essere
umano e di militante schierato dalla parte di quelle “classi subalterne” in cerca di
riscatto, classi che dal 1917 e per lungo tempo avrebbero cercato proprio di “fare
come in Russia”.
2.
Nato ad Ales, in Sardegna, il 22 gennaio 1891, Antonio Gramsci aveva
trascorso una infanzia non facile, sia perché colpito in tenera età dal morbo di
Pott (una forma di tubercolosi ossea), sia per l’arresto e la condanna per
irregolarità amministrative del padre, impiegato dell’ufficio delle imposte di
Sorgono, nel 1894-1895, evento che gettò la famiglia (numerosa) in una
situazione di gravissime difficoltà economiche. Costretto anche a sospendere lo
studio dopo le scuole elementari e a lavorare per due anni presso l’ufficio del
catasto del paese della madre, Ghilarza, dove la famiglia si era ritirata per
cercare di sopravvivere, il piccolo Antonio riuscì a riprendere la scuola,
mostrando grandi doti di intelligenza e volontà. Dopo il liceo, frequentato dal
1908 a Cagliari, grazie anche al fratello Gennaro, che era contabile presso la
locale Camera del lavoro, nel 1911 Nino (come era chiamato da ragazzo) si era
trasferito a Torino per frequentare la Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo di
filologia moderna, grazie al conseguimento di una borsa di studio che tuttavia
non fu sufficiente a evitargli ancora gli stenti e le sofferenze che caratterizzavano
la vita di uno studente povero, meridionale e proveniente dalla provincia, in una
grande città settentrionale e industriale come Torino.
In Sardegna Gramsci aveva iniziato a leggere libri e riviste di quella cultura
d’opposizione (al positivismo, e sul piano politico a Giolitti e al giolittismo) che
fu il terreno proprio della sua formazione: il meridionalismo di Salvemini e le
“riviste fiorentine” come «Il Leonardo» e «La Voce» di Papini e Prezzolini, che
agitavano motivi filosofici – dal neoidealismo al pragmatismo, al bergsonismo –
convergenti nella rivalutazione del “soggetto” contro l’“oggettivismo” di matrice
positivistica, che aveva influenzato in modo determinante anche le principali
correnti del socialismo del tempo.
All’Università di Torino Gramsci aveva subìto l’influenza di Matteo Bartoli,
docente di glottologia, che voleva avviarlo agli studi di linguistica e alla carriera
universitaria, e dal quale deriverà sia una impostazione di tipo storicistico, sia la
convinzione della importanza del «prestigio» culturale. Accanto agli studi di
linguistica, era stato rilevante l’approfondimento del pragmatismo italiano di
Vailati e di quello statunitense di William James; la lezione di Georges Sorel,
che ispirandosi anche a Henri Bergson aveva criticato il movimento socialista
ufficiale da posizioni di attivismo rivoluzionario; l’incontro con la lezione di
Francesco De Sanctis e col neoidealismo di Benedetto Croce, che stava
determinando in Italia una nuova egemonia culturale antipositivistica; la filosofia
della praxis su cui avevano richiamato l’attenzione il primo marxista italiano,
Antonio Labriola, e il filosofo neohegeliano Giovanni Gentile, studioso di Marx
che aveva sottolineato l’importanza delle marxiane Tesi su Feuerbach, che
saranno uno dei testi di riferimento fondamentali per il Gramsci maturo, poiché
in esse Marx aveva insistito su una visione dialettica della realtà, non sbilanciata
né dal lato del soggetto e dell’idealismo né da quello del mondo oggettivo e del
materialismo2.
Da tutte queste componenti della sua prima formazione il giovane Gramsci
aveva tratto soprattutto un aspetto fondamentale: il ruolo della volontà,
dell’azione soggettiva, della prassi ai fini della trasformazione della realtà. Il
socialismo prevalente, economicistica e determinista, evoluzionista e riformista,
proprio di Turati, di Treves, di Bissolati, era incline a ridimensionare la funzione
del soggetto (collettivo) per esaltare le leggi oggettive (o presunte tali) della
società e della storia, con annesso il mito dell’inevitabile progresso e del trionfo
inesorabile del socialismo. Esso sembrava escludere ogni ribellismo, ogni
volontarismo rivoluzionario, caratteri maturati in Gramsci nel clima delle
ingiustizie patite in Sardegna e a contatto con la sua terra, povera e sfruttata al
pari di una colonia, come più in generale l’Italia meridionale.
Il marxismo di Gramsci era allora in molti tratti approssimativo, troppo
influenzato dall’idealismo, troppo limitato nella conoscenza di Marx (che
inizierà davvero proprio dopo e a motivo dell’Ottobre), ma era comunque vitale,
innovativo, rivoluzionario, caratterizzato da una torsione volontaristica e
soggettivistica, in opposizione sia alla cultura “ufficiale” del tempo, giolittiana e
positivistica, sia al socialismo riformista, economicista e determinista,
caratteristiche che il vecchio socialismo italiano condivideva con quasi tutta la
cultura della Seconda Internazionale. Gramsci paventava nel riformismo
socialista una deriva “fatalistica”, ovvero il pericolo che – una volta ritenuto
inevitabile il socialismo, per le leggi certe della storia – ne sarebbe scaturita la
conseguenza di un atteggiamento passivo, di azione politica di piccolo
cabotaggio, in attesa che la nuova società scaturisse dalle contraddizioni
oggettive del capitalismo, senza il faticoso e rischioso intervento della
soggettività rivoluzionaria.
La Torino del tempo non era solo una capitale culturale, era anche la più
grande città industriale d’Italia. A Torino Gramsci divenne definitivamente
socialista, incontrando la classe operaia di quella città – una delle classi operaie
più numerose e forti dell’epoca, in una città industriale dove andavano già
nascendo colossi come la Fiat – e il movimento socialista che da tale classe
operaia traeva forza. Gramsci si iscrisse al Partito socialista italiano tra il 1913 e
il 1914, il suo debutto politico avvenne con un articolo intitolato Neutralità
attiva e operante, pubblicato su «Il Grido del Popolo» il 31 ottobre 19143. Lo
scritto suscitò molte polemiche, poiché cercava di fornire una lettura “di sinistra”
delle posizioni di Mussolini, che stava rapidamente convertendosi a favore
dell’intervento nella Prima guerra mondiale. In realtà Gramsci vi avanzava una
posizione non molto lontana da quella che – in modo certo molto più maturo e
consapevole – aveva espresso Lenin: i socialisti dovevano trasformare la guerra
in una occasione rivoluzionaria. Del resto, il partito di Lenin, il Partito operaio
socialdemocratico russo (frazione bolscevica), e il Partito socialista italiano
furono i due partiti principali tra quelli che, nell’ambito della Seconda
Internazionale, si rifiutarono di appoggiare i rispettivi Stati nell’avventura
bellica, anche se i socialisti italiani nella loro maggioranza furono più titubanti,
divisi e pilateschi, attestandosi sul celebre “né aderire né sabotare” (secondo il
motto coniato dal segretario del partito, Costantino Lazzari). Proprio questo
atteggiamento nascondeva per il giovane Gramsci una pericolosa posizione di
inerzia4 e denotava l’assoluta incapacità del Psi di volere e di preparare la
rivoluzione.
Isolato a causa della sua presa di posizione e per qualche tempo in disparte,
Gramsci rientrò ben presto nella vita attiva del partito grazie alla guerra, che a
esso sottraeva quadri e dirigenti. Gramsci giornalista militante si impose per la
vastità dei campi di intervento e per l’originalità delle sue lenti analitiche. Negli
scritti del 1915-1916 questo giovane venticinquenne mostrava una cultura del
tutto diversa da quella della maggior parte dei suoi compagni: uno storicismo di
stampo idealistico, una interpretazione della storia e della società in cui si faceva
già strada l’importanza delle idee e delle sovrastrutture per il cambiamento
politico e sociale, un soggettivismo antideterministico che faceva tutt’uno con la
riaffermazione dell’importanza della volontà. Che significava anche voler
prendere parte, rifuggire dalla passività, odiare gli indifferenti e l’indifferenza,
secondo quanto recitava un celebre articolo pubblicato nel “numero unico” di
«La città futura», che Gramsci da solo aveva redatto e scritto per i giovani
socialisti e che uscì l’11 febbraio 1917.
Tutto ciò che era volontà, attività del soggetto, iniziativa rivoluzionaria, era
importante per il giovane Gramsci. Non sorprende che, con questa impostazione
culturale e politica, egli vide nella Rivoluzione russa una conferma di enorme
prestigio per le sue convinzioni.