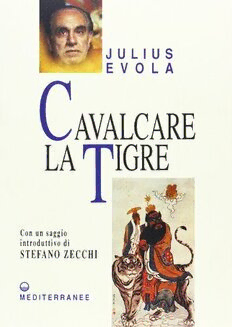Table Of ContentJULIUS EVOLA
Cavalcare la tigre
Orientamenti esistenziali per un'epoca della dissoluzione
Quinta edizione corretta e con una Appendice
Saggio introduttivo di Stefano Zecchi
EDIZIONI
MEDITERRANEE
JULIUS EVOLA
Julius Evola (19 maggio 1898 - 11 giugno 1974), nasce a Roma da fami-
glia di nobili origini. Formatosi sulle opere di Nietzsche, Michelstaedter e
Weininger, partecipa alla prima guerra mondiale come ufficiale di artiglie-
ria. L'esperienza artistica lo avvicina a Papini e a Marinetti, a Balla e a
Bragaglia, ma è l'incontro epistolare con Tzara che lo impone come princi-
pale esponente di Dada in Italia: dipinge ed espone i suoi quadri a Roma e
Berlino, collabora alle riviste Bleu e Noi, elabora testi teorici (Arte
astratta, 1920, definito da M. Cacciari "uno degli scritti più filosoficamen-
te pregnanti delle avanguardie europee"); scrive poemi e poesie (La parole
obscure du paysage intérieur, 1921).
Iscrittosi alla facoltà di Ingegneria, giunto alle soglie della laurea, vi rinun-
cia per disprezzo dei titoli accademici. Il dadaismo - di cui oggi viene con-
siderato il maggior esponente italiano - è però solo un primo passo per
"andare oltre": completa un suo ampio lavoro filosofico iniziato nelle trin-
cee del Carso, che intende presentarsi come un superamento dell'idealismo
classico e lo fa precedere da una raccolta di scritti (Saggi sull'idealismo
magico, 1925; Teoria dell'individuo assoluto, 1927; Fenomenologia
dell'individuo assoluto, 1930).
Attira l'attenzione di Croce, Tdgher e Calogero. Contemporaneamente
scopre le dottrine di realizzazione estremo-orientali, cura una versione ita-
liana del Tao-tè-Ching (Il Libro della Via e della Virtù, 1923) e pubblica la
prima opera italiana sui Tantra (L'uomo come potenza, 1926), seguita da
un libro molto polemico sui rapporti tra fascismo e cristianesimo
(Imperialismo pagano, 1928).
Diviso tra l'elevazione spirituale dell'Io e gli interventi nella vita culturale
del tempo, collabora a Ignis, Atanor, Bilychnis e pubblica i quaderni men-
sili di Ur (1927-1928) e Krur (1929), dove scrivono Reghini, Colazza,
Parise, Onofri, Comi, Servadio; poi il quindicinale La Torre (1930), chiuso
per le sue interpretazioni troppo eterodosse del fascismo.
Continua la sua indagine sulle forme di realizzazione interiore e si interes-
sa quindi di alchimia (La tradizione ermetica, 1931), di neo-spiritualismo
(Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo, 1932), di leggende
cavalleresche ed esoteriche (Il mistero del Graal, 1937).
Alla base della sua Weltanschauung antimoderna, antimaterialista, antipro-
gressista - che gli faceva criticare sia bolscevismo che americanismo, con-
siderati due facce della stessa medaglia nel saggio omonimo apparso sulla
Nuova Antologia (1929) - c'è Rivolta contro il mondo moderno (1934), la
sua opera più importante e famosa, ampio panorama della civiltà tradizio-
nale contrapposta alla civilizzazione contemporanea. "Dopo averlo letto ci
si sente trasformati" scrisse Gottfried Benn. Cerca d'introdurre queste
tematiche nel dibattito di quegli anni curando la pagina "Diorama filosofi-
co" (1934-1943) del quotidiano II Regime Fascista di Cremona, che ospitò
tutte le migliori firme degli intellettuali conservatori dell'epoca. Sviluppa
anche contatti personali con questi ambienti tenendo molte conferenze,
soprattutto in Germania.
Fa conoscere in Italia autori come Spengler, Guénon, Meyrink, Bachofen.
Fra il 1935 e il 1943 s'interessa - ben prima che l'argomento diventasse
d'attualità - allo studio ed all'esame dei problemi delle razze, "respingen-
do ogni teorizzazione del razzismo in chiave esclusivamente biologica" (R.
De Felice); e scrive: Tre aspetti del problema ebraico (1936), Il mito del
sangue (1937), Indirizzi per una educazione razziale (1941), Sintesi di dot-
trina della razza (1941), che suscita l'interesse di Mussolini il quale lo
convoca a Palazzo Venezia nel settembre di quell'anno: "E' il libro che ci
occorreva", gli disse.
In piena guerra, quasi l'indicazione di una via da seguire, pubblica un sag-
gio sull'ascesi buddhista: La dottrina del risveglio (1943). Dopo l'8 set-
tembre raggiunge fortunosamente la Germania. Nel 1945, a Vienna, poco
prima dell'ingresso dei sovietici, si trova coinvolto in un bombardamento
e, in seguito ad una lesione al midollo spinale, subisce una paresi agli arti
inferiori.
Rientra in Italia nel 1948 ed è ricoverato a Bologna, quindi tornerà a Roma
nel 1950. Ma non è rimasto inattivo, perché tra un ospedale e un altro
riscrive il giovanile L'uomo come potenza, che diventa Lo Yoga della
potenza (1949), rivede ed adatta i testi apparsi in Ur e Krur nei tre volumi
di Introduzione alla Magia quale Scienza dell'io (1955-6) e inizia nuove
collaborazioni giornalistiche che gli procureranno anche una avventura
giudiziaria da cui uscirà completamente scagionato (il cosiddetto "proces-
so dei FAR", 1950-1).
L'opuscolo Orientamenti (1950) contiene in nuce tutte le posizioni poi svi-
luppate in tre libri successivi, dove sono esposte le sue idee per vivere nel
mondo del post-1945 che sempre più Evola vede come espressione dell'età
ultima, il Kali-yuga, l'era oscura: quelle sulla politica in Gli uomini e le
rovine (1953), sull'erotismo in Metafisica del sesso (1958) e sugli orienta-
menti esistenziali in Cavalcare la tigre (1961).
Nel 1963 viene riscoperto come dadaista: Enrico Crispolti organizza una
mostra dei suoi quadri alla Galleria "La Medusa" di Roma. Seguono
un'autobiografia attraverso i suoi libri (Il cammino del cinabro, 1963), un
saggio d'interpretazione storico-ideologica (Il fascismo, 1964), due volumi
miscellanei (L'arco e la clava, 1968; Ricognizioni, 1974), la raccolta di
tutte le sue poesie (Raaga Blanda, 1969).
Fonda e dirige per le Edizioni Mediterranee dal 1968 al 1974 - anno della
sua scomparsa - la collana "Orizzonti dello Spirito", nella quale inserisce
opere e autori dei più ampi e diversi orientamenti spirituali e tradizionali.
L'ultima fase della vita vede Julius Evola nella insospettata veste di un anti-
Marcuse: il nascere della "contestazione" anche in Italia (1968) fa riscoprire
il suo pensiero non solo a "destra" ma anche a "sinistra", talché nel periodo
1968-1973 una dozzina di suoi libri vengono ristampati una o anche due
volte, mentre suoi interventi sono richiesti da varie riviste. Un mese prima
della morte, detta lo statuto della Fondazione che prende il suo nome.
Dopo la sua scomparsa sono state pubblicate numerose scelte antologiche
- a tema e non - di suoi articoli e saggi.
Quadri e disegni di Julius Evola sono presso musei e collezioni private
(Paesaggio interiore ore 10.30 è alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a
Roma). I suoi saggi e i suoi libri sono stati tradotti e pubblicati in
Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Svizzera, Gran Bretagna,
Russia, Stati Uniti, Messico, Canada.
Indice
Nota del Curatore 7
Evola, o una filosofia della responsabilità contro il nichilismo,
di Stefano Zecchi. 13
ORIENTAMENTI
1. Mondo moderno e uomini della Tradizione 19
2. Fine di un ciclo.«Cavalcare la tigre» 23
NEL MONDO DOVE DIO È MORTO
3. Il nichilismo europeo. Dissoluzione della morale 29
4. Dai precursori alla «gioventù bruciata» e alla «contestazione» 32
5. Coperture del nichilismo europeo. Il mito economico-sociale e la
«contestazione» 37
6. Il nichilismo attivo. Nietzsche 42
7. «Essere se stessi» 48
8. La dimensione della trascendenza. «Vita» e «più che vita» 52
9. Di là da teismo e da ateismo 57
10. Invulnerabilità. Apollo e Dioniso 61
11. L'agire senza desiderio. La legge causale 68
IL VICOLO CIECO DELL'ESISTENZIALISMO
12. Essere e esistenza inautentica 77
13. Sartre: la prigione senza muri 80
14. L'esistenza, «progetto gettato nel mondo» 82
15. Heidegger: fuga in avanti e «essere per la morte». Collasso
dell'esistenzialismo 89
DISSOLUZIONE DELL'INDIVIDUO
16. Duplice aspetto dell'anonimìa 97
17. Distruzioni e liberazioni nel nuovo realismo 102
18. L'«ideale animale». Il sentimento della natura 107
DISSOLUZIONE DELLA CONOSCENZA - IL RELATIVISMO
19.1 procedimenti della scienza moderna
20. Copertura della natura. La «fenomenologia»
IL DOMINIO DELL'ARTE - DALLA MUSICA «FISICA» AL REGIME
DEGLI STUPEFACENTI
21. La malattia della cultura europea
22. La dissoluzione nell'arte moderna
23. Musica moderna e jazz
24. Parentesi sulle droghe
La DISSOLUZIONE NEL DOMINIO SOCIALE
25. Stati e partiti. L'apolitìa
26. La società. La crisi del sentimento di patria
27. Matrimonio e famiglia
28. Le relazioni fra i sessi
IL PROBLEMA SPIRITUALE
29. La «seconda religiosità»
30. La morte. Il diritto sulla vita
APPENDICE: Interviste 1964-1972
Cattivi maestri, cattivi discepoli, cattivi esegeti,
di Gianfranco de Turris
Le interviste di Julius Evola 1964-1972
Indice dei nomi e dei testi anonimi
Nota del Curatore
Cavalcare la tigre (1961) è il libro più realista e più pessimista scritto
da Julius Evola (egli stesso userà parole quasi simili parlandone ne II cam-
mino del cinabro, 1963), anche se non per questo rassegnato, rinunciatario
o passivo. E anche il libro di Evola che è stato più malcompreso e male
interpretato rispetto ai molti altri da lui scritti, quello su cui vi sono stati
più equivoci fin dal suo primo apparire. L'aspetto del pessimismo - che
riguarda la genesi - verrà affrontato in questa Nota; il secondo, riguardante
più propriamente la sua cattiva interpretazione nonostante le messe in
guardia dell'autore, sarà esaminato nell'Appendice.
Il "pessimismo" di Cavalcare la tigre ed il suo invito ad "applicarsi al
problema puramente individuale" (come Evola afferma ne II cammino del
cinabro), è sembrato a molti, già all'epoca della sua iniziale pubblicazione,
e ancora oggi, in contraddizione con altre indicazioni fornite in precedenti
opere, soprattutto ne Gli uomini e le rovine (1953), sulle cui pagine si tro-
vano indicazioni per così dire "generali" dopo averne indicati i presupposti
"teorici". È vero il contrario, invece. I due saggi non sono in contrapposi-
zione, viceversa li si deve considerare complementari. Ricostruendone la
genesi, si può dimostrare che ciò era proprio nelle intenzioni dell'autore.
Entrambi hanno origine nelle idee espresse da Evola negli articoli che
iniziò a pubblicare su varie riviste a partire dal settembre 1949, quando era
ancora ricoverato in clinica a Bologna, specie quelli su Imperium (maggio,
giugno, luglio 1950), e che riorganizzò in un opuscolo, a cura di quest'ulti-
ma rivista, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Schieramenti e che
alla fine prese il titolo di Orientamenti (1950). Rientrato nella sua casa di
Roma nel marzo 1950, Evola vide radunarsi intorno a sé un gruppo di gio-
vani che, come ha scritto Fausto Gianfranceschi nel suo contributo alle
Testimonianze su Evola (Edizioni Mediterranee, 1973), lo sollecitarono ad
ampliare gli "undici punti" di Orientamenti in un testo più articolato e
profondo. II risultato fu il citato Gli uomini e le rovine che venne scritto o
completato nel 1952 e stampato l'anno dopo dalle Edizioni dell'Ascia. Tra
le opere annunciate come di prossima pubblicazione (anzi come "prime
pubblicazioni") sul suo frontespizio e su quello de La crisi del mondo
7
moderno di Guénon uscito lo stesso anno, c'era già Cavalcare la tigre.
Non solo: nella edizione 1953 de Gli uomini e le rovine Julius Evola effet-
tuava sin allora tre precisi rimandi ai capitoli 4 e 8 di Cavalcare la tigre
che quindi nel 1953 deve considerarsi di sicuro in parte scritto. Come si
può allora parlare di contrasto di fondo fra le due opere, se vennero di
certo pensate e almeno parzialmente redatte insieme all'inizio degli Anni
Cinquanta?
Evola non pare abbia mai affrontato la questione (forse la riteneva
inessenziale), ma alcune deduzioni logiche accompagnate a dati di fatto
permettono di dare una risposta abbastanza ragionevole.
Primo punto. I due libri vennero impostati e forse realizzati quasi
contemporaneamente perché nelle intenzioni dell'autore si rivolgevano a
due tipi di lettori, quelli che intendevano operare all'esterno, sul piano
politico, e quelli che volevano operare sul piano interiore, personale. Il
che non era altro che un tener conto della duplice "disposizione", della
duplice "personalità" che Evola riconosceva già in se stesso, come rivela
nelle pagine iniziali de II cammino del cinabro: "il naturale distacco
dall'umano", e cioè "l'impulso alla trascendenza" da un lato, la "disposi-
zione da kshatriya", e cioè rivolta all'azione, dall'altro. Ecco i due tipi
umani cui, nelle intenzioni di Evola, dovevano indirizzarsi i suoi due libri
fin dal 1953. Evidentemente quell'epoca vedeva intorno a sé dei giovani
che manifestavano entrambe le tendenze e senza privilegiare l'una o
l'altra, anche perché convivevano in lui stesso, pensò di scrivere delle
opere tra loro complementari e non in contrasto.
Sta a dimostrarlo quanto si legge sin dalla prima edizione 1961 di
Cavalcare la tigre, là dove si spiega che nell'attuale "mondo moderno",
quello uscito "dopo gli ultimi sconvolgimenti mondiali", si possono indivi-
duare due tipi di "uomini che sono per così dire in piedi fra le rovine e fra la
dissoluzione, i quali, più o meno consapevolmente, è a quell'altro mondo
che appartengono", cioè al mondo della Tradizione: da un lato c'è "una pic-
cola schiera (che) sembra disposta a battersi anche su posizioni perdute, e
quando essa non fletta, quando non scenda a compromessi per la seduzione
esercitata da tutto ciò che potrebbe condizionarne un qualche loro successo,
la sua testimonianza è valida". Per costoro - è logico dedurlo - è stato scrit-
to Gli uomini e le rovine. Da un altro lato ci sono coloro per i quali "si tratta
invece di isolarsi completamente, cosa che però richiede disposizioni inter-
ne e anche condizioni materiali privilegiate che ogni giorno si fanno sempre
più rare. Aggiungeremo i pochissimi che nel campo intellettuale possono
affermare i valori 'tradizionali', al di fuori di ogni scopo immediato, tanto
da svolgere un"azione di presenza' (...). Ciò non risolve però il problema
pratico personale, quando non si tratta di coloro cui è dato di isolarsi mate-
rialmente, ma di uomini che non possono o non vogliono tagliare i ponti
con la vita attuale, che perciò si trovano dinanzi al problema dell'atteggia-
mento da prendere nell'esistenza, già in ordine a quanto si riferisce alle rea-
zioni e alle relazioni umane più elementari". Per costoro, vale a dire per
8
coloro i quali non hanno la possibilità di "isolarsi completamente" (anche
da un punto di vista materiale, concreto), quotidianamente a contatto con il
"mondo moderno", ma non vogliono o non hanno la capacità di rivolgersi
all'"azione", è stato scritto Cavalcare la tigre.
Secondo punto. Tra il progetto e la compilazione forse parziale di
quest'opera trascorsero però otto o nove anni, dal 1952 al 1961. Un lungo
periodo in cui molte illusioni caddero: naturale, quindi, che, se rimasero le
intenzioni iniziali, si modificò - probabilmente in modo anche profondo -
il tono dello scritto. Da qui, il pessimismo esplicito e il disincanto che tra-
spaiono nel 1961. Scrive infatti Julius Evola due anni dopo, ne II cammino
del cinabro, riferendosi a quello che allora si presentava come il suo ultimo
libro: "In essenza, esso corrisponde al bilancio negativo che ho dovuto
trarre dalle mie esperienze e ad una visione realistica della situazione gene-
rale, cioè al convincimento che nulla può essere fatto per provocare una
modificazione di rilievo in questa situazione, per agire su processi che
ormai, dopo gli ultimi crolli, hanno un irrefrenato corso. In particolare,
l'incentivo a scrivere il libro mi è stato dato anche da varie persone che mi
avevano seguito nella fase 'tradizionale', che avevano pertanto riconosciu-
to il superiore diritto di un sistema dell'esistenza e della società che riflet-
tesse i valori della Tradizione quali li avevo messi in luce soprattutto in
Rivolta contro il mondo moderno, ma che si domandavano che cosa mai si
potesse fare in seno ad un mondo, ad una società e ad una cultura come
quelle ormai stabilizzatesi all'epoca attuale. Evidentemente, a costoro vi
era solo da indicare un diverso orientamento. Bisogna abbandonare ogni
fine costruttivo esteriore, reso irrealizzabile da un'epoca di dissoluzione
come la presente, bisogna applicarsi al problema puramente individuale
consistente essenzialmente nel far sì che 'ciò su cui io non posso nulla,
nulla non possa su di me' ".
Sarebbe importante sapere se le "varie persone" cui Evola si riferisce
lo abbiano sollecitato a scrivere Cavalcare la tigre prima o dopo il 1953,
cioè prima o dopo Gli uomini e le rovine e gli sviluppi che prese la politica
italiana in generale e quella della destra in modo specifico: dopo il con-
gresso di Milano del 1956, infatti, uscirà dal MSI la corrente di "Ordine
Nuovo", di cui facevano parte nomi che sempre a Evola avevano fatto rife-
rimento, troncandosi in tal modo ogni possibilità di influenzare dall'inter-
no, in senso tradizionale, il maggion partito della destra italiana, così come
Evola si era proposto sin dal suo ritorno in Italia, collaborando - come si è
ricordato - alle riviste specie giovanili di quell'area culturale a partire dal
1949 (// Nazionale, Rivolta ideale, La sfida, Meridiano d'Italia, Impe-
rium), scrivendo Orientamenti nel 1950 e così via.
Sono questi, probabilmente, "gli ultimi crolli", cioè quelli politici e
pratici, e da qui il "bilancio negativo". Molto esplicito su ciò fu Evola, sei
anni dopo Cavalcare la tigre, nella sua "nota dell'autore" alla seconda edi-
zione de Gli uomini e le rovine (Volpe, 1967): "Il presente libro fu scritto
non senza relazione con una determinata situazione italiana. Nel 1953,
quando uscì in prima edizione, sembrava che in Italia fossero presenti le
condizioni per dare inizio alla formazione di uno schieramento di Destra:
di Destra non nel senso politico, ma anche e anzitutto ideale e spirituale.
Così non avevo ritenuto inutile formulare i principi, i valori e le linee prin-
cipali di una dottrina dello Stato da servire per questo eventuale schiera-
mento, non nell'idea di una loro possibile assunzione e realizzazione, ma
essenzialmente nell'intento di indicare una direzione di marcia (...).
Purtroppo le possibilità che sembrava si delineassero non hanno avuto svi-
luppo alcuno e il processo di franamento politico e morale dell'Italia è
continuato".
Quindi abbandonare i fini "esteriori" e preoccuparsi di quelli "persona-
li". Un libro, come quelli di Nietzsche, "per tutti e per nessuno": "Il libro è
dedicato a chi non può o non vuole staccarsi dal mondo attuale, che è pron-
to ad affrontarlo e a viverci persino nelle forme più parossistiche senza però
cedere interiormente, mantenendovi la propria differenziata personalità",
così si chiarisce ancor meglio nel Cammino del cinabro. Una visione pessi-
mistica, come si è detto all'inizio, ma né passiva, né rinunciataria.
Questo - dunque - per il pessimismo. L'altro aspetto del saggio è
l'estremo, crudo realismo. Esso deriva dal fatto che l'autore, e i destinatari
della sua opera, adottano un criterio di valutazione e giudizio che si rifa
alla tedesca Neue Sachlichkeit, la Nuova Oggettività, vale a dire una visio-
ne chiara, distaccata e oggettiva dell'esistenza, la quale produce "una inca-
pacità positiva esistenziale a soggiacere ancora ai miti di qualsiasi genere
essi siano", in modo "da dar luogo a una forma del comportamento ade-
guata, nell'uomo libero, alle strutture oggettive del mondo contempora-
neo" e da adempiere "il compito di capovolgere nel positivo ciò che deriva
dall'esperienza del mondo più moderno". È, in pratica, l'applicazione alla
contemporaneità, delle teorie esposte in libri come La dottrina del risve-
glio, la cui nuova edizione apparirà nel 1965, cioè tra la prima edizione di
Cavalcare la tigre e la seconda de Gli uomini e le rovine.
Nell'età ultima, nel kali-yuga, quello che Evola chiama "uomo diffe-
renziato", cioè legato intimamente ad una dimensione trascendente e quin-
di alla Tradizione, sa che non ci si può fare alcuna illusione; allo stesso
tempo però non viene travolto dall'angoscia esistenziale e dalla frustrazio-
ne, compie il proprio dovere sino in fondo, fa quel che deve essere fatto,
proprio perché il suo sguardo interiore limpido e sgombro da residui e con-
dizionamenti gli fa vedere come stanno realmente le cose nel mondo. Non
è dunque un messaggio disperato quello che Evola consegna come suo
testamento spirituale. Tale infatti si può considerare il libro, tenendo conto
anche di quanto l'autore stesso scrisse, sempre ne II cammino del cinabro,
"fonte autentica" cui è indispensabile riferirsi: "Cavalcare la tigre, sotto
certi aspetti riflette la mia stessa via; le massime e gli orientamenti in esso
indicati sono anche quelli che, in genere, mi sono sforzato di seguire nella
mia esistenza (...). Con questo libro si chiude un ciclo, nel senso che in un
certo modo io sono tornato alle posizioni di partenza, a quelle verso le
10