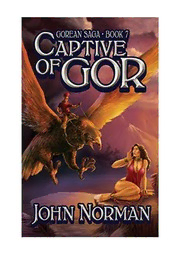Table Of ContentCapitolo 1
IL MARCHIO
Il resoconto che segue è stato scritto per ordine del mio Padrone, Bosk di Port Kar,
grande mercante e, credo, ex guerriero.
Il mio nome è Elinor Brinton. Ero stata ricca e indipendente. Ci sono molte cose che
non capisco. Ma lascio agli altri il compito di trovare un significato a quanto narrerò.
Mi risulta che la mia storia non sia né unica né tanto rara quanto potrebbe sembrare.
Secondo gli standard terrestri, ero reputata una vera bellezza. Eppure, in questo
mondo sono solo una ragazza da quindici pezzi d’oro, certamente più bella di molte
altre, ma ancora lontana dall’eccellenza che mozza il fiato e che posso solo invidiare.
Ero stata acquisita per le cucine della dimora di Bosk. Sapevo che i mercanti
percorrevano le rotte degli schiavi fra questo mondo e la Terra. Le donne, come molti
altri beni, vengono prese e portate nei mercati di questo strano mondo. Se sei molto
bella e desiderabile, devi temere: a quanto pare, loro possono fare ciò che vogliono.
Tuttavia, penso che ci sono destini peggiori che possono toccare una donna, rispetto
all’essere portata su questo mondo come premio per gli uomini.
Il mio Padrone mi ha detto di non descrivere questo mondo in modo troppo
dettagliato. Non capisco il perché, ma non lo farò. Mi ha detto di raccontare
soprattutto ciò che è accaduto a me. E ha sottolineato che deve trattarsi dei miei
pensieri ma, soprattutto, delle mie emozioni. Spero di riuscirci. Non mi piace farlo,
ma devo obbedire.
Mi basterà accennare alla mia esperienza e alla mia condizione.
Ho ricevuto un’educazione costosa ma non completa. Ho trascorso anni e anni di
solitudine in scuole e collegi, e infine ho frequentato uno dei collegi per donne
benestanti nella zona nord degli Stati Uniti.
Quegli anni ora mi sembrano vuoti e frivoli, e non ho incontrato difficoltà
nell’ottenere il diploma.
La mia intelligenza, a quanto mi risulta, è buona, ma i miei lavori erano sempre
valutati bene anche quando mi sembravano scarsi, come del resto accadeva anche alle
altre studentesse.
I nostri genitori erano ricchi e le donazioni a scuole e istituti universitari spesso
seguivano il conseguimento del titolo di studio.
Inoltre, non avevo mai frequentato uomini, anche se molti dei miei istruttori lo erano,
ed erano difficili da accontentare. Più che altro, erano loro che sembravano desiderosi
di accontentarmi.
Ero stata bocciata in una sola materia, Francese. Il mio istruttore in questo caso era
una donna. Il Decano degli studenti, come era solito fare in queste circostanze, aveva
rifiutato di accettare il voto. Mi fecero fare un breve esame con un altro istruttore e il
mio voto diventò una A. La donna diede le dimissioni in primavera. Mi dispiacque,
ma lei avrebbe dovuto saperlo.
Come ragazza ricca, avevo delle difficoltà a farmi degli amici. Ero molto popolare,
ma non ricordo nessuno con cui avrei voluto parlare. Preferivo trascorrere le mie
vacanze in Europa.
Potevo permettermi dei bei vestiti, e l’ho sempre fatto. I miei capelli erano sempre
ben tagliati e pettinati, anche se apparentemente potevano sembrare trascurati. Un
nastrino colorato, un accessorio appropriato, l’appropriata tonalità di un costoso
rossetto,la cucitura su una gonna, la qualità della pelle di una cintura d’importazione,
scarpe abbinate, per me tutto era importante.
Quando chiedevo la dilazione per un compito in ritardo, indossavo mocassini
sformati, blue jeans e maglietta, e un nastro nei capelli. Forse avrei dovuto anche
avere un po’ di inchiostro dei nastri per la macchina da scrivere sulle guance e sulle
dita, ma avevo solo bisogno di un po’ di tempo in più. E, naturalmente, non avevo
mai battuto a macchina. Di solito scrivevo a mano. Mi piaceva farlo. Mi piaceva di
più delle cose che potevo comprare.
Uno dei miei istruttori, dal quale avevo ottenuto una proroga nel pomeriggio, non mi
aveva riconosciuta quella stessa sera, quando si era seduto dietro di me ad un
concerto di musica da camera al Lincoln Center. Mi aveva guardata con aria
interrogativa, e durante l’intervallo era sembrato sul punto di dirmi qualcosa. Lo
avevo freddato con lo sguardo e lui aveva girato gli occhi altrove, con il viso rosso.
Indossavo un abito nero, capelli alzati sulla nuca, perle e guanti bianchi. Lui non
aveva più osato guardarmi per tutta la serata.
Non riesco a ricordare quand’è che sono stata notata. Potrebbe essere accaduto in una
strada di New York, su un marciapiede di Londra o in un caffè a Parigi. Potrebbe
anche essere accaduto durante i bagni di sole sulla Riviera. Ma poteva anche essere
successo nel campus dell’università. Dovunque. A mia insaputa, ero stata notata e
stavo per essere acquisita.
Ricca, bella ed elegante. Sapevo di essere migliore di tanta altra gente e non avevo
paura di mostrarlo, alla mia maniera, perché era vero. È interessante notare che molte
persone, anziché essere arrabbiati con me, qualunque siano i loro sentimenti privati,
sembravano impressionati e un po’ mi temevano. Mi accettavano per la mia
apparenza, che era considerevole. Volevano essermi simpatici. Mi divertivo con loro,
a volte mettevo il broncio, fingendo di essere offesa o dispiaciuta, poi sorridevo e
lasciavo che mi perdonassero. E loro sembravano grati, raggianti. Quanto li
disprezzavo! Mi annoiavano. Io ero ricca, fortunata e bellissima. Loro non erano
niente.
Mio padre aveva fatto la sua fortuna nel settore immobiliare a Chicago. Era
concentrato solo sui suoi affari, per quanto mi risultava. Non mi ricordo di una sola
volta in cui mi abbia dato un bacio. Non ricordo di averlo mai visto fare una carezza a
mia madre, né lei a lui, in mia presenza. Lei veniva da una ricchissima famiglia di
Chicago, con ampie proprietà sulla costa. Non credo che mio padre fosse interessato
ai soldi di mia madre, se non altro per il fatto che lui poteva farne molto di più di
qualsiasi altra persona. Era un uomo infelice.
Ricordo mia madre che ospitava nella nostra casa. Lo faceva spesso. Ricordo anche
che mio padre una volta mi disse che lei era il suo bene più prezioso. Era certamente
un complimento, a modo suo. Ricordo che era molto bella. Lei avvelenò un
barboncino che avevo tanti anni fa, perché aveva strappato una delle sue pantofole.
Avevo sette anni all’epoca e piansi disperatamente. Amavo molto quel cane.
Quando mi sono laureata, né mio padre né mia madre hanno partecipato alla
cerimonia. Fu la seconda volta in vita mia, a quel che mi è dato ricordare, che piansi.
Lui aveva un appuntamento d’affari e mia madre, a New York, aveva dato una cena
per alcuni suoi amici. Mi spedì un biglietto che accompagnava un costoso orologio,
che mi affrettai a regalare ad un’altra ragazza.
Quell’estate, mio padre appena quarantenne ebbe un attacco di cuore e morì. Da
quello che so, mia madre vive ancora a New York City, in una suite su Park Avenue.
Nella divisione ereditaria, mia madre ricevette la maggior parte dei beni, mentre a me
toccarono circa 750.000 dollari, prevalentemente in azioni e obbligazioni, una fortuna
che oscillava notevolmente a seconda del mercato azionario, ma sostanzialmente in
buona salute. E se anche il mio patrimonio fosse stato superiore ai tre quarti di
milione di dollari, non mi sarebbe interessato granchè.
Dopo la mia laurea, presi un attico a Park Avenue. Mia madre e io non ci vedevamo
più. Non avevo più interessi rilevanti come quando ero a scuola. Fumavo molto,
anche se lo odiavo. Bevevo anche abbastanza. Non ho mai preso droghe perché mi
sembra stupido.
Mio padre aveva avuto numerosi contatti di affari a New York, e mia madre ne aveva
fatto i suoi amici influenti. Feci una telefonata a mia madre poche settimane dopo la
mia laurea, pensando che poteva essere interessante farmi assumere come modella.
Avevo pensato che poteva esserci un certo glamour in questo, e che avrei potuto
incontrare persone interessanti e divertenti.
Pochi giorni dopo fui invitata da due agenzie per un’intervista, che mi aspettavo fosse
una mera formalità. C’erano indubbiamente molte ragazze bellissime che volevano
fare da modella. La bellezza, in sé stessa, in una popolazione che conta circa dieci
milioni di individui, non è certo difficile da trovare. Di conseguenza, in particolare
per le ragazze inesperte, si potrebbe supporre che debbano esserci altri criteri diversi
dal fascino e dalla bellezza, per determinare le probabilità di riuscita in un settore così
competitivo.
E fu così nel mio caso. Ritenevo, naturalmente, di poter avere successo a modo mio,
ma non ce ne fu bisogno.
Mi sono goduta al mia carriera da modella, anche se non era durata più di poche
settimane. Mi piaceva indossare gli abiti e li portavo splendidamente. Mi piaceva
mettermi in posa, anche se era faticoso. I fotografi e gli artisti sembravano tutti
intelligenti e spiritosi, anche se a volte avevano maniere brusche. Erano sempre molto
professionali. Uno di essi una volta mi chiamò puttana. Risi. I miei incarichi erano
frequenti.
Il mio incarico più remunerativo fu quando mi chiamarono per fare da modella per
una nuova linea di costumi da bagno, prodotti da una società molto nota, il cui nome
è comunque irrilevante ai fini di questo racconto.
Non lo accettai.
Un lunedi pomeriggio ricevetti l’incarico e dovevo dare una risposta allo studio il
mercoledì successivo. Non avevo chiamate per il martedi. La sera prima, avevo dato
un giorno di libertà alla mia cameriera di colore fino a mercoledì: volevo godermi la
mia casa, stare da sola a leggere e ascoltare musica.
Martedì mattina dormii fino a tarda ora.
Mi svegliò un raggio di sole attraverso le tende. Era un caldo giorno di ozio. Mi
stiracchiai. Era quasi mezzogiorno. Avevo dormito nuda, fra lenzuola di seta bianca.
Mi avvicinai al comodino e presi le sigarette e il posacenere. Era tutto normale, nella
stanza.
Un orso di peluche, un buffo koala, giaceva ai piedi del letto. I libri erano sulle loro
mensole. Il paralume era leggermente inclinato, come me lo ricordavo la sera prima.
La sveglia, che non avevo impostato, giaceva nel cassetto.
La sigaretta non aveva un buon gusto, ma avevo voglia di fumare. Mi sdraiai sulle
lenzuola e mi stiracchiai ancora, poi allungai le gambe fuori dal letto e infilai i piedi
nelle pantofole. Mi infilai una vestaglia di seta. Spensi la sigaretta nel posacenere e
andai in bagno a farmi la doccia.
Mi legai i capelli, mi sfilai la vestaglia e aprii la porta scorrevole della doccia,
entrandovi. Mi abbandonai subito all’abbraccio dell’acqua calda. Era un giorno caldo,
molto molto caldo. Restai qualche minuto con la testa piegata all’indietro e gli occhi
chiusi, lasciando che l’acqua calda mi scivolasse sul viso e sul corpo. Poi presi la
saponetta e iniziai ad insaponarmi.
Quando le mie dita toccarono la coscia sinistra per insaponarla, sobbalzai. Stavo
toccando qualcosa che la sera prima non c’era e che non avevo mai toccato prima. Mi
appoggiai al muro e allungai la gamba sinistra. All’improvviso, tutto divenne buio.
Non potevo più respirare. Ero terrorizzata. Non sentivo dolore ma di sicuro quello
non c’era la sera prima!
C’era un marchio sulla mia gamba. Sulla parte alta della coscia. Grande circa 5 o 6
sentimetri. Era una lettera in corsivo, anche carina, se vogliamo. Era fin troppo chiaro
che non poteva essere una semplice ferita. Era troppo perfetto, chiaro e profondo. Era
stato deliberatamente inciso nella mia coscia!
Annaspai per riprendere fiato e mi appoggiai con le spalle al muro per non cadere.
Con gesti rapidi e rigidi mi lavai il sapone di dosso e uscii dalla doccia. Lasciai il
bagno ancora tutta bagnata, e camminai scalza sul tappeto davanti allo specchio che
stava nell’angolo opposto della stanza. Respiravo a fatica e mi sembrava che la stanza
barcollasse intorno a me.
Sullo specchio, c’era un altro marchio, ma non me ne ero accorta prima. Era stato
disegnato con il mio rossetto. Era grosso circa una ventina di centimetri ma era
identico a quello sulla mia coscia, lo stesso carattere in corsivo.
Incredula, mi guardai allo specchio.
Mi toccai il marchio sulla coscia. Guardai di nuovo il marchio rosso disegnato sulla
superficie dello specchio. Non credevo ai miei occhi.
Non sapevo niente di queste cose ma non pensavo ci fosse stato uno sbaglio
nell’incidermi quel marchio sulla coscia.
Tutto ridivenne nero e svenni sul tappeto davanti allo specchio. Ero stata marchiata!
Capitolo 2
IL COLLARE
Non ricordo quanto sono rimasta svenuta sul tappeto dinanzi allo specchio. Forse sarà
stata circa un’ora, a giudicare dalla posizione del sole attraverso le tende. Mi sollevai
in ginocchio e mi guardai allo specchio. Urlai. Stavo impazzendo! Mi presi la testa
fra le mani e la scossi.
Infilai le dita nella fascia che avevo al collo, cercando di strapparla via. Sicuramente
mi era stata messa mentre giacevo senza coscienza!
Intorno al collo avevo una graziosa lucente fascia di metallo. Recuperai le mie forze
mentali e cercai di rimuoverla. Le mie dita brancolavano nel buio dietro la nuca. Non
riuscivo a trovare la chiusura. Lo girai attentamente intorno al collo, essendo
abbastanza stretto. Lo esaminai allo specchio.
Non c’erano fermagli o chiusure. Solo un piccolo lucchetto e un foro dove poteva
entrare una piccola chiave. Era stato bloccato intorno al mio collo! C’era
un’iscrizione sulla fascia metallica, ma niente che io potessi leggere. Non era una
lingua che conoscevo!
Ancora una volta la stanza si oscurò improvvisamente ai miei occhi e mi roteava
intorno, ma cercai di non perdere conoscenza. Qualcuno era penetrato nella mia
stanza da letto e mi aveva messo un collare. Poteva essere ancora qui.
A testa bassa e i capelli ricadenti sul tappeto, a quattro zampe, scuotevo il capo.
Strappai i peli del tappeto. Non volevo perdere conoscenza. Volevo mantenere i miei
sensi.
Mi guardai intorno. Il mio cuore fu ad un passo dall’infarto. La stanza era vuota.
Strisciai fino al telefono sul comodino vicino a letto. Mi alzai in piedi con molta
esitazione, per non fare nessun rumore. Il telefono non dava segni di vita. Il filo
pendeva strappato. Mi salirono le lacrime agli occhi.
C’era un altro telefono nel salotto, ma era dall’altro lato della porta. Avevo paura di
aprire la porta. Diedi uno sguardo al bagno. Anche quella stanza mi faceva paura.
Non sapevo cosa poteva esserci dentro.
Avevo un piccolo revolver. Non avevo mai sparato. Mi era tornato in mente solo ora.
Saltellando, feci un balzo fino al triplo armadio all’altro capo della stanza.
Infilai le mani sotto le sciarpe e gli slips nel cassetto, e toccai l’impugnatura. Mi
sfuggì un grido di gioia. Presi l’oggetto. Guardai l’arma, incredula. Non sapevo se
piangere o lamentarmi. Semplicemente non capivo proprio cosa fosse successo.
L’arma era diventata un grumo informe di metallo. Quasi fosse stato un pezzo fuso di
cioccolato. Lo gettai sulle lenzuola e restai inebetita, guardandomi allo specchio. Ero
inerme. Ma il mio terrore non era semplice terrore: sentivo che era successo qualcosa
di strano, che aveva cambiato i termini del mondo che conoscevo. Ero spaventata.
Corsi fino alla finestra della camera da letto e spalancai le tende. Guardai la città.
Lo smog la ricopriva come al solito, offuscando la luce del sole. Potevo vedere
centinaia di finestre, alcune con i riflessi del sole, immerse in una luce dorata
surreale. Potevo vedere i grandi muri di mattoni e i palazzi di acciaio, cemento e
vetro. Era il mio mondo.
Rimasi immobile per qualche istante, col sole che mi abbagliava attraverso i vetri.
Era il mio mondo!
Ero nuda al di qua del vetro, con il mio collare di metallo che non riuscivo a togliere.
E avevo un marchio sulla coscia.
"No!" gridai a me stessa. "No!"
Volta le spalle alla finestra e, furtivamente, mi avvicinai alla porta del salotto, che era
socchiusa. Feci appello a tutto il mio coraggio ed aprii quella porta: quasi svenni per
il sollievo. La stanza era vuota e tutto era come lo avevo lasciato la sera prima.
Corsi in cucina, dato che potevo vederla dal salotto. Aprii un cassetto e presi un
coltello da macellaio. Mi voltai di scatto, schiena al mobiletto, brandendo il coltello,
ma non c’era nessuno.
Impugnando il coltello, mi sentivo un po’ più sicura.
Tornai nel salotto, dov’era il telefono sul tavolo. Imprecai nel vedere il filo tagliato.
Esaminai l’attico. Le porte erano tutte chiuse. La casa era vuota, e anche il patio e la
terrazza.
Il cuore mi batteva all’impazzata. Ma ero su di giri. Corsi al guardaroba per vestirmi,
lasciare la casa e andare alla polizia.
Avevo appena raggiunto l’armadio che sentii un pesante colpo alla porta. Mi girai,
stringendo il coltello. La bussata fu ripetuta, più insistente..
"Apra la porta" ordinò una voce. "Polizia!"
Mi sentii sollevata. Corsi verso la porta, tenendo il coltello. Alla porta mi fermai,
stringendo il coltello, terrificata. Non avevo chiamato la polizia!
Nell’attico non c’era nessuno che mi avesse sentita gridare. Non avevo sentito nessun
suono quando avevo preso il telefono, e infatti il cavo era distrutto. Volevo solo
fuggire.
Chiunque ci fosse dall’altra parte delal porta, di certo non poteva essere la polizia.
Bussarono ancora e ancora. Mi girava la testa.
La bussata diventava sempre più forte.
"Apra la porta!" sentivo. "Apra la porta. Polizia!"
Cercai di mantenere la calma.
"Un attimo" risposi con tutta la calma di cui ero capace in quel momento. "Apro la
porta fra un attimo. Mi sto vestendo".
I colpi alla porta cessarono.
"Va bene" disse la voce. "Ma faccia in fretta"
"Si" risposi dolcemente. "Ci vuole solo un attimo di pazienza!"
Corsi in camera da letto e mi guardai intorno. Presi alcune lenzuola dall’armadio e
febbrilmente li annodai insieme. Corsi sulla terrazza. Avevo la nausea solo a guardare
oltre la ringhiera. Ma circa 10 metri sotto di me c’era un’altra terrazza piccola, una
delle centinaia che sporgevano su questo lato del palazzo.
Era dell’appartamento sotto il mio. Con il sole e il vento che mi pungevano gli occhi,
e molecole di polvere e cenere che mi cadevano addosso, annodai un capo della corda
di fortuna alla ringhiera di ferro che sormontava il muro intorno alla terrazza. L’altro
capo della corda lo lasciai cadere fino alla piccola terrazza di sotto. Ero terrorizzata
per quello che non avrei mai avuto il coraggio di fare, in condizioni normali.
Ricominciarono a bussare alla porta. Si avvertiva l’impazienza nei forti colpi.
Avevo realizzato che non potevo portare il coltello con me, perché mi occorrevano
entrambe le mani per scendere con le lenzuola di seta.
Forse potevo tenerlo fra i denti, ma ero troppo terrorizzata e non pensavo di poterlo
fare. Ero ancora in camera da letto quando sentii la porta andare in pezzi, fuori dai
cardini e dalla serratura. nascosi il coltello sotto il cuscino e corsi nel patio. Senza
guardare in basso, terrorizzata, afferrai la corda di lenzuola e -senza quasi respirare-
cominciai a mano a mano a scendere.
Ero sparita sotto il bordo della terrazza quando sentii la porta scardinata che cadeva a
terra e degli uomini che entravano nell'appartamento. Più veloce che potei, stavo per
raggiungere la terrazza di sotto. Ancora pochi metri e sarei stata salva. Avrei potuto
attirare l'attenzione delle persone che vi abitavano, magari rompendo uno dei vetri.
Sopra di me, nel mio appartamento, sentivo grida rabbiose.
Sentivo anche i rumori della strada, molto sotto di me. Non osavo guardare in basso.
Finalmente i miei piedi toccarono il pavimento dela terrazza di sotto. Ero in salvo!
Qualcosa di morbido e bianco mi scivolò sopra la testa, impedendomi la vista.
Qualcos'altro mi fu infilato in bocca. Un altro pezzo di stoffa mi coprì la testa e fu
annodato saldamente dietro la mia nuca.
Provai a gridare ma non ci riuscii.
"L'abbiamo presa!" disse una voce.