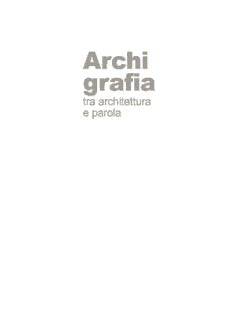Table Of ContentArchi
grafia
tra architettura
e parola
Università degli Studi
di Trieste
Facoltà di Architettura
Dottorato di ricerca
in composizione
architettonica e urbana
icar14
XXII ciclo
marzo2007-aprile2010
Archigrafia
tra architettura
e parola
dottorando
Thomas Bisiani
relatore
chi.mo prof. Giovanni Fraziano
coordinatoredelcollegiodeidocenti
chi.mo prof. Giovanni Fraziano
indice
7 Introduzione 75 L’alfabeto dell’architetto.
Il Novecento e le nuove
costruzioni della parola
11 La civiltà della scrittura
visibile.
21 Questo ucciderà quello.
85 Nel labirinto.
Comunicazione e libri
Tre programmi
di pietra.
di esposizione testuale
29 Scrittura, decoro
per i trasporti metropolitani.
e ornamento.
99 Da New Heaven
Le scritture urbane
a Peepland, passando
esposte e il paesaggio
per Sin City.
testuale.
109 Nuove scritture.
37 Herman Zapf.
Petite cronique
Analfabeti della vista.
del muro animato.
40 L’elisione in quattro casi
tra arte comunicazione
visiva e spazio pubblico. 119 Archigrafia atlante.
1991-2009, tra architettura
51 Archigrafia.
e parola.
Scrittura, segno
e superficie. 172 Alcune considerazioni
sull’atlante.
57 L’architettura tipografica
e il manuale pratico.
Archigrafia, futurismo
178 Conclusioni
e razionalismo.
62 Fortunato Depero.
180 Bibliografia
Architettura pubblicitaria.
66 Fortunato Depero.
Padiglione del libro.
dalle iscrizioni monumentali
“
di un edificio pubblico
a quella volumetrica
o dipinta per un negozio,
dal monogramma ricamato
di un fazzoletto a quello inciso
o riportato di un oggetto
personale, si prospettano
innumerevoli applicazioni
che, a tutt’oggi, sono risolte
nell’ ignoranza completa,
con forme o meglio deformazioni,
che sembrano fantasie e sono
invece arbitrio o ignoranza.
”
Adalberto Libera
Manuale pratico per il disegno delle lettere,
Ente Nazionale per l’Artigianato
e le Piccole Industrie, Milano 1938, cit. p. 5.
introduzione
Nel 1938 Raffaello Bertieri pubblica il Manuale pratico per
il disegno delle lettere, il Manuale è curato da Adalberto
Libera che nel testo di accompagnamento rileva la condi-
zione di “arbitrio o ignoranza” che caratterizza anche l’atto
di progettare iscrizioni integrate alle opere di architettura.
Osservando il paesaggio urbano contemporaneo la citazio-
ne di Libera appare pertinente e di grande attualità.
finalità della ricerca
Sulla base di questa premessa, il presente studio indaga il
rapporto originario tra architettura e parola partendo da
una riflessione sulla scrittura archigrafica, ricollocata nel
paesaggio della comunicazione contemporanea.
In questo scenario eterogeneo e cacofonico, dominato dal-
la sistematica sovrapposizione di segni, linguaggi e signifi-
cati, l’archigrafia grazie alle sue caratteristiche strutturali di
concretezza e permanenza viene riscoperta prima, e verifi-
cata poi, ricomponendo a posteriori una geografia di con-
tributi sia scritti che costruiti.
L’ipotesi da dimostrare è che in un ambito di progetto
dichiaratamente ambiguo, e per questo di grande interes-
se, a metà strada tra il mestiere dell’architetto e la pratica
del progettista visivo, dove gli spunti teorici e i contributi
7
metodologici risultano sporadici od occasionali, esistono
esempi rilevanti e significativi, che non hanno carattere
incidentale ma al contrario testimoniano consapevolezza e
volontà progettuale.
L’obbiettivo ultimo è di dichiarare l’esistenza di una pratica
progettuale antica quanto l’architettura stessa, che solo in
una apparente generalità di applicazioni rimane imprigio-
nata nelle specificità disciplinari tra le due dimensioni della
parola scritta e le tre dimensioni dell’oggetto architettonico.
Così come enunciato il tema tuttavia può apparire di detta-
glio, forse troppo specifico e specialistico, in realtà Joseph
Rykwert in L’architettura e le altre arti ha chiarito che:
“iscrizioni e incisioni erano e rimangono elementi sintoma-
tici del nostro rapporto con l’architettura – e, più in genera-
le, del rapporto fra architettura e società”.
Di riflesso quindi il fine è quello di riallaciarsi alla più gene-
rale questione del senso, del rapporto che le opere di
architettura innescano con la società e con l’ambiente
urbano, e della capacità di stabilire un dialogo e di com-
prenderne o dedurne il significato; confermando così lo
statuto artistico della pratica architettonica.
struttura dei contenuti
Il percorso di ricerca è diviso in due parti: l’indagine si artico-
la a partire dalle sperimentazioni delle avanguardie artistiche
del ‘900 per comporre uno scenario teorico-critico che, stabi-
lendo una possibile distinzione tra architettura e design, attri-
buisce all’archigrafia, nel percorso che porta dal moderno al
contemporaneo, una dimensione progettuale autonoma.
88
L’articolazione di questa prima parte verifica i contributi
disciplinari e le posizioni teoriche raccolte confrontandole
con l’approfondimento di alcuni casi di studio pertinenti.
La sequenza dei capitoli quindi non vuole ricostruire una
storia dell’archigrafia, ma piuttosto individua una serie di
temi che in alcuni casi si intrecciano, si sovrappongono tra
loro o si sviluppano parallelamente rispetto ad un percorso
cronologico.
La seconda parte dello studio ricompone un atlante che
raccoglie le esperienze significative in questo campo, indi-
viduando come area di indagine un corpus di progetti
esemplari realizzati negli ultimi vent’anni.
Questa raccolta testimonia de facto l’esistenza di un ambi-
to progettuale definito e circoscritto, di vivace sperimenta-
zione e di ampie applicazioni; un ventaglio allargato sia
anagrafico che geografico di autori ed opere.
Il paradigma teorico di riferimento è la distinzione e il rico-
noscimento di diverse forme di scrittura, all’articolazione
originaria tra archigrafia e calligrafia si aggiungono le scrit-
ture tipografiche prima e le nuove scritture poi.
Sulla base di questa ossatura, che nel rapporto mezzo di
tracciamento-supporto individua l’origine delle diverse tecni-
che di scrittura, è possibile per traslato riconoscere diverse
forme di scrittura, con significati e valori tra loro alternativi.
Nel passaggio dalla ragione fisica delle scritture alla loro
dimensione concettuale è quindi possibile individuare ed
organizzare i contributi progettuali raccolti, spiegarne il
senso e riconoscere rapporti e commistioni.
99
nonostante l’invasione
“
delle immagini la nostra
è più che mai una civiltà
della scrittura. In genere,
poi, sembra sempre
più difficile concepire
un sistema di immagini
o di oggetti i cui significati
possono esistere fuori
dal linguaggio.
”
Roland Barthes
Elementi di semiologia,
Einaudi, Torino, 1966, cit. p.14.
Description:che ne fa linguaggio, il segno visivo infatti non è mai isola- .. 5 cfr. Alfred Kallir, Segno e disegno. Psicogenesi dell'alfabeto, Spirali, Milano. 1994.