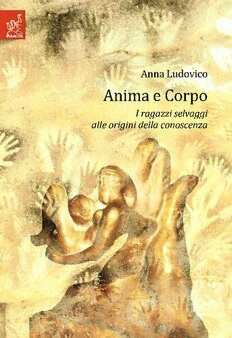Table Of ContentAnna Ludovico
Anima e Corpo
I ragazzi selvaggi
alle origini della conoscenza
ARACNE
INDICE
Capitolo Primo
Uno sfondo storico per i "ragazzi selvaggi"
Eredità e ambiente: esseri umani sì nasce e si diventa, 1 - Le concezioni di
Linneo e di Condillac, 10 - Rousseau e "l'uomo di natura", 14 - L'illu-
minismo di Lamettrie e di hard, 16 - Natura ed Educazione: due sistemi a
confronto, 18-7? libro di Singh e Zingg per il problema del rapporto
mente/corpo, 21 -La comparsa del linguaggio, 26.
Capitolo Secondo
Fanciulli allevati da animali 33
Bambini-lupo, 33 - Bambini-orso, bambino-capra, bambino-pecora, bambi-
no-vitello, bambina—maiale, bambino-leopardo, bambino-gazzella, 49 - Con-
clusioni, 59
Capitolo Terzo
Fanciulli sopravvissuti per autosostentamento: Tomko e gli altri 61
Capitolo Quarto
Victor dell'Aveyron 75
Capitolo Quinto
Fanciulli allevati in condizioni di totale isolamento:
da Kaspar Hauser a Genie 91
Capitolo Sesto
Gli esperimenti con gli scimpanzè 113
Capitolo Settimo
Venticinque anni dopo 131
Baby Hospital, bambina-scimmia, 131
6 Indice
Capitolo Ottavo
E la storia continua 145
Ramu, bambino—lupo indiano, 145 - Roberto, cresciuto nella selva tropicale,
146 - Horst, bambino-cane, 147 -Altri due casi di bambini-cane, 152
Capitolo Nono
Che fine ha fatto Genie? 155
Capitolo Decimo
Una controprova 165
Kanzi, "primate faber"?, 173
Capitolo Undicesimo
La natura del pensiero 179
Schede riassuntive di 47 casi di ragazzi selvaggi 197
Album 213
Bibliografia 231
Capitolo Primo
UNO SFONDO STORICO
PER I “RAGAZZI SELVAGGI”
Eredità e ambiente: esseri umani si nasce e si diventa
Troppo spesso si dimentica che un fattore veramente determinante per
l’educazione di un essere umano è costituito dalla comunicazione verbale
(orale prima e scritta poi), probabilmente perché la si ritiene quantomai
naturale e priva, quindi, di implicazioni che possano mettere in difficoltà
o addirittura traumatizzare il bambino. E generalmente, infatti, tutti i
bambini imparano a parlare, a leggere e a scrivere senza eccessivi
imbarazzi; senza — per meglio dire — che tali operazioni risultino, ge-
neralmente, agli occhi dell’adulto, genitore o insegnante che sia, più
difficoltose di operazioni quali il mangiare e il camminare.
È mia intenzione, invece, dimostrare che l’apprendimento di una
lingua e di un comportamento emotivo adeguato da parte di un bam-
bino siano il prodotto di una lunga serie di operazioni mentali, che, a
loro volta, sono rese possibili unicamente da una socializzazione svi-
luppata in un ambiente tipicamente umano. Intendo, cioè, far vedere,
attraverso l’esame dei cosiddetti “ragazzi selvaggi”, come sia difficile
“imparare” a diventare un essere umano, poiché la natura dell’uomo è
fortemente determinata dalle circostanze sociali e storiche nelle quali
si vive. E direi che il prodotto più vistoso della nostra socialità è
costituito dalla comunicazione verbale, in special modo da quella
orale1. Ritengo, infatti, che la lingua sia un risultato fenotipico, cioè
determinato dalle condizioni socio–ambientali, che deve al genotipo,
cioè alle condizioni del codice genetico, della specie umana solo la
base delle possibilità anatomo–fisiologiche.
1 Con comunicazione verbale s’intende la comunicazione orale e quella scritta insieme;
per chiarezza e brevità espositiva chiamerò lingua la comunicazione orale e scrittura la
comunicazione scritta.
7
8 Capitolo Primo
Per chiarire e comprendere a fondo la differenza nella interdipen-
denza tra genotipo e fenotipo è opportuno riportarne una definizione
tecnico–scientifica.
Genotipo: Costituzione ereditaria degli organismi, cioè l’insieme dei fattori
genetici che essi ricevono quando iniziano la loro esistenza a seguito del-
l’unione del gamete femminile e del gamete maschile dei due genitori. Il
termine può usarsi altresì per riferirsi a singoli fattori ereditari e applicarsi
anche quando, per varie ragioni, il genotipo non è espresso. […] Già G.
Mendel aveva sottolineato il ruolo di certe condizioni per riconoscere l’im-
portanza dei fattori genotipici e quindi, di fatto, per eseguire le prime vere
analisi del genotipo stesso. In genere, affinché si possa riscontrare una
differenza genotipica fra due organismi, è necessario che essi vengano
allevati e mantenuti in condizioni il più possibile simili, a meno che il diverso
genotipo che li contraddistingue non determini caratteri (di solito di natura
esclusivamente qualitativa) che li rendano diversi sotto le più svariate
condizioni ambientali (ad esempio i gruppi sanguigni della specie umana).
Comunque una volta che in condizioni uniformi due organismi presentino
sistematicamente delle differenze e tali differenze essi trasmettano alla
propria progenie, queste si possono ragionevolmente attribuire alle loro di-
verse costituzioni genotipiche2.
Fenotipo: Termine proposto da W. Johansen (1911) per indicare l’aspetto (in-
teso in senso molto lato e specificamente rispetto a un carattere o compor-
tamento) di un organismo vivente. Il fenotipo è il risultato di due fattori: la
costituzione intrinseca individuale (genotipo, sancito dall’unione di particolari
elemerti forniti dai genitori, gameti) e l’insieme delle condizioni estrinseche o
ambientali che agiscono sull’organismo nel corso della sua vita, giacché soli-
tamente un organismo comincia la sua esistenza come unità unicellulare a
seguito della fecondazione, si sviluppa in un embrione, s’accresce, diventa
adulto, pur conservando praticamente il genotipo originario. A una identica
costituzione le circostanze esterne possono imprimere gli aspetti più svariati: e
diremo allora che da uno stesso genotipo si possono avere più fenotipi.
D’altra parte si può arrivare a un medesimo fenotipo partendo da genotipi
diversi. In alcuni casi è più facile ottenere il primo risultato, in altri il
secondo. È istruttivo il caso dei gemelli identici (quelli non tali sono eviden-
temente solo fratelli, concepiti contemporaneamente, come lo prova il fatto
che circa il 50% di essi sono di sesso diverso). Evidentemente tali gemelli
hanno uguale genotipo: ebbene, se per qualche ragione vengono separati in
tenera età e vanno incontro a circostanze molto differenti, potranno diffe-
2Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Mondadori, Milano 1963, vol. V, p. 508.
Uno sfondo storico per i “ragazzi selvaggi” 9
renziarsi, cioè mostreranno fenotipi differenti. Esistono varietà e quindi geno-
tipi di primule cinesi che presentano fenotipo notevolmente differente a
seconda della temperatura alla quale vengono allevate: se sopra i 20°C danno
fiori bianchi, se sotto fiori rossi. […] In definitiva quindi quello che si eredita
con un genotipo non è un determinato carattere, ma una certa capacità di
reagire a determinate condizioni ambientali. Ciò pone, e nello stesso tempo
supera, la vecchia questione se per lo sviluppo dei caratteri e l’ottenimento
quindi di un certo fenotipo abbia maggiore importanza il genotipo o l’am-
biente. In realtà si può dire che quasi tutti i caratteri sono determinati sia dal
genotipo sia dall’ambiente, ma il contributo dell’uno o dell’altro può variare
enormemente da caso a caso. Per esempio le caratteristiche che distinguono
gli esseri umani nei vari gruppi sanguigni sono praticamente quasi soltanto di
origine genotipica; il colorito della cute e il colore dei capelli sono principal-
mente dovuti al genotipo, ma vi contribuisce anche l’ambiente; lo sviluppo
dell’intelligenza è in parte sotto controllo genotipico e in parte in rapporto
alle condizioni ambientali; si apprende una lingua verosimilmente soltanto in
rapporto all’ambiente in cui si cresce3.
Sarà mia cura esplicitare questo “verosimilmente” nel corso del-
l’indagine gnoseologica qui proposta.
Comunque sin d’ora possiamo affermare che se l’apprendimento di
una lingua rientra in toto nei fenomeni fenotipici, ciò significa che,
qualora l’ambiente non fornisca la possibilità d’imparare una lingua,
essa mancherà completamente all’organismo vissuto in tale condi-
zione, anche nel caso in cui l’organismo sia quello dell’essere genoti-
picamente umano. È infatti ciò che accade e che possiamo verificare
nei “ragazzi selvaggi”, in quegli esseri umani, cioè, che, abbandonati a
loro stessi in tenera età, sono riusciti a sopravvivere o per essere stati
allevati da animali o fidando solo nelle proprie risorse. Faccio questa
distinzione binaria tra la presenza o meno dell’allevamento da parte di
animali non solo come ovvia constatazione di fatto, ma soprattutto
come premessa iniziale indispensabile a quanto dirò in seguito. Ri-
tengo, cioé, che l’animale–uomo vissuto in una società purchessia
abbia maggiori difficoltà a inserirsi in una società diversa dalla
precedente di quante non ne abbia l’animale-uomo vissuto in isola-
mento, in quanto il primo è — in certo qual modo — intralciato da un
3Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, op. cit., vol. IV, pp. 796–797.
10 Capitolo Primo
imprinting4 già socializzato. Prima di esporre in dettaglio i casi di
questi ragazzi selvaggi desidero fornire una sorta di panorama storico
degli autori — a mio avviso più significativi — che si sono occupati,
per varie ragioni, di tali casi, in modo da poterne avere una prospettiva
quanto più allargata possibile.
Le concezioni di Linneo e di Condillac
La suddivisione del regno animale fatta da Linneo contempla sei
classi: (1) mammiferi, (2) uccelli, (3) anfibi, (4) pesci, (5) insetti, (6)
vermi. I mammiferi vengono definiti pelosi, che stanno sul terreno,
che camminano, che emettono suoni significativi. Una seconda suddi-
visione è costituita da sette ordini5, che a loro volta si ripartiscono nei
generi e nelle specie. Così alla classe dei mammiferi appartiene l’or-
dine dei Primati, i cui generi sono: uomo, scimmia, lemure, pipistrello.
L’uomo è definito con stazione eretta, e al genere “uomo” Linneo dà
l’attributo di sapiens, definendolo diurno e vario per abitudini cultu-
rali e località.
Al genere Homo sapiens appartiene la specie ferus, che viene
definita quadrupede, muta, irsuta. Come esemplificazioni dell’Homo
sapiens ferus, Linneo riporta le seguenti:
1. Juvenis ursinus Lithuanus. 1661.
2. Juvenis lupinus Hassiacus. 15446.
3. Juvenis ovinus Hibernus7.
4. Juvenis bovinus Bambergensis8.
5. Juvenis Hannoveranus. 1724.
4 Con il termine imprinting la scienza etologica intende uno speciale tipo di appren-
dimento, che avviene in un periodo precoce e particolarmente sensibile dello svilluppo del-
l’animale. Tale apprendimento non può verificarsi in un periodo diverso e, una volta acqui-
sito, risulta irreversibile.
5 I sette ordini sono: I. Primates, II. Bruta, III. Ferae, IV. Glires, V. Pecora, VI. Belluae,
VII. Cete.
6 Probabilmente si tratta di un refuso per 1344.
7 Come fonte Linneo cita il 9° cap. del IV tomo delle Observationes medicae del medico
olandese Nicolas Tulp (1593-1674).
8 La fonte citata è Philippe Camerarius.
Uno sfondo storico per i “ragazzi selvaggi” 11
6. Pueri Pyrenaici. 1719.
7. Puella Transisalana. 1717.
8. Puella Campanica. 1731.
9. Johannes Leodicensis Boerhavii9.
Mi è parso importante cominciare con Linneo questo breve excursus
storico, poiché Linneo è ritenuto il primo organizzatore scientifico del
mondo animale, e la sua classificazione è, diciamo, di tipo morfologico,
in quanto è basata sulle diversità delle costituzioni biofisiche degli ani-
mali. Infatti, in base a tali diversità, Linneo sotto la voce Homo sapiens
raggruppa le specie Ferus10, Americanus, Europaeus, Asiaticus, Afer,
Monstruosus: con questa ultima denominazione vengono classificati
quei tipi che mostrano delle “anomalie” rispetto alla norma per la
biofisica umana, anomalie che variano a seconda della località e delle
usanze; i tipi sono enumerati in questo modo: Alpini, Patagonici,
Monorchides, Imberbes, Macrocephali, Plagiocephali, dove gli Alpini
vengono definiti molto piccoli, agili, timidi; i Patagonici sono grandi
oltre misura; i Monorchides assai poco fertili: gli Ottentotti; degli
Imberbes fanno parte parecchi popoli dell’America; i Macrocephali
hanno il cranio conico: i Cinesi; i Plagiocephali hanno la parte anteriore
del cranio schiacciata: i Canadesi.
Voglio, cioè, evidenziare il fatto che nella classificazione di Linneo i
cosiddetti “ragazzi selvaggi” (gli Homines feri) sono considerati una
vera e propria specie all’interno del genere umano, in quanto le diffe-
renze “morfologiche” che tali esseri presentano vengono trattate alla
stessa stregua di quelle che distinguono un Americano da un Europeo o
da un Asiatico. In definitiva, dunque, Linneo considera che le caratte-
ristiche fondamentali del genere “uomo” appartengano anche, per
esempio, allo Juvenis lupinus Hassiacus; il che significa che anche per
questo Juvenis sono valide le descrizioni proprie della classe dei Mam-
miferi, dell’ordine dei Primati e del genere Uomo. Eppure abbiamo
visto come una delle caratteristiche fondamentali dell’Uomo sia la sta-
zione eretta, ciò che non ha — come vedremo in seguito — il fanciullo
9 Le fonti sono le opere di medicina dell’olandese Hermann Boerhaave (1668-1738).
10 Linneo usa l’aggettivo Ferus nel senso etimologico di “selvatico” in contrapposizione a
“domestico”, “civilizzato”, da non confondere con il sostantivo Ferae del III ordine dei
Mammiferi, che ha la specifica significazione di ‘fiere’.