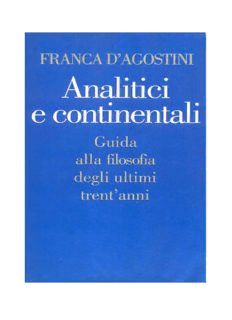Table Of Contentpre oe
e continental
ANALITICI E
CONTINENTALI
Una guida alla filosofia contemporanea
dagli anni Sessanta a oggi: i tempi del
dibattito filosofico attuale, gli autori, le
principali scuole e correnti. Una messa
a punto generale, che tiene conto
tanto deila filosofia europea
(“continentale”) quanto di quella
angloamericano (“analitica”): due
tradizioni di pensiero i cui esponenti,
come osserva Karl Otto Apel negli
anni Seitanta, “raramente hanno preso
nota gli uni degli altri” e, se hanno
fatto, 6 stato soprattutto per
delegittimarsi a vicenda, per accusarsi
reciprocamente di non essere “veri”
filosofi. Nella prima parte del libro si
propone un quadro tematico del
pensiero contemporaneo: dal
problema deila “fine della filosofia” alle
varie ragioni e forme di relativismo;
dalla questione del! soggetto al
problema della metafisica; dalla svolta
linguistica alla svolta cognitiva. Nella
seconda parte vengono prese in
esame le correnti che hanno
determinato il dibattito degli ultimi
trent’anni: Ja filosofia anaiitica,
lermeneutica, il poststrutturalismo, il
neostrutturalismo e il postmodernismo,
il razionalismo critico, l'epistemologia
postempiristica, la teoria della
complessita, la teoria critica
francofortese e habermasiana.
Conclude i! volume una bibliografia
ragionata su autori e correnti del
pensiero contemporaneo.
Franca D’ Agostini
Analitici e continentali
Guida alla filosofia
degli ultimi trent’ anni
Prefazione di Gianni Vattimo
© 1997 Raffaello Cortina Editore
Edizione CDE spa - Milano
su licenza Raffaello Cortina Editore
PREFAZIONE
Gianni Vattimo
Gli schemi, apparentemente neutrali e di comodo, che si adot-
tano per presentare in modo ordinato la storia della filosofia nei
suoi vari periodi, non sono mai davvero neutrali e puramente de-
scrittivi; hanno sempre, come si sa, anche uno sfondo teorico, che
fa della storiografia filosofica, pit ancora di qualunque altro gene-
re di storiografia, una scrittura carica di teoria, caratterizzata pit o
meno esplicitamente e consapevolmente da precise prese di posi-
zione. Se un tale impegno teorico della descrizione storiografica ri-
sulta poco marcato nelle storie della filosofia del passato meno vi-
cino, é solo perché in questo caso gli schemi storiografici sono or-
mai canonizzati, e hanno assunto una ovwvieta che li rende quasi in-
visibili. Quando si tratta invece di periodi pid vicini a noi, la dove
ancora non si sono stabiliti degli ordinamenti canonici, il coinvol-
gimento teorico risulta pit evidente; anche pit discutibile ma, in-
sieme, pitt ricco di stimoli e di indicazioni di sviluppo. E questo il
caso dell’ipotesi di lavoro adottata da Franca D’ Agostini nella pre-
sentazione della filosofia degli ultimi trent’ anni in base alla dicoto-
mia tra “analitici” e “continentali”. Che non é una formulazione
radicalmente nuova, perché si fonda su una contrapposizione con-
cettuale largamente presente nel dibattito contemporaneo (anche
se forse non é stata ancora adottata come base per una storia del
pensiero degli ultimi decenni); ma rappresenta un approccio cari-
co di implicazioni teoriche meritevoli di un’attenzione che va mol-
to al di la dell’interesse puramente informativo.
Intanto, la “semplificazione” del quadro che si opera con la de-
cisione di assumere come base questa grande dicotomia non pud
evitare di apparire anche come l’indicazione di una specie di pro-
blema centrale e decisivo per il pensiero contemporaneo. In molti
sensi, cioé, la separazione o l’opposizione tra queste due grandi li-
XI
PREFAZIONE
nee e stili di pensiero é forse la questione in cui si riassume il pro-
blema caratteristico a cui si trova di fronte la filosofia di oggi. Por-
re la cosa in questi termini pud sembrare una decisione arbitraria,
ma é anche, secondo noi, il punto di partenza per una lettura che
solo in quanto é orientata da un interesse non panoramico pud
affrontare il materiale del libro — le teorie, le vicende delle varie
scuole e dei singoli pensatori — con l’atteggiamento giusto, adegua-
to alla “cosa stessa”.
Insomma, lo schema entro cui l’autrice colloca il lavoro filosofi-
co degli ultimi tre decenni puo sia venire assunto come un puro
principio di organizzazione esteriore del materiale, che si rivela co-
munque utile per costruire un quadro non troppo frammentario e
sufficientemente chiaro e informativo; sia, in un senso pit: impe-
gnativo, pud venir preso come punto di partenza per una discus-
sione dei risultati, dei problemi aperti, del “senso” complessivo da
attribuire alla ricerca e al dibattito filosofico con cui ci mette in
contatto.
A mano a mano che si procede nella lettura del libro, ci si rende
conto che l’utilita informativa e “organizzatrice” dello schema é
segno della sua fecondita e appropriatezza teorica; che, cioé, il si-
gnificato del lavoro consiste nel mettere in evidenza, nella filosofia
pit recente, un tema ricorrente che ne costituisce anche il proble-
ma centrale ancora aperto (quello appunto della contrapposizione
individuata dal titolo) oltre che nel mostrare le linee di continuita
e gli elementi di affinita teorica che legano, in alcuni aspetti e mo-
menti, le ragioni rispettive dei due stili filosofici.
La legittimita e la fecondita euristica della dicotomia scelta co-
me filo conduttore da Franca D’Agostini si dispiega con evidenza
quando si provi a esplicitare le tante dicotomie analoghe che, nel
corso dell’esplorazione delle varie tematiche, opere ¢ autori, essa
richiama spontaneamente. La prima a cui pensiamo, prima non
necessariamente in ordine di importanza né in alcun senso crono-
logico, é quella tra una linea kantiana e una linea hegeliana nel
pensiero contemporaneo; vi ha alluso Richard Rorty in un suo
scritto, e sebbene la distinzione non coincida completamente con
quella tra analitici e continentali, ma abbia con essa (come del re-
sto le altre distinzioni evocate nel libro) solo una rassomiglianza di
famiglia, si pud a buon diritto pensare che indichi un aspetto filo-
soficamente essenziale in quella prima coppia di concetti. La linea
kantiana, interessata principalmente a cogliere le condizioni tra-
XII
PREFAZIONE
scendentali di possibilita della conoscenza e in genere della razio-
nalita, anche pratica, si incarna oggi in tutte le filosofie che con-
centrano la loro attenzione sulla logica, ’epistemologia, le forme
del sapere scientifico o anche dell’agire etico con l’intento di indi-
viduarne i tratti universali e stabili. Chiamiamo invece linea hege-
liana, secondo la proposta di Rorty, quella tendenza che si riscon-
tra nelle filosofie che guardano principalmente alla concretezza
storica delle forme di vita, dei linguaggi, dei paradigmi scientifici,
e che dunque anche pongono al centro dell’attenzione il problema
della storicita dei saperi e della stessa filosofia, fino agli esiti estre-
mi del relativismo 0, all’opposto, all’ascolto di una storia-destino
dell’essere, come é il caso di Heidegger e dei suoi discepoli. Gia il
semplice fatto di porre accanto alla dicotomia analitici-continenta-
li quest’altra, analoga ma non identica, tra linee kantiana e hegelia-
na, suscita una quantita di problemi e suggerisce ampi rimescola-
menti di carte: risulta per esempio evidente che non tutta la filoso-
fia continentale é sulla linea hegeliana, mentre non pochi filosofi di
formazione analitica, proprio attraverso la via del relativismo o, da
ultimo, di una qualche forma di comunitarismo, sfuggono all’im-
postazione prevalentemente kantiana della tradizione logico-epi-
stemologica anglosassone. Ma questi scivolamenti e rimescolamenti
del panorama, non che inficiare la validita dello schema di parten-
za, mostrano quella che ho chiamato la sua fecondita euristica: fat-
ta reagire con Ja distinzione tra kantiani e hegeliani, la dicotomia
analitici-continentali si anima e da luogo a ulteriori articolazioni,
lascia vedere pit specifiche differenze, indica pit varie e molteplici
possibilita di soluzione dei problemi.
Un altro modo di formulare I’antitesi pud essere quello che adot-
ta, e adatta liberamente, un’espressione dell’ultimo Foucault! che
contrappone alla filosofia come “analitica della verita” una filosofia
intesa come “ontologia dell’attualita”, preferendo esplicitamente la
seconda. Sebbene Foucault non elabori il significato del termine
ontologia, la dicotomia che cosi, anche al di Ja delle sue intenzioni
esplicite,.si delinea, apre nuove possibili distinzioni e articolazioni
nello schema, e non solo per quanto riguarda la compattezza del
cété continentale: se si tratta di parlare ancora dell’essere, la linea
continentale si scinde piuttosto nettamente tra coloro che, pit fe-
deli alle intenzioni di Heidegger, ritengono che comunque dell’es-
sere si debba ancora cercare di parlare, e coloro che, come Derrida,
pensano che cosi si rimarrebbe prigionieri di una prospettiva meta-
fisica. Ma la messa da parte del problema dell’essere come proble-
XII
PREFAZIONE
ma necessariamente metafisico avvicina anche sensibilmente Derri-
da a certe posizioni anti-metafisiche di origine analitica, per esem-
pio a Rorty, stabilendo dunque un altro possibile ponte tra filosofi
analitici e filosofi continentali. Paradossalmente ma non tanto, la
maggiore o minore disponibilita a parlare ancora dell’essere e a fa-
re dell’ontologia finisce per stabilire anche un’ulteriore divisione
tra diversi stili di scrittura filosofica, che non rispetta quella (gene-
ralmente accettata, e anche sostanzialmente valida) tra uno stile pit
argomentativo e definitorio proprio degli analitici e uno stile pit
suggestivo, narrativo o addirittura poetico, dei continentali. Quan-
to pid si cerca di fare una ontologia, tanto meno ci si pud permette-
re di lasciar da parte l’argomentazione (cid anche contro gli esempi
della meditazione ontologica del tardo Heidegger); dal che discen-
de che certi testi continentali esplicitamente impegnati sul terreno
dell’ontologia sono stilisticamente affini a scritti di autori di prove-
nienza analitica molto pit che ai testi classici del decostruzionismo.
Alla fine, ma é un tema che, per molte buone ragioni, appare
solo marginalmente nel lavoro di Franca D’ Agostini, la dicotomia
analitici-continentali, passando attraverso quelle tra linea kantiana
e linea hegeliana, tra analitica della verita e ontologia dell’attualita,
tra argomentazione e narrazione, finisce per condurre, mediante
un ulteriore scivolamento, a quella che si pud caratterizzare con i
nomi delle due grandi tradizioni religiose che hanno improntato
l’Occidente moderno, ebraismo e cristianesimo. Ancora una volta,
del tutto giustamente data l'importanza decisiva del pensatore, il
discorso ruota qui intorno a Jacques Derrida, ma anche intorno al
nome di quello che é stato forse il suo vero maestro, Emmanuel
Lévinas. Fino a che punto Lévinas e Derrida si possono collocare
entro la filosofia continentale quando questa sia caratterizzata spe-
cificamente come hegeliana piuttosto che kantiana, come ontolo-
gia dell’attualita piuttosto che come analitica della verita ecc.? Se
si guarda al tema della storicita, é facile scoprire che la storicita di
cui si pud parlare per Derrida e Lévinas equivale puramente e
semplicemente alla finitezza. Per entrambi, storicita dell’esistenza’
significa che siamo “sempre” gettati in una condizione finita, spe-
cifica ecc. Ma cid che importa alla filosofia, qui, é il “sempre”, e
non i tratti determinati della concreta situazione. Non sembra ar-
bitrario chiamare ebraico questo modo di considerare la storicita,
almeno nel senso che l’attesa di colui (0 di cid) che ha da venire —
che pure é una componente essenziale di molti scritti, soprattutto
XIV
PREFAZIONE
recenti, di Derrida — non @ confortata da nessun evento storico
specifico gia accaduto che articoli e dia un senso definito a tempi
ed epoche. E possibile pensare autenticamente la temporalita e la
storicita fuori dalla prospettiva della parusia come ritorno di un
messia gia venuto e dunque riconoscibile anche nell’articolazione
di momenti effettivamente diversi di una storia della salvezza (ma
anche in una storia dell’essere)?? Un altro segno della fecondita
della dicotomia da cui questo libro muove potrebbe essere pro-
prio la sua capacita di condurre, attraverso vie che permettono di
riarticolare in modi molteplici il panorama della filosofia odierna,
all’estremo del ritrovamento della problematica relazione tra que-
sta filosofia e la tradizione religiosa dell’Occidente. Che questa tra-
dizione si presenti sotto forma di una alternativa, tra ebraismo e
cristianesimo, che perd implica — nasconde, richiama, afferma —
una profonda, decisiva continuita (si pensi, tra gli autori di cui qui
si parla, a Franz Rosenzweig), potrebbe a buon diritto essere preso
come un segno del fatto che, anche nel caso del problematico rap-
porto tra filosofia analitica e filosofia continentale, o tra “verita” e
“attualita”, tra struttura ed evento, cid che sta davanti alla filosofia
come suo compito é, dopo la decostruzione, un lavoro di ricucitu-
ra e di ricomposizione.
NOTE
1. Vedi M. Foucault, “Che cos’é l’illuminismo? Che cos’é la rivoluzione?”,
1984, tr. it. di G, Marramao, in I/ Centauro, 11-12, maggio-dicembre 1984.
2. Si pensi qui all’importanza che ha l’attesa della parusia nel corso di le-
zioni heideggeriane sulla Phenomenologie der Religion (1920-21) ora nel vol.
60, Il sez., della Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a.M. 1995, nel quale,
con un serrato commento alle due lettere di Paolo ai Tessalonicesi, Heidegger
raggiunge una prima definizione della nozione di temporalita autentica che svi-
luppera in Essere e tempo.
A mio padre
in memoria