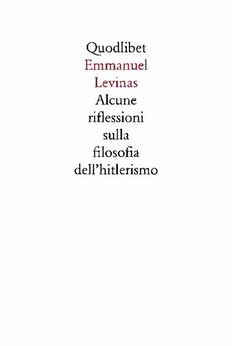Table Of ContentQuodlibet
Emmanuel
Levinas
Alcune
riflessioni
sulla
filosofia
dell’hitlerismo
Titoli originali:
Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme
© Michaël Levinas
Traduzione di Andrea Cavalletti
Le Mal élémental
© Miguel Abensour
Traduzione di Stefano Chiodi
© 1996 Quodlibet
Via Padre Matteo Ricci, 108 - 62100 Macerata
Introduzione
Il testo di Lévinas che qui presentiamo è forse l'unico tenta
tivo riuscito della filosofia del novecento di fare i conti con
l'evento politico decisivo del secolo: il nazismo. A dire il vero,
altri tentativi c'erano stati, a cominciare da quello che nel
1933 porta Heidegger all'esperienza del Rettorato — ma essi
si erano saldati con un disastro senza attenuanti. Proprio
perché il nazismo era un evento decisivo, esso — esattamen
te come lo stalinismo — non era qualcosa che ci si potesse
illudere di orientare a proprio piacere verso quella o questa
sponda. Levinas si rende subito conto della novità dell'hitle-
rismo rispetto alla tradizione filosofico-politica dell'Occi
dente. Mentre il pensiero giudaico-cristiano e quello libera-
le — egli argomenta lucidamente — tendono alla liberazio
ne dello spirito dai vincoli della situazione sensibile e stori
co-sociale cui l'uomo si trova di volta in volta consegnato,
distinguendo un regno eterno della ragione da quello del
corpo, la filosofia hitleriana si fonda invece su un'assunzio
ne senza riserve della situazione storica e materiale, consi
derata come una coesione inscindibile di spirito e corpo, ere
dità naturale e eredità culturale. Ma ciò che rende la dia
gnosi di Levinàs propriamente incomparabile è il coraggio
con cui egli riconosce all'opera nella filosofia dell'hitlerismo
le stesse Categorie che sono o saranno in quegli anni al cen
tro del suo cantiere filosofico (e, implicitamente, anche di
quello del suo maestro di Friburgo).
Si prenda il bellissimo saggio del 1933 De l’évasion. Qui
Levinas analizza alcune esperienze immediate apparente-
7
Introduzione
mente marginaii, il bisogno corporeo, la nausea, la vergogna,
per farne invece il luogo privilegiato di quella che egli chia
ma “l’esperienza dell’essere allo stato puro”, dell’essere nel
suo aspetto “desertico, ossessivo e orrendo”: il semplice fatto
che qualcosa esista senza scampo, irreparabilmente. La nau
sea (secondo un paradigma che è verosimilmente all’origine
delle celebri descrizioni sartriane, di qualche anno successi
ve) è, in questo senso, “la presenza rivoltante di noi stessi a
noi stessi”, presenza tanto assoluta e incondizionata, quan
to brutale e intollerabile. Essa è “l’impossibilità di essere dò
che si è” — ma, nello stesso tempo, d consegna a noi stessi e
c’inchioda alla nostra soffocante presenza, al puro fatto del
la nostra esistenza. In modo analogo, nella vergogna e nel
la nudità noi facciamo l’esperienza di non poter nascondere
ciò che vorremmo celare: “ciò che appare nella vergogna è
pressamente il fatto di essere inchiodati a noi stessi... la pre
senza irremissibile di me a me... È la nostra intimità, la
nostra presenza a noi stessi che ci fa vergogna”1.
La categoria che orienta qui l’analisi levinasiana è quel
la dell’essere consegnati senza scampo a se stessi o a una
situazione, o, come Levinas dice, dell’ètre rivé (letteralmen
te: essere inchiodati o appiattiti su qualcosa; river indica il
gesto di ribattere un chiodo per conficcarlo completamente
nel legno). Ora questo vero e proprio terminus technicus
della prima officina levinasiana compare significativamente
nel testo sull’hitlerismo per definire la novità del rapporto
dell’uomo nazista con la sua corporeità. “Una concezione
veramente opposta alla nozione europea di uomo” scrive
Levinas “sarebbe possibile solo se la situazione a cui è inchio
dato (vìve) non si aggiungesse a lui, ma costituisse il fonda
mento stesso del suo essere. Esigenza paradossale che l’espe
rienza del nostro corpo sembra realizzare”2. Il corpo non è,
8
Introduzione
infatti, per il nazionalsocialismo, soltanto l’eterno straniero
della tradizione cristiana e liberale: "(esso) non ci è sola
mente più vicino o più familiare del resto del mondo, non
determina soltanto la nostra vita psicologica, il nostro amo
re e la nostra attività. Al di là di queste banali constatazio
ni, c’è il sentimento d’identità. Non ci affermiamo in questo
calore unico del nostro corpo ben prima che il pieno svilup
po dell’Io pretenda di distinguersene? E non resistono forse
ad ogni prova quei legami che, ben prima che si schiuda
l’intelligenza, il sangue ha stabilito? In una pericolosa
impresa sportiva, in un esercizio in cui i gesti richiedono una
perfezione quasi astratta a un soffio dalla morte, ogni dua
lismo tra l’io e il corpo deve scomparire. E nella situazione
senza uscita della sofferenza fisica, il malato non sperimen
ta forse l’inscindibile semplicità del proprio essere, quando si
rigira nel suo letto di dolore senza trovar pace?... il corpo non
è soltanto un accidente felice o infelice che ci mette in rap
porto col mondo implacabile della materia — la sua aderen
za all’Io vale di per se stessa. È un’aderenza alla quale non
si sfugge e che nessuna metafora potrebbe far confondere
con la presenza di un oggetto esteriore: è un’unione il cui tra
gico sapore di definitivo nulla potrebbe alterare... L’essenza
dell’uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incate
namelo. Essere veramente se stessi, non significa risollevarsi
al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà
dell’Io: ma, al contrario, prendere coscienza dell’incatena-
mento originale, ineluttabile, unico al nostro corpo; signifi
ca soprattutto accettare questo incatenamene... Incatenato
al suo corpo, l’uomo si vede rifiutare il potere di sfuggire a se
stesso. La verità, per lui, non è più la contemplazione di uno
spettacolo estraneo — essa consiste in un dramma di cui
l’uomo stesso è l’attore. È sotto il peso di tutta la sua esisten-
9
Introduzione
za — che comporta dei dati su cui non si può più tornare —
che l'uomo pronuncerà il suo sì o il suo no”3
La prossimità fra questo essere consegnato e quasi
“inchiodato” a un corpo e a una situazione fattizia determi
nata e le analisi della contemporanea fenomenologia del
novecento (comprese quelle che, come abbiamo visto, orien
teranno il pensiero del primo Levinas) è fin troppo eviden
te. Certo Levinas cerca nell'esperienza del fatto bruto e sen
za scampo dell3esistenza proprio qualcosa come una via di
fuga (“una situazione limite in cui Vinutilità di ogni azione
è precisamente Vindice dell'istante supremo in cui non resta
più che uscire”4), così come, in Heidegger; l'essere-gettato
non è un “Faktum compiuto”, ma contiene in sé in qualche
modo la possibilità stessa dell'apertura dell'Esserci. Ma,
come a Davos non era sfuggito a Rosenzweig e allo stesso
Levinas, la grande novità della fenomenologia heideggeria
na era proprio il suo prendere risolutamente radice nella
situazione fattizia, il suo essere, innanzitutto, una “erme
neutica della fatticità”. Del resto, ripubblicando nel 1990 su
“Criticai Inquiry” il testo sull'hitlerismo, Levinas vi aggiun
ge una postilla che non lascia dubbi quanto alla tesi che un
lettore attento avrebbe comunque potuto leggervi tra le
righe, e, cioè, che la possibilità del nazismo come “Male eie
mentale” era iscritta nella stessa filosofia occidentale, e, in
particolare, nell'ontologia heideggeriana (“nella stessa onto
logia dell'Essere che ha cura di essere — dell'essere dem in
seinem Sein um dieses Sein selbst geht”5).
La pointe del saggio del 1934 è nella radicalità di questa
diagnosi, che sarebbe vano cercare di esorcizzare con con
danne o apologie. Il testo non è tanto un atto di accusa,
quanto una rilevazione topografica che in ogni senso ci
riguarda. Se il nazismo ha potuto confinare, almeno nel suo
io
Introduzione
punto di partenza, con la grande filosofia del novecento,
sarebbe stolto credere di potersi sottrarre a buon mercato a
questo scomodo vicinato condannando un filosofo e assol
vendone un altro. Le domande che il saggio implicitamente
poneva continuano sessanta anni dopo a esigere una rispo
sta. Qual è il senso di questa prossimità? Siamo veramente
usciti da questo vicinato o dimoriamo ancora senza render
cene conto sui margini del nazismo?
Quando, nel 1994, vide la luce la raccolta postuma di
Hannah Arendt Essays in Understanding, si potè osservare
con sorpresa che il curatore aveva inserito tra gli altri artico
li e saggi un breve appunto che aveva il tono confidenziale di
una nota di diario o di un pettegolezzo. Nel testo, che porta
va la rubrica Heidegger the fox, la Arendt paragonava il suo
antico maestro a una volpe, una volpe, però, di una specie
molto particolare, che, volendo come tutte le volpi, costruirsi
un covo sicuro, aveva scelto come tana una trappola. Sotto
l'apparenza di un pettegolezzo, l'appunto contiene un'indi-
cazione preziosa sull'ontologia di Essere e tempo. Si è molto
parlato dell'aperto come categoria centrale del pensiero di
Heidegger; dimenticando, però, troppo spesso che la specifi
cità e la novità di questa apertura consistono precisamente nel
suo essere innanzitutto apertura a una chiusura e attraverso
una chiusura. L'Esserci è fin dall'inizio gettato senza scampo
nel suo Ci, rimesso a una tonalità emotiva e a una situazio
ne fattizia determinata che gli stanno davanti come un enig
ma impenetrabile, in modo tale che la sua apertura coincide
in ogni punto col suo essere consegnato a una caduta. “Nella
tonalità emotiva”, recita il par. 29 di Essere e tempo, “l'Esser
ci è sempre già aperto secondo una disposizione data come
ii
Introduzione
Vente al quale VEsserci è consegnato nel suo essere come
l'essere che esso, esistendo, ha da essere. Aperto non significa
qui riconosciuto come tale... Il puro fatto del “che c'è” si
mostra, ma il da dove e il verso dove restano nell'oscurità...
Questo carattere d'essere dell'Esserci, velato nella sua prove
nienza e nella sua destinazione, ma proprio per questo tanto
più in se stesso aperto senza veli, noi lo chiamiamo l'essere-
gettato (Geworfenheit,) di questo ente nel suo Ci... L'espres
sione essere consegnato sta a significare la fatticità dell'essere
consegnato... In quanto ente consegnato al suo essere, l'Esser
ci è sempre consegnato a questo in modo che esso deve esser
si sempre già trovato, trovato, però, in un trovarsi che non
scaturisce da un diretto cercare, ma da un fuggirsi. La tona
lità emotiva non apre nel modo di un vedere l'essere-getta
to, ma in un processo di conversione o di evasione... ”.
Tale è la costituzione fattizia di quella Lichtung che l'Esser-
ci apre e il cui nome è, dunque, davvero qualcosa come un
lucus a non lucendo6 sprofondato in ciò che lo apre, nascosto
in ciò che l'espone e oscurato dalla sua stessa luce, l'Esserci ha
innanzitutto da essere ciò a cui è già sempre rimesso e abban
donato, i suoi stessi modi di essere. L'ontologia heideggeriana
è, cioè, risolutamente manierista e non essenzialista; l'Esserci
non ha una natura propria e una vocazione precostituita, ma
è un essere assolutamente inessenziale, la cui essenza, essendo
gettata, giace (liegt) ora integralmente nell'esistenza, nelle sue
molteplici maniere (Weisen,) di essere.
È da questa struttura ontologica dell'Esserci che Levinas
muove per la sua interpretazione della filosofia dell'hitleri-
smo: come è stato opportunamente notato, l'être rivé (che
compare significativamente per la prima volta proprio nel
saggio del 1952 su Heidegger et l'ontologie,) non è, in questo
senso, altro che una ripresa e una radicalizzazione della
12
Introduzione
Geworfenheit. L'uomo del nazismo condivide, cioè, con l'Esser
ci l'assunzione incondizionata della fatticità, l'esperienza
di un essere senza essenza che ha da essere soltanto i suoi
modi di essere. Ciò significa, però, che la vicinanza tra il na
zismo e la filosofia del novecento consiste precisamente in ciò
che fa la novità e l'attualità di questa rispetto alla tradizio
ne politica dell'Occidente, con la sua chiara distinzione fra
essenza e esistenza, diritto e fatto, oicos e polis. La dimensio
ne che si apre a questo punto è esattamente il contrario di
quel che la Arendt ha costantemente inteso come spazio pub
blico e sfera politica. Si capisce, allora, perché l'aneddoto sul
la volpe che si è costruita come tana una trappola potesse for
se essere per lei così importante: esso non contiene soltanto
un'indicazione sull'ontologia di Heidegger; ma è anche una
parabola sullo spazio politico della modernità.
Ricordo che, nel 1966, mentre frequentavo a Le Thor il
seminario su Eraclito, chiesi a Heidegger se avesse letto
Kafka. Mi rispose che, del non molto che aveva letto, era
rimasto soprattutto impressionato dal racconto Der Bau, “La
tana". L'innominato animale (talpa, volpe o essere umano)
protagonista del racconto è ossessivamente occupato a co
struire una tana inespugnabile, che si rivela a poco a poco
essere, invece, una trappola senza uscita. Ma non è precisa-
mente quanto è avvenuto nello spazio politico degli stati-
nazione dell'Occidente? Le case (le “patrie") che questi han
no lavorato a costruire si sono rivelate essere, alla fine, per i
“popoli" che dovevano abitarvi, soltanto delle trappole mor
tali. (E Kafka è certamente l'autore che ha descritto nel
modo più lucido la fine dello spazio politico dell'Occidente e
l'assoluta indeterminazione che ne deriva tra spazio pubbli
co e spazio privato, “castello" e camera da letto, tribunale e
soffitta.)
13
Introduzione
Il testo di Levinas, con la sua diagnosi senza indulgenze,
può allora offrire l'occasione per prendere coscienza della
nostra imbarazzante prossimità col nazismo, non certo in
nome del revisionismo, ma, anzi, per affrontare una volta
per tutte questa prossimità. Se l'analitica dell'Esserci (come
avrebbe dovuto essere scontato, se ogni ontologia non può
che implicare una politica) definisce la situazione politica
dell'Occidente in cui ancora ci troviamo e se questa, per
alcuni tratti non marginali, coincide con quella da cui muo
ve il nazismo, in che modo possiamo sfuggire all'esito cata
strofico implicito in questa prossimità? Poiché dev'essere
ormai chiaro che i grandi stati totalitari del novecento rap
presentano a loro modo un tentativo di dare una risposta a
un problema che non ha cessato di essere attuale: come può
un essere inessenziale, che non ha altra vocazione e altra
consistenza che la sua stessa esistenza fattizia e che, pertan
to, ha da assumere e essere i suoi stessi modi di essere, darsi
un compito storico e costruire per sé una dimensione propria
e una "casa" che non siano una trappola? A partire dalla fine
della prima guerra mondiale è, infatti, evidente che, per gli
stati-nazione europei, non vi sono più compiti storici asse
gnabili. Si fraintende completamente la natura dei grandi
esperimenti totalitari del novecento se li si vede soltanto
come prosecuzioni degli ultimi grandi compiti degli stati-
nazione ottocenteschi: il nazionalismo e l'imperialismo. La
posta in gioco è, ora, tutt'altra e più estrema, poiché si tratta
di assumere come compito la stessa esistenza fattizia dei
popoli — cioè, in ultima analisi, la loro nuda vita. In questo,
i totalitarismi del nostro secolo costituiscono veramente
l'altra faccia dell'idea hegelo-kojèviana di una fine della sto
ria: l'uomo ha ormai raggiunto il suo telos storico e non resta
altro che la depoliticizzazione delle società umane attraver
14